I Palestinesi, un popolo di troppo – Intervista a Jeff Halper (prima parte)
Scritto da Lorenzo Galbiati
giovedì 17 settembre 2009
Jeff Halper, ebreo israeliano di origine statunitense (è nato nel Minnesota
nel 1946), è urbanista e antropologo, e insegna all’Università Ben Gurion
del Negev. In Israele ha fondato nel 1997 l’ICAHD, Israeli Committee Against
House Demolitions (www.icahd.org), associazione di persone che per vie
legali e con la disobbedienza civile si oppongono alla demolizione delle
case palestinesi, e che forniscono supporto economico e materiale per la
loro ricostruzione. Per questa attività, e per il suo attivismo pacifista,
Halper è stato arrestato dal governo israeliano una decina di volte, ed è
ora considerato uno dei più autorevoli attivisti israeliani per la pace e i
diritti civili. In questi giorni Halper è in Italia per un giro di
conferenze e per promuovere il suo libro Ostacoli alla pace (Edizioni “Una
città”). Il programma delle sue conferenze è consultabile su:
www.unacitta.it . Oltre alle sue attività accademiche e per l’ICAHD, Halper
scrive libri ed è un conferenziere internazionale. Nel 2006 è stato
candidato al Premio Nobel per la Pace dall’ American Friends Service
Committe. Nell’agosto del 2008 Halper ha partecipato alla spedizione per
Gaza del Free Gaza Movement: la spedizione era costituita da un gruppo
internazionale di attivisti dei diritti umani, tra i quali l’italiano
Vittorio Arrigoni, e ha raggiunto Gaza a bordo di un peschereccio partito da
Cipro, rompendo così per la prima volta l’embargo marittimo imposto da
Israele alla Striscia di Gaza.
Tu sei un cittadino dello “stato ebraico” di Israele, uno stato fortemente
voluto nel Novecento dal movimento sionista e ottenuto dopo 50 anni di
grande emigrazione degli ebrei europei nel 1948, sulla spinta della fine
della Seconda guerra mondiale e del terribile crimine della Shoah. Che cos’è
per te oggi, concretamente, il sionismo?
«Il sionismo fu un movimento nazionale che ebbe un senso in un determinato
tempo e luogo. Mentre i popoli d’Europa cercavano un’identità come nazioni
rivendicando i loro diritti all’autodeterminazione, allo stesso modo si
comportavano gli ebrei, considerati all’epoca dalle nazioni d’Europa stesse
un popolo separato. Tuttavia, due problemi trasformarono il sionismo in un
movimento coloniale che oggi non può più essere sostenuto. Innanzitutto, il
sionismo adottò una forma di nazionalismo tribale, influenzato dal
pan-slavismo russo e dal pan-germanismo del centro Europa, culture dominanti
nei territori dove la maggior parte degli ebrei vivevano in Europa,
rivendicando la terra d’Israele fra il Mediterraneo e il fiume Giordano come
fosse un diritto esclusivamente ebraico. Questo creò i presupposti per un
inevitabile conflitto con i popoli indigeni, quelli della comunità araba
palestinese, che ovviamente rivendicavano un proprio Paese dopo la partenza
dei britannici. Se il sionismo avesse riconosciuto l’esistenza di un altro
popolo nel territorio, “alloggiare” tutti in una sorta di stato bi-nazionale
sarebbe stato ancora possibile. Ma pretendere la proprietà esclusiva,
pretesa che anche oggi sussiste dai sionisti e da Israele, rende non
fattibile uno stato “ebraico”. Il secondo problema fu che il paese non era
disabitato. Una proprietà esclusiva del territorio avrebbe potuto funzionare
se fosse stato completamente privo di abitanti. Ma visto che la popolazione
palestinese esisteva ed era in effetti in maggioranza, cosa che sta
avvenendo anche oggi, una realtà bi-nazionale esisteva già allora e doveva
essere gestita come tale».
* * *
Molti anni fa tu ti sei trasferito dagli USA in Israele: è stata una scelta
dovuta a motivi contingenti, personali, o spinta da una motivazione
ideologica?
«Sono cresciuto negli Stati Uniti negli anni ’60. Sono sempre stato
coinvolto nelle attività politiche della sinistra (o perlomeno la nuova
sinistra): i movimenti per i diritti civili di Martin Luther King, il
movimento contro la guerra in Vietnam ecc. Dunque, dopo il 1967 sono
diventato critico dell’occupazione d’Israele (Israele non fu mai un
argomento politico di grande rilievo prima di quel momento). Ma gli anni ‘60
furono anche un periodo in cui molti di noi cittadini americani bianchi di
classe media rifiutavamo il materialismo americano e la conseguente
superficialità della sua cultura, cercando significati più profondi
attraverso la ricerca delle nostre radici etniche. Man mano che divenivo più
distaccato dalla cultura americana, la mia identità di ebreo diventò
centrale – ma in senso culturale e viscerale, non religioso. Ho viaggiato
attraverso Israele nel 1966, mentre ero in transito per andare ad effettuare
delle ricerche in Etiopia, e il paese mi “parlò”. Provai un senso di
appartenenza che risultò soddisfacente alla mia ricerca di un’identità, pur
restando conscio a livello politico dell’occupazione, a cui mi opponevo.
Quando mi sono trasferito in Israele nel 1973, mi sono immediatamente unito
ai movimenti pacifisti di sinistra. Le mie vedute negli anni sono cambiate
coi tempi e le circostanze. Ormai non sono più un sostenitore della
soluzione dei due stati, visto che non ritengo che Israele sia realizzabile
come stato “ebraico”, sostenendo al contrario la soluzione dello stato
bi-nazionale. Però credo ancora che gli ebrei abbiano legittimamente diritto
a un posto in Israele/Palestina, anche come entità nazionale. Non siamo
stranieri in questa terra e non accetto la nozione che il sionismo sia
semplicemente un movimento coloniale europeo (sebbene si sia effettivamente
comportato come tale)».
* * *
In Europa, e segnatamente in Italia, sta passando l’equazione antisionismo
uguale antisemitismo; infatti, il nostro presidente Napolitano durante la
Giornata della Memoria del 2007 ha detto che va combattuta ogni forma di
antisemitismo, anche quando si traveste da antisionismo, e qualche mese fa,
il presidente della Camera Fini ha detto in tivù, di fronte all’accondiscendente
presidente della comunità ebraica romana Riccardo Pacifici, che oggi l’antisionismo
è la nuova forma che ha assunto l’antisemitismo. Come spieghi questo
fenomeno? Che significato ha a livello politico internazionale?
«Questo è il risultato di una campagna martellante da parte del governo
israeliano per mettere a tacere qualsiasi critica contro Israele o le sue
politiche. Diversi anni fa, in una riunione di strategia tenutasi al
ministero degli affari esteri, un “nuovo antisemitismo” fu inventato, che
sfruttava in modo conscio e deliberato l’antisemitismo per fini di pubbliche
relazioni israeliane. Il “nuovo antisemitismo” affermava che ogni critica
mossa contro Israele era anche antisemita. Tutto ciò non è solo falso e
disonesto da un punto di vista politico, ma pericoloso per tutti gli ebrei
del mondo. L’antisemitismo è effettivamente un problema che andrebbe
combattuto assieme ad altre forme di razzismo. Definirlo solo in termini
israeliani lascia altri ebrei della diaspora senza protezione. E’ quindi
considerato accettabile essere antisemiti, vedi Fini e gli evangelisti
americani come Pat Robertson, ad esempio, purché si è “pro-Israele”. Loro lo
sono per vari motivi (principalmente perché Israele si è allineata con
elementi destrorsi e fascisti ovunque nel mondo). Ma se sei critico di
Israele come Paese, ed abbiamo tutti il diritto di esserlo, non sei
antisemita però vieni condannato e zittito secondo la dottrina del “nuovo
antisemitismo”. E’ conveniente per Israele ma pericoloso sia per gli ebrei
della diaspora che per chiunque si batta a favore dei diritti umani e contro
il razzismo».
* * *
In Israele hai fondato l’Icahd, l’Israeli Committee Against House
Demolitions, con il quale ti sei opposto, anche fisicamente, alla
demolizione di molte case palestinesi, finendo più volte in carcere per
questo. Come giudichi le politiche israeliane per l’assegnazione della terra
e per i permessi edilizi? Credi si possa parlare di apartheid?
«I governi israeliani più recenti hanno tentato di istituzionalizzare un
sistema di apartheid, basato su un “Bantustan” palestinese, prendendo a
modello ciò che fu creato nell’era dell’apartheid in Sud Africa. Quest’ultima
creò dieci territori non-autosufficienti, per la maggioranza abitati da
neri, ricoprenti solo l’11% del territorio nazionale, in modo da dare al Sud
Africa una manovalanza a buon mercato e contemporaneamente liberandola della
sua popolazione nera, rendendo quindi possibile il dominio europeo
“democratico”. Questo è esattamente ciò che intenderebbe fare Israele – il
proprio “Bantustan” palestinese comprenderebbe solo il 15% del territorio
della Palestina storica. In effetti, dai tempi di Barak come primo ministro,
Israele ha proprio adottato il linguaggio dell’apartheid. Quindi il termine
usato per definire la politica di Israele nei confronti dei palestinesi è
hafrada, che in ebraico significa “separazione”, esattamente come lo fu in
Afrikaans. Apartheid non è né uno slogan, né un sistema esclusivo del Sud
Africa. La parola, come viene usata qui, descrive esattamente un regime che
può aver avuto origine in Sud Africa, ma che può essere importato e adattato
alla situazione locale. Alla sua radice, l’apartheid può essere definita
avente due elementi: prima di tutto, una popolazione che viene separata
dalle altre (il nome ufficiale del muro è “Barriera di Separazione”), poi la
creazione di un regime che la domina definitivamente e istituzionalmente.
Separazione e dominio: esattamente la concezione di Barak, Sharon e
eventualmente, Olmert e Livni, per rinchiudere i palestinesi in cantoni
poveri e non autosufficienti. La versione israeliana dell’apartheid è
tuttavia persino peggiore di quella sudafricana. In Sud Africa i Bantustans
erano concepiti come riserve di manodopera nera a buon mercato in un’economia
sudafricana bianca. Nella versione israeliana i lavoratori palestinesi sono
persino esclusi dall’economia israeliana, e non hanno nemmeno un’economia
autosufficiente propria. Il motivo è che Israele ha scoperto una manodopera
a buon mercato tutta sua: all’incirca 300.000 lavoratori stranieri
provenienti da Cina, Filippine, Thailandia, Romania e Africa occidentale, la
pre-esistente popolazione araba in Israele, Mizrahi, etiope, russa e est
europea. Israele può quindi permettersi di rinchiuderli là dentro persino
mentre gli vengono negate una propria economia e legami liberi con i paesi
arabi circostanti. Da ogni punto di vista, storicamente, culturalmente,
politicamente ed economicamente, i palestinesi sono stati definiti un’umanità
di troppo, superflua. Non gli resta che fare da popolazione di “stoccaggio”,
condizione che la preoccupata comunità internazionale sembra continuare a
permettere a Israele di attuare. Tutto ciò porta oltre l’apartheid, a quello
che può essere definito lo “stoccaggio” dei palestinesi, una della
popolazioni mondiali “di troppo”, assieme ai poveri del mondo intero, i
detenuti, gli immigrati clandestini, i dissidenti politici e milioni di
altri emarginati. “Stoccaggio” rappresenta il migliore, e anche il più
triste dei termini per definire ciò che Israele sta creando per i
palestinesi nei territori occupati. Siccome lo “stoccaggio” è un fenomeno
globale e Israele è stato pioniere nel creare un modello di questo metodo,
ciò che sta accadendo ai palestinesi dovrebbe essere affare di tutti.
Potrebbe costituire una forma di crimine contro l’umanità completamente
nuovo, e come tale essere soggetto a una giurisdizione universale delle
corti del mondo come qualsiasi altra palese violazione dei diritti umani. In
questo senso l’“occupazione” di Israele ha implicazioni che vanno ben oltre
un conflitto locale fra due popoli. Se Israele può confezionare e esportare
la sua articolata “matrice di controllo”, un sistema di repressione
permanente che unisce una amministrazione kafkiana, leggi e pianificazioni
con forme di controllo palesemente coercitive contro una precisa popolazione
mantenuta entro i limiti di comunità murate con metodi ostili (insediamenti
in questo caso), mura e ostacoli di vario tipo contro qualsiasi libero
spostamento, allora, in questo caso, come scrive lucidamente Naomi Klein nel
suo libro The Shock Doctrine, altri paesi guarderanno ad Israele/Palestina
osservando che : “Un lato sembra Israele; l’altro lato sembra Gaza”. In
altre parole, una Palestina Globale».
* * *
Ti abbiamo visto in alcuni filmati descrivere la situazione di Gerusalemme
est, spiegare quante e quali case palestinesi sono state distrutte: che cosa
sta succedendo a Gerusalemme est? Si può parlare di pulizia etnica per
Gerusalemme est, come fa Ilan Pappé?
«Concordo con Pappé nell’affermare che la pulizia etnica non stia avvenendo
solo nella Gerusalemme est, ma anche nel resto dei territori occupati e in
tutto Israele stesso. L’anno scorso il governo israeliano ha distrutto tre
volte più case dentro Israele – appartenenti a cittadini israeliani che
naturalmente, erano tutti palestinesi o beduini – rispetto al numero che ha
distrutto nei territori occupati. L’ICAHD ha come scopo quello di resistere
all’occupazione opponendosi alla politica di Israele di demolire le case dei
palestinesi. Dal 1967 Israele ha distrutto più di 24 000 case palestinesi –
praticamente tutte senza motivo o giustificazioni legate alla “sicurezza”,
oltre ad aver dato decine di migliaia di ordini di demolizione, che possono
essere messi in atto in qualsiasi momento».
* * *
Israele negli ultimi 4 anni ha sostenuto due guerre di invasione
sanguinarie, quelle contro il Libano e la Striscia di Gaza. Ha ricevuto da
molte parti accuse di crimini di guerra, sia per il tipo di armi che ha
usato sia per la volontà deliberata di colpire la popolazione e le strutture
civili, impedendo in molti casi i soccorsi medici. Come spieghi l’apparente
consenso di una grande maggioranza di cittadini israeliani nei confronti di
queste guerre? Come spieghi l’adesione a queste soluzioni politiche da parte
di intellettuali considerati “pacifisti” come Grossmann e Oz?
«In Israele, la popolazione ebraica è ben poco interessata sia all’occupazione
che al più universale principio della pace. Sono entrambi non-argomenti in
Israele (non credo che siano stati menzionati una sola volta durante la
passata campagna elettorale). Gli ebrei israeliani stanno attualmente
vivendo una vita piacevole e sicura, e Barak e gli altri leader sono
riusciti a convincere la gente che non esiste soluzione politica, che agli
arabi non interessa la pace (siamo bravissimi a dare la colpa ad altri per
evitare le nostre responsabilità di grande potenza colonizzatrice degli
ultimi 42 anni!). Finché tutto sarà tranquillo e l’economia andrà bene,
nessuno vuole sapere nulla degli “arabi”. Credo che dobbiamo rinunciare a
sperare di vedere il pubblico israeliano come elemento attivo del
cambiamento verso la pace. La maggior parte degli israeliani non si
intrometterebbero in una soluzione imposta se la comunità internazionale
dovesse insistere nell’imporne una, ma non farebbero alcun passo
significativo da soli in quella direzione. Alla stessa maniera dei bianchi
in Sud Africa, che accettarono e in alcuni casi dettero il benvenuto alla
fine dell’apartheid, e che al tempo stesso non sarebbero mai insorti contro
di essa. Invece per quel che riguarda gli “intellettuali”, anche loro non
vedono. E’ la dimostrazione che si può essere estremamente sensibili,
intelligenti, ricettivi come Amos Oz e alcuni dei nostri professori, che
tuttavia rimangono al sicuro nella loro “nicchia”».
* * *
Tu da qualche anno sostieni che non è più praticabile sul campo la soluzione
due nazioni due stati, poichè Israele ha ormai occupato con il Muro, le
colonie e le strade gran parte della West Bank. Sostieni quindi la soluzione
di uno stato laico binazionale. Oggi, dopo la carneficina di Gaza, e dopo le
elezioni israeliane, è ancora immaginabile questa soluzione?
«Noi dell’ICAHD crediamo che la soluzione dei due stati sia irrealizzabile –
a meno che si accetti una soluzione da apartheid, un mini-stato palestinese
sovrano solo a metà sul 15% del territorio palestinese storico, spezzettato
in ciò che Sharon chiama quattro o cinque “cantoni”. Non li vediamo né come
fattibili né giusti o pratici, sebbene Israele li veda come una soluzione e
stia spingendo in questa direzione al processo di Annapolis. Per noi la
questione non è solo di creare uno stato palestinese, ma uno stato
autosufficiente. Non solo questo minuscolo stato palestinese dovrà
sopportare il ritorno dei rifugiati, ma un 60% di palestinesi sotto l’età di
18. Se emerge uno stato che non ha alcuna possibilità di offrire un futuro
ai suoi giovani, una economia autosufficiente che può svilupparsi, rimane
semplicemente uno stato-prigione, un super-Bantustan. Credo che se non si
materializzerà la soluzione dei due stati, e la soluzione per uno stato
bi-nazionale (che io preferisco) verrà effettivamente impedita da Israele e
la comunità internazionale, allora preferirei una confederazione economica
medio orientale che comprenda Israele, Palestina, Giordania, Siria e Libano,
nella quale tutti i residenti della confederazione abbiano la libertà di
vivere e lavorare all’interno della stessa. Israele/Palestina è
semplicemente un territorio troppo piccolo per poterci infilare tutte le
soluzioni necessarie – la sicurezza, lo sviluppo economico, l’acqua, i
rifugiati. E alla fine, quanto sarà grande lo stato palestinese sarà
importante solo se verrà concepito come un’entità indipendente,
economicamente autonoma. Se ai palestinesi sarà concessa la sovranità anche
solo di un piccolo stato, più ristretto rispetto ai confini del ‘67, ma
comunque avente l’intera confederazione per sviluppare la propria autonomia
economica, credo che questo potrebbe rivelarsi lo scenario migliore. Ma
questa è una proposta ambiziosa e campata in aria per il momento, e resta
finora senza sostenitori (sebbene Sarkozy stia anche pensando in termini
regionali). Quando si vedrà che la soluzione dei due stati è fallita, credo
che allora la gente inizierà a cercare una nuova soluzione. E credo proprio
che allora l’idea della confederazione risulterà sensata».
* * *
Credi che esistano forze politiche parlamentari, in Israele, in grado di
sostenere un accordo autentico con i Palestinesi, in vista di una pace e
della creazione di uno stato palestinese?
«L’unico ostacolo a un’autentica soluzione dei due stati (cioè uno stato
palestinese disteso su tutti i territori occupati, con pochissime modifiche
agli attuali confini) è nella volontà di Israele di permettere che avvenga.
Giudicando dai fatti che si vedono sul terreno, la costruzione di nuovi
insediamenti in particolare, nessun governo israeliano, né di destra né
tanto meno di sinistra o centro, ha mai veramente considerato la soluzione
dello stato palestinese come fattibile. Per rendere le cose ancora più
difficili, se un simile governo dovesse mai emergere (e non ve n’è uno in
vista), non avrebbe alcun mandato, alcuna autorità per evacuare gli
insediamenti e “rinunciare” ai Territori Occupati Palestinesi considerato l’estrema
frammentazione del sistema politico israeliano. Semplicemente, fra i partiti
politici non vi è alcuna unità d’intenti per concordare veramente una
soluzione di pace e di due stati. Ecco perché, se la comunità internazionale
dovesse forzare Israele a ritirarsi per una vera pace, il pubblico
israeliano la sosterrebbe. Israele non è destrorso quanto la gente immagina.
Ho quindi una formula per la pace: Obama, l’ONU o la comunità internazionale
dovranno dire a Israele: 1) Vi amiamo (gli israeliani se lo devono sentir
dire); 2) Garantiremo la vostra sicurezza (QUESTA è la preoccupazione
maggiore del pubblico israeliano); 3) ora che è finita l’occupazione, sarete
fuori da ogni centimetro cubo dei Territori Occupati Palestinesi entro i
prossimi 2-3-4 anni (e noi, la comunità internazionale, pagheremo per il
dislocamento). Credo che ci sarebbe gente a ballare per le strade di Tel
Aviv se tutto ciò avvenisse. Questo è esattamente ciò che vorrebbero gli
israeliani, ma non possono sperarci, visto il nostro sistema politico. E’
altamente improbabile che ciò avvenga».
* * *
Che giudizio dai all’azione politica dei dirigenti palestinesi di Fatah ed
Hamas dalla morte di Arafat a tutt’oggi?
«Ovviamente l’andamento della leadership palestinese è altamente
problematico. Dobbiamo ricordare, tuttavia, che negli ultimi 40 anni Israele
ha sostenuto una sistematica campagna di omicidi, esili e incarcerazioni dei
capi di governo palestinesi, quindi la leadership attuale è mutilata (si
potrebbe essere ingenerosi e, alla luce delle campagne condotte dall’autorità
palestinese contro la sua stessa gente, affermare che l’attuale leadership
di Fatah sia ancora viva e funzionante perché Israele sa bene chi deve
eliminare e chi risparmiare). Una delle mie maggiori critiche rivolte all’attuale
leadership di Fatah riguarda la sua inefficacia nel veicolare la causa
palestinese all’estero. Nonostante un cambiamento dell’opinione pubblica
ormai più a favore dei palestinesi, soprattutto dopo l’invasione di Gaza, la
leadership non ha saputo sfruttare il momento propizio per inviare i propri
portavoce presso le popolazioni ed i governi del mondo (in effetti, nell’ultimo
anno, incluso il cruciale periodo della transizione verso l’amministrazione
Obama, non vi è stato un solo rappresentante palestinese a Washington – e i
rappresentanti palestinesi all’estero, con qualche rara eccezione, sono
generalmente inefficaci). Al contrario di Israele, pare che la leadership
palestinese si sia quasi ritirata dal gioco politico. In questo vuoto
lasciato da Fatah, Hamas è giunto sulla scena come il “salvatore”, la
forza/partito/leadership che resisterà ad Israele, resisterà alla
“soluzione” dell’apartheid, manterrà l’integrità palestinese e combatterà
la corruzione. Mentre la sua ideologia religiosa ed il suo programma
dovrebbero essere considerati inaccettabili per qualsiasi persona
minimamente progressista, si dovrebbe perlomeno ammirare la resistenza di
Hamas e ammettere che stia effettivamente controbilanciando ciò che è stata
percepita come la collaborazione di Fatah con Israele».
* * *
Credi che se la classe politica palestinese usasse dei metodi di lotta
nonviolenta, quali il digiuno pubblico, e se convincesse la popolazione
palestinese israeliana o che lavora in Israele a forme di sciopero
generalizzato potrebbe ottenere dei risultati concreti?
«I metodi non-violenti sarebbero potuti essere efficaci. Se la leadership
palestinese fosse più portata alla strategia, potrebbe usare a proprio
vantaggio metodi non-violenti, come il movimento BDS (Boicottaggio –
Disinvestimento - Sanzioni) e altre campagne analoghe con gruppi di
pressione efficaci. Ma non lo fanno».
_______________________
(traduzione di Daniela Filippin)
_______________________
http://www.nazioneindiana.com/
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
































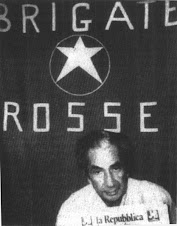























































































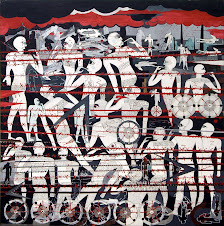






























































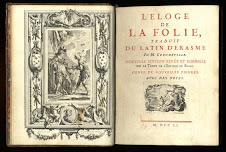



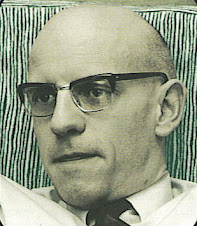














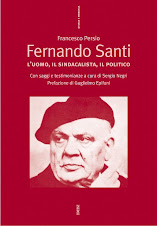





























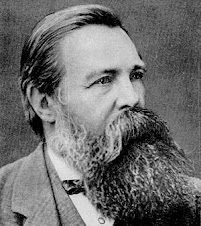













































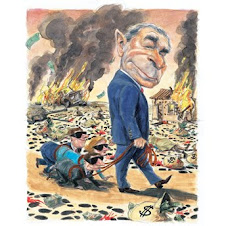

















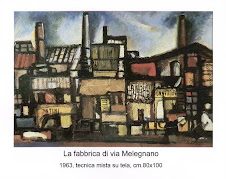














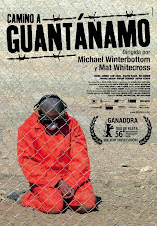





















































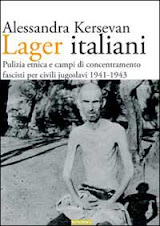



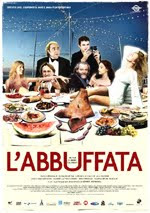















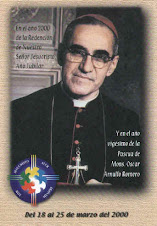










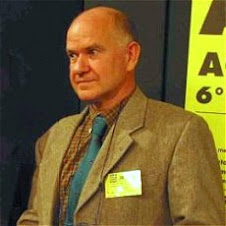




































































.jpg)
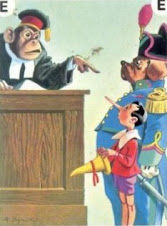







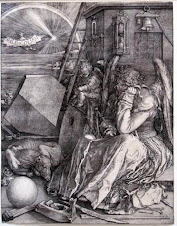


















.jpg)











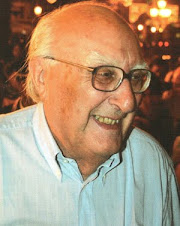









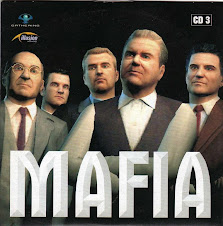















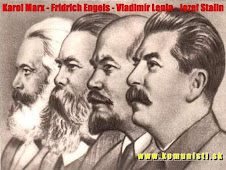



















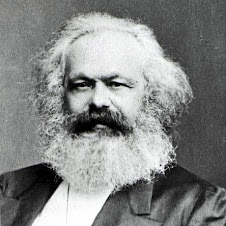























































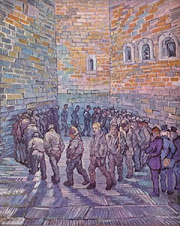
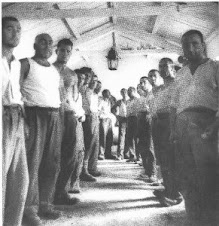




























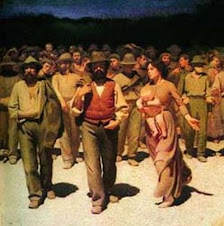













































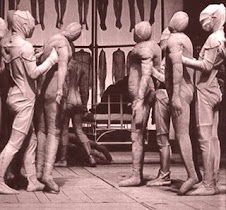


































































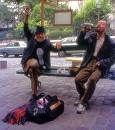



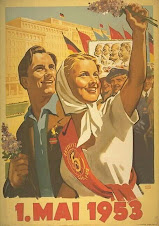
















































































































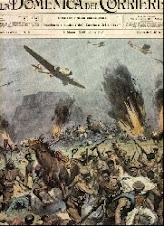






















































.jpg)















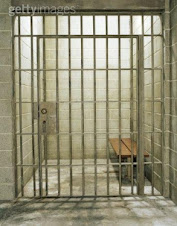







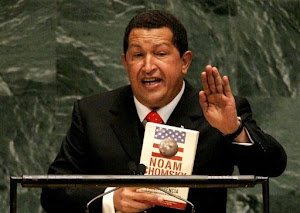







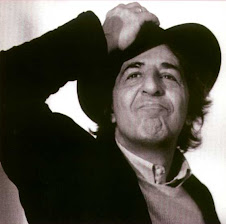










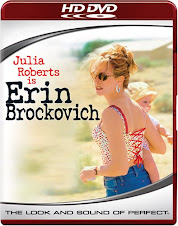






























Nessun commento:
Posta un commento