Bentornata Bandiera Rossa!
Sito COMUNISTA DESTALINIZZATO, aperto a chiunque abbia posizioni anticapitaliste. Accettiamo testi, poesie e racconti possibilmente di qualità. Cercateci anche su FACEBOOK nel GRUPPO omonimo. Siamo un po’ poveri di capacità informatiche. Ci piacerebbe passare dal BLOG a un SITO vero e proprio. Perciò, se c’è qualcuno che se la sente, saremo felici di affidargli la trasformazione del blog in sito vero e proprio.
Cerca nel blog
powered by
Blog Bandiera Rossa
RIFARE LA CGIL NEL NOME DEI SOLITI BUROCRATI di L. Mortara
di LORENZO MORTARA
In un articolo di Pietro Ancona, Rifare la Cgil da un’altra parte, gli iscritti sono invitati a lasciarla per l’ennesimo sindacato di base e soprattutto per ridare vita, sotto nuova formula, alla Cgil di Di Vittorio.
La penna di Pietro Ancona, sindacalista in pensione, è ottima e sarebbe perfetta se solo si inchiostrasse nel marxismo. Purtroppo il suo calamaio attinge alla Costituzione e al socialismo parlamentare, il quale altro non è che la copertura politica per il capitalismo extraparlamentare.
Dopo averci ricordato tutte le malefatte della maggioranza della Cgil, dal sostegno all’intervento imperialista in Libia alla legge Biagi, all’opposizione in Fiom e allo smantellamento delle pensioni, Pietro Ancona, da petulante riformista qual in fondo è, propone come ricetta per il “male incurabile” del nostro sindacato, il ritorno all’età dell’oro di Di Vittorio, ovvero all’epoca immaginaria di «una linea di coerente difesa dei lavoratori».
Non c’è niente da fare, o abbattiamo gli idealisti di tutte le razze e le provenienze, o non ci risolleveremo mai. Chi è per Di Vittorio, non può essere contro la Camusso. Nella democrazia progressiva è già contenuto in nuce il Partito Democratico. Il processo che porta da Berlinguer a D’Alema è solo la tappa dello stesso identico percorso che va da Togliatti, passando per Di Vittorio, fino all’attuale riduzione degli ex-PCI a personale politico della borghesia. Non c’è soluzione di continuità. I salti, anche bruschi, da una svolta all’altra, sono solo accelerazioni nella stessa direzione. Imboccata la strada della controrivoluzione permanente, il destino era segnato in partenza.
La coerenza di Di Vittorio, data per scontata da Pietro Ancona, è messa in contrapposizione ai vertici attuali della Cgil e a quel D’Aragona che strisciò come un verme ai piedi del fascismo. Di Vittorio è un mito per Pietro Ancona, e quindi è mitica la Cgil sua e del compare socialista Bruno Buozzi. Infatti, la realtà storica, è affatto diversa e non lascia scampo alle illusioni del sindacalista in pensione.
Elogiare Buozzi che ricostruisce da un’altra parte la Cgil consegnata al fascismo da D’aragona, si può fare solo a patto di ricordare quanta responsabilità abbia avuto questa nullità a forma di socialista nell’avvento del regime mussoliniano. Nel biennio rosso, quando la Cgil si spacca a un passo dalla rivoluzione, Buozzi, come tutti gli ipocriti pieni di ambizioni sbagliate, non si schierò né con la mozione a favore della socializzazione dei mezzi di produzione, firmata da Schiavello e da Bucco, né con quella di D’aragona firmata da tutti quelli che se la facevano nei calzoni. Buozzi, anima bella del sindacato italiano, per darsi chissà quali arie, sostenne una terza via, la via dell’ipocrisia più sfacciata. A nome del direttivo Fiom sostenne il programma di «attuare tutte le riforme politiche ed economiche più insistentemente reclamate dal proletariato socialista e compatibili con le condizioni del Paese»1. Gli è in primo luogo che la compatibilità con le condizioni del Paese, è la compatibilità dell’operaio subordinata alle esigenze del Capitale, e in secondo luogo che un movimento rivoluzionario è tale proprio perché tutte le istanze del proletariato sono entrate in rotta di collisione con le compatibilità del sistema capitalistico di sfruttamento. Buozzi che non era uno stupido, in fondo sapeva benissimo queste cose, è per questo che subito dopo aver programmato la capitolazione degli operai, da buon piccolo borghese, si astenne. E si sa che in un momento rivoluzionario, chi si astiene, vota contro.
D’Aragona dal canto suo, in quei giorni, dal Direttivo della Confederazione diramava comunicati edificanti come questo: «un movimento insurrezionale in Italia avrebbe dato modo alla borghesia di scatenare una violenta e sanguinosa reazione che avrebbe diminuito le nostre forze ed impedito il successivo svolgersi dell’azione politico-sindacale socialista»2. Buozzi gli strizzava l’occhio accusando i rivoluzionari di giustificare con la loro mozione «la più immediata e spietata delle reazioni». Come si vede, i due compari, non sono poi così diversi, uguali essendo, in tutte le occasioni rivoluzionarie, gli opportunisti vigliacchi di tutte le sfumature.
Gli opportunisti sono così, scaricano sempre su qualcuno la loro impotenza. Sono incapaci di assumersi la responsabilità di quel che (non) fanno. I socialisti tedeschi, qualche anno prima, non avevano votato i crediti di guerra con la scusa che anche negli altri paesi i socialisti facevano lo stesso? E così i loro corrispettivi italiani votarono contro la rivoluzione per non scatenare la controrivoluzione. Come se fosse possibile fare l’una senza sollevare anche l’altra. Fare la rivoluzione senza scatenare la reazione, significa pretendere di farla al di fuori della lotta di classe. E in effetti questo è il motto di chi in fondo si è schierato sul più bello dall’altra parte. Va però girato al contrario per comprenderne il pieno significato: non scateniamo la reazione altrimenti corriamo il rischio di dover fare la rivoluzione!
La realtà, ovviamente, s’incaricò di smentire questi due damerini del proletariato. La reazione ci fu lo stesso, più spietata del previsto. I socialisti furono estromessi dal Parlamento, i sindacati veri sciolti e il fascismo fu appunto il regalo che D’Aragona e Buozzi, dopo aver fatto fallire la rivoluzione, fecero agli operai.
Il povero Buozzi fu poi fucilato dai nazisti, poco prima della firma del Patto di Roma, con cui nel 1945 assieme a Di Vittorio e Grandi, alla caduta del fascismo, e cioè di Sua Maestà il Capitale, i tre burocrati riconsegnavano sottobanco, e per la seconda volta, il proletariato nelle mani dei padroni. Era dovere di ogni comunista difendere Buozzi dalle camicie brune, ma solo per avere il piacere di fucilarlo noi, sulla pubblica piazza, come nemico del popolo.
L’erede di D’Aragona, Di Vittorio, aveva già avuto modo di non distinguersi dagli altri, quando da buon socialista nazionale, e cioè sciovinista provinciale, s’era scoperto interventista nella Prima Guerra Mondiale, andando al fronte a servire le mire imperialistiche dei padroni italiani. Tornato in Patria, come ricompensa, i padroni lo fecero deputato nel 1921 dopo una breve parentesi carceraria che giunse come la manna dal cielo per gli operai, impegnati com’erano, poco prima, nel biennio rosso. Deputato a sbarre, Di Vittorio non poté fare gli stessi danni di Buozzi e D’Aragona. Per questo si rifece nel 1936, quando sulle orme del suo predecessore, firmò assieme a Togliatti e ad altri 61 stalinisti come lui, il famoso Appello ai fratelli in camicia nera. Fascisti e antifascisti dovevano unirsi contro il comune nemico del Capitale plutocratico (sic!). Fu con questo appello che chi ancora non aveva capito, non aveva più scuse, allora come ancor di più oggi, per capire che l’antifascismo antirivoluzionario e coglione di certa gente non era altro che un gioco di potere come quelli praticati dai borghesi.
Dopo una parentesi in Spagna, inviato per una breve battuta di caccia alla rivoluzione, col Tradimento di Salerno, insediato come un burattino dal burattinaio Togliatti, burattino di Stalin, alla guida della Cgil, Di Vittorio ebbe finalmente la grande occasione per dimostrare tutte le sue grandi qualità di burocrate stalinista.
La sua prima vera mossa fu il Patto di Roma, e cosa fu il Patto di Roma lo spiega l’unico partito onesto, ancorché inconcludente, della coalizione antifascista: il Partito d’Azione. Il Patto di Roma non fu per l’unità sindacale, ma per l’esatto contrario, visto che questa «deve attuarsi come espressione delle categorie lavoratrici e non come organo di un gruppo più o meno importante di partiti politici»3. Sordi ai richiami del Partito d’Azione, i firmatari del Patto di Roma rifondavano la Cgil sul «principio della più ampia democrazia interna». Tutte le cariche dovevano «essere elette dal basso». Proprio per questo, la democratica Cgil di Di Vittorio, Grandi e Canevari (in sostituzione del defunto Buozzi), dall’alto della loro autorità burocratica, tagliava la democrazia a fette di 5 rappresentanti per ognuna della correnti maggioritarie. Le minoranze, come quelle del Partito d’Azione, erano democraticamente escluse. Ed esclusi più di ogni altra cosa erano gli operai a cui il Patto di Roma veniva – sempre democraticamente! – imposto alle spalle.
Qualche stalinista giustificherà questa porcheria con la solita scusa delle difficoltà del momento, come primo atto di un qualcosa da aggiustare successivamente. L’idealismo spinge sempre a vedere quello che non c’è. La maestria con cui venne sabotata la rivoluzione, dimostra infatti che nulla fu lasciato al caso e all’improvvisazione. Perché, in realtà, solo stabilendo d’ufficio 10 cariche controrivoluzionarie unite a 5 presunte rivoluzionarie era possibile l’unità sindacale contro la rivoluzione. Ma non bastava, bisognava ancora affidare all’ala socialista gli operai dell’industria, all’ala democristiana l’agricoltura e all’ala comunista, capeggiata dal codista Di Vittorio, i miserabili braccianti. È così che la borghesia, con la complicità di Togliatti e Di Vittorio, riuscì a mettere i comunisti come ultima ruota del carro anche tra i ranghi del proletariato. In questo modo, sbilanciata a favore della reazione, la Cgil, cinghia di trasmissione dei tre partiti, fu subito dichiarata e pretesa autonoma dai partiti. In una parola, fu subito dichiarata borghese. In effetti, l’unità sindacale dall’alto e a forza, non è che l’unità dei burocrati coi padroni e contro gli operai.
È su questa base che poté dispiegarsi al meglio l’opera di Di Vittorio.
Per la ricostruzione capitalistica, ribattezzata pomposamente ricostruzione nazionale, Di Vittorio fu in prima linea a Torino, con Togliatti e Roveda, per sconfessare l’operaismo e far ritornare in fabbrica 1200 esperti, alias capi e capetti, buttati fuori a calci dagli operai che non ne potevano più di simili sanguisughe. È grazie a questa pressione dei massimi dirigenti rossi che gli operai della Fiat si ritroveranno tra le balle il fascista Valletta con tutto il suo corteo di criminali del vecchio regime. E mentre i fascisti ritornavano a piede libero o in fabbrica a vessare gli operai, le carceri si riempivano di partigiani. In mezzo a tutto questo casino, gli operai portavano a casa anche la scala mobile. La portavano a casa non grazie a Di Vittorio, ma nonostante Di Vittorio. Era la spinta inarrestabile della rivoluzione che costringeva i padroni a concedere giocoforza qualche briciola. Lo ammetteva lo stesso Di Vittorio, quando commentava che la scala mobile «compensa solo in parte i lavoratori di fronte al crescente costo della vita»4. Cinquant’anni dopo, ci avrebbero pensato i degni eredi di Di Vittorio, Trentin e compagni, a togliere agli operai quel che Peppino non era riuscito a lasciare ai padroni...
Il 18 Gennaio 1946, Di Vittorio presentò come un grande successo la sua firma che sbloccò i licenziamenti padronali. Condì il discorso con grandi promesse di futuri lavori tramite riconversione produttiva e sottospecie di novelli atelier nationaux che nessuno avrebbe mai visto, nemmeno gli operai. Luis Blanc, quando li propose nel 1848 francese, era in fondo in buona fede e comprensibilmente digiuno di marxismo. Quasi cent’anni dopo, Di Vittorio non aveva altra malafede da ostentare oltre a una scorpacciata di stalinismo, ingurgitata sapientemente dal 1921 (o poco dopo), anno della sua conversione al Partito Comunista. E mentre i padroni licenziavano in massa i rossi e gli operai più combattivi, Di Vittorio raccoglieva dal Governo lo sputo delle prime e ultime tasse progressive con cui pretendeva di confiscare i profitti del regime lasciandolo al potere, riverniciato da Democrazia Cristiana. Dei 24˙823 miliardi di lire accertati, il PCI riuscì a portarne a casa per gli operai ben 19, poco più dello 0,07%, una vera fortuna, anche se per i padroni!
Esaurito il loro compito di guardiani dei profitti, i padroni ricompensarono gli stalinisti che non servivano più a nulla, buttandoli fuori dal Governo nel 1947. Ci pensò la Provvidenza, dal volto fanatico di Antonio Pallante, a dare una nuova chance agli stalinisti, attentando alla vita di Palmiro Togliatti. Era il 14 Luglio del 1948. Prese d’assalto strade e fabbriche, ci fu il più imponente sciopero spontaneo che la classe operaia abbia mai messo in scena in questo Paese. Ci vollero 36 ore per cominciare a frenare la piega insurrezionale che aveva preso. Lo sforzo di Di Vittorio e compagni fu teso solo a sfiancare gli operai facendoli marciare per chilometri e chilometri e facendoli girare come le oche per le vie delle città. Nella seduta cretin-parlamentare del 16 Luglio, Di Vittorio cercò di spiegare ai suoi colleghi che la Cgil si era solo inserita nello sciopero per cercare di “tenerlo in pugno”. E mentre implorava almeno la destituzione del Ministro degli Interni Scelba, gli sgherri del Ministro, per le strade, accoppavano 20 dei nostri che chiedevano solo ai D’Onofrio di turno «A D’Ono’ dacce er via». Il via naturalmente non arrivò mai e Scelba, rimasto al suo posto, poté continuare indisturbato l’opera mandando al creatore 75 persone, arrestandone 150˙000 e condannandone la metà a oltre 20˙000 anni di carcere. Per tale repressione, ovviamente, non chiese il via a D’Onofrio né a Di Vittorio, sicuro com’era che tanto glielo avrebbero dato. Perché chi non dà il via libera agli operai, lo dà di fatto ai padroni.
Rientrato lo sciopero per l’attentato a Togliatti, la sorte provò ancora a baciare gli stalinisti, liberandoli della palla al piede dei cattolici, che sfrutteranno lo sciopero politico per l’attentato ad Ercoli per rompere l’unità sindacale e fondare di lì a poco la futura Cisl. Come d’incanto, la lotta di classe riprese di slancio. Senza più i cattolici, fu facile agli stalinisti prendere il controllo della Cgil. A mettere il bastone tra le ruote agli operai fu il loro capo sindacale, il compagno Di Vittorio, altamente preoccupato dall’immane pericolo che la Confederazione potesse «anche solo apparire come una Confederazione comunista»5. Di Vittorio confermava che all’idea che qualcosa diventi particolarmente rosso, gli stalinisti sbiancano regolarmente. Ma, in effetti, grande pericolo non c’era, perché liberatasi dai cattolici, la Confederazione non sarebbe mai sfuggita agli stalinisti, e come la Storia ha ampiamente dimostrato è molto più probabile che uno stalinista diventi un servo totale dei padroni, anziché un soldato davvero al servizio dei lavoratori. Eppure, nonostante il loro irrecuperabile capo, gli operai nel 1949 portarono a casa un aumento generale dei salari, e del 5% dalla 44ª alla 48ª ora di lavoro. Poco rispetto a quello di cui avevano bisogno, tanto rispetto a quello che i Di Vittorio avevano lasciato ai padroni negli anni precedenti.
Fu il canto del gallo della classe operaia che, spossata dagli inconcludenti anni ’40, finì per rifluire negli anni ’50. Anni d’oro per i parolai. Mentre infuriava la repressione alla Fiat, Di Vittorio, il burocrate, fu subito in prima linea nell’appoggio a piani del lavoro tanto ponderosi quanto vacui, esattamente come i loro promotori: Vittorio Foa e Bruno Trentin. Nessun’ora di sciopero per provare almeno ad attuare le proprie fantasie. Il piano del lavoro in effetti, esattamente come gli stalinisti, non si rivolgeva agli operai, ma al Governo e ai borghesi che ovviamente lo cestinarono senza dargli nemmeno un’occhiata. Sconsolato, Di Vittorio, non riuscì a capacitarsi del «perché la nostra (sic!) società nazionale non riesce ad utilizzare l’immensa forza-lavoro disponibile, rappresentata dai milioni di disoccupati e di sottoccupati, per attaccare d’ogni lato l’arretratezza economica dell’Italia?». Bella domanda per un sedicente marxista. Un vecchio con la barba, nel 1870 o giù di lì, aveva già dato la risposta: perché il capitale crea incessantemente un esercito industriale di riserva che preme sui salari e fa da perenne arma di ricatto contro il proletariato in lotta contro lo sfruttamento. Non si può quindi eliminare la disoccupazione lasciando al contempo la (loro) società dello sfruttamento. Alla stessa maniera, non si può demandare al Governo una riforma agraria vasta e profonda che elimini i residui di latifondo, perché tale compito può assolverlo solo la rivoluzione socialista. Infatti, cinque anni dopo, Di Vittorio registrò che le misure prese dal Governo, contro disoccupazione e latifondo, non avevano «nessuna parentela con lo spirito e con la portata pratica del piano del lavoro». Il dirigente sindacale, mentre constatava queste cose, non si domandò, però, perché il programma dei comunisti avrebbe dovuto essere attuato dai democristiani. Domanda troppo impegnativa per uno stalinista.
In questo modo allegro, proseguì la carriera di Di Vittorio, fino al 1957, quando la morte sottrasse un equivoco alla classe operaia. Il sindacalista aveva appena fatto in tempo, un anno prima, a sfornare il suo capolavoro di tartuferia e di ambiguità, ancora oggi strombazzato a destra e a manca come atto di chissà quale onestà intellettuale. Appoggiato fin dall’ascesa Stalin come un cagnolino, nel 1956 Di Vittorio si schierò apparentemente con la rivolta di Budapest. Un comunicato della Cgil del 27 Ottobre esprimeva «la condanna storica e definitiva di metodi antidemocratici di governo e di direzione politica ed economica. Sono questi metodi che determinano il distacco tra i dirigenti e le masse popolari». Di qui il sentimentalismo strappalacrime per il grande Peppino. Peccato che il 4 Novembre Di Vittorio scaricò il comunicato all’ala socialista della Cgil, giustificandolo come un sacrificio dei comunisti in nome dell’unità della Confederazione. Averlo approvato «non significa affatto che in noi si siano attenuati il profondo attaccamento che sentiamo per l’URSS». L’attaccamento all’URSS era ovviamente l’attaccamento alla burocrazia del Cremlino, infatti tre giorni dopo, a ricevere in pompa magna i dirigenti sovietici, c’erano tra gli altri Pertini, Foa, Amendola, Longo e naturalmente Di Vittorio. Nella tragedia ungherese, la sua commedia era finita. Il partito gli regalò l’epilogo di una sorta di processo a porte chiuse, in cui Di Vittorio fu visto addirittura piangere le sue lacrime di coccodrillo.
Non vorrei però che qualcuno leggesse queste ultime righe come un elogio dei socialisti. Se gli stalinisti come Di Vittorio si comportarono da stalinisti, i socialisti furono anche peggio, come al solito. La predica contro i metodi antidemocratici, veniva infatti da chi si era spartito alle spalle dei lavoratori il sindacato, ma soprattutto era la solita condanna a parole dei socialisti. Condannare davvero la repressione ungherese, voleva dire scendere in piazza per buttare giù le nostre statue con le stesse rivendicazioni socialiste dei consigli operai di Budapest. Divisi negli insignificanti comunicati di carta, socialisti e stalinisti si trovarono uniti nel non proclamare un’ora di sciopero in appoggio alla rivolta ungherese. Di fatto, dunque, appoggiarono la repressione. Proprio per questo, il più ipocrita di tutti, Nenni, premio baffone anche lui, non si presentò al ricevimento coi sovietici: stava studiando il sistema di scaricarli ora che cominciavano a non essere più di moda.
L’unica cosa concreta che fece Di Vittorio, invece, fu porre le basi perché fosse tranciata la cinghia di trasmissione che legava la Cgil al PCI. Come tutte le teste di legno burocratiche era incapace di vedere il male dove stava – in lui e in quelli come lui – perciò lo attribuì a tutto tranne che a sé stesso e al peso dell’apparato. La cinghia di trasmissione in realtà andava benissimo come concetto, essendo del grande Lenin, quello che era da buttare e sostituire erano le due rotelle, sindacato burocratico e partito stalinista, che giravano al contrario, a favore della concertazione coi padroni anziché a favore dei lavoratori.
Compiuto quest’ultimo sacrilegio della nostra dottrina, Di Vittorio, ignorante assoluto di marxismo, ci lasciò. Il lascito, come si vede, non è granché. Per fortuna ci pensa la sua Fondazione ad abbellirlo, con convegni in cui dimostra che il metodo stalinista è ancora ben oliato, e può, per la bisogna, trasformare il biennio del ’19-20, da biennio rosso a semplice «esplosione di conflittualità che non riescono ad essere gestite pienamente da nessuna delle istanze politiche e istituzionali preesistenti». È incredibile cosa, certa gente, non riesce a fare per nascondere, nei momenti rivoluzionari, l’opera nefasta dei suoi amati controrivoluzionari. Una Fondazione comunque non basta, è per questo che la borghesia ha sentito il bisogno di rendere omaggio a Peppino Di Vittorio con un film. Ci voleva un grande attore come Pierfrancesco Favino per trasformare la maschera d’uno stalinista nella faccia d’un sindacalista. Eppure, nonostante questi trucchi e altri effetti speciali, come non vedere nei suoi discorsi ambigui e perennemente retorici l’analogia coi discorsi vacui dei dirigenti di oggi? Come non vedere la continuità che c’è tra Di Vittorio che vanta come un successo lo sblocco dei licenziamenti alla Fiat nel 1946, i burocrati che presentano come vittoria la sconfitta epocale dei 35 giorni alla Fiat nel 1980, e gli ultimi loro eredi che vanno nelle fabbriche ai giorni nostri a dire che è nel nostro interesse fare 6 anni in più di lavoro? E in effetti a ben guardare, quando oggi si dice che si vuol tornare indietro senza più contratti nazionali né scioperi tra un contrattazione di chissà che tipo e l’altra, non ci accorge di affermare che si vuol tornare ai tempi di Di Vittorio! Il diritto di sciopero al momento di trattare, infatti, gli operai lo conquistarono nel ’68, sconfiggendo padroni e burocrazie sindacali che fecero, com’era storicamente scontato, da freno.
Gli operai, a differenza di quel che scrive l’Ancona, non hanno bisogno di un «sindacato autonomo dai partiti e dai governi». In mezzo secolo di attività sindacale, non ha ancora capito, Pietro Ancona, che i primi a urlare contro la dipendenza dei sindacati dai partiti e dalla politica, sono i padroni? E come possono i lavoratori volere un sindacato fatto su misura e coincidente con la mentalità padronale? In realtà, gli operai hanno il sacrosanto bisogno di un sindacato autonomo dai partiti e dai governi padronali. La differenza non è mica da poco. Infatti, l’unico modo che ha un sindacato per essere autonomo dai padroni, è essere la cinghia di trasmissione di un partito operaio, e il partito operaio per antonomasia è il partito della rivoluzione.
Gli operai hanno anche bisogno d’una frusta con cui levare la pelle a tutti i piccoli borghesi che s’infeudano nel sindacato, esaltandone la presunta autonomia da partiti e governi, per poi regolarmente piagnucolare per la mancanza del referente parlamentare con cui mandare avanti i loro traffici burocratici, inconcludenti e meschini.
La frusta, però, serve più di tutto ai lavoratori per richiamare all’ordine tutti i “gettatori” di spugna che solo per le nefandezze dei capi si sentono in diritto di abbandonare la nave della Cgil. Sei milioni di iscritti ha la Cgil. Lasciarla significa quadruplicare le cinghie di trasmissione che incatenano metà dei lavoratori alla burocrazia d’apparato e ai partiti padronali.
Suona molto intelligente poi uscire dalla Cgil per ritrovarsi a dover combattere nei sindacati di base la stessa burocrazia che ti butta fuori per niente come fa la Cgil6.
Non serve uscire dalla Cgil, bisogna restarci dentro a tutti i costi per buttare fuori tutti i burocrati che svendono i lavoratori. Questo, come direbbe Lenin, non si può ottenere senza un lavoro lungo e tenace. E nemmeno si può ottenere se lo scopo è un sindacato «non riformista e non massimalista». Un sindacato senza attributi, né carne né pesce, è perfetto per i centristi indecisi come Pietro Ancona. Loro, eterni nostalgici, vanno avanti e indietro col tempo alla ricerca dell’epoca d’oro in cui possono continuare a sognare. Il loro empirismo, li spinge dentro e fuori dalla Cgil a seconda del grado di disperazione raggiunto. In tutti i casi restano sempre a distanza siderale dal marxismo-leninismo. Immergere nel marxismo fino al collo i Pietro Ancona, è il compito più urgente dei compagni più coscienti. E non c’è molto tempo, bisogna far presto, anche a costo di iniettarglielo per endovenosa. In caso contrario, nei migliori militanti del nostro sindacato, continuerà a circolare il sangue avvelenato dalle mille piastrine del liberalismo. Invece di riprendere il cammino, non ci muoveremo d’un passo.
2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
































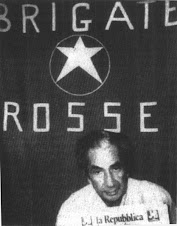























































































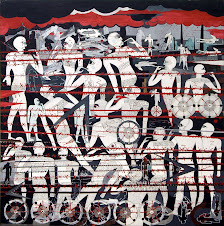






























































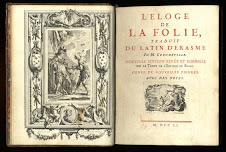



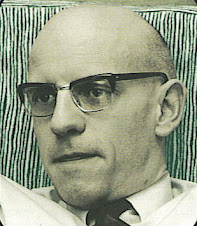














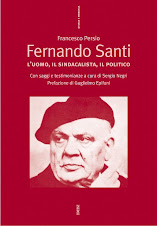





























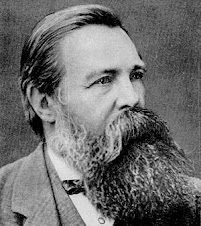













































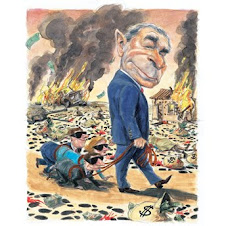

















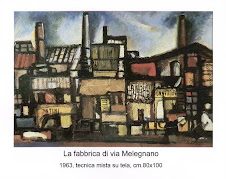














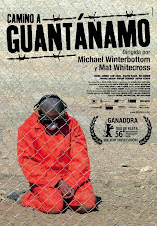





















































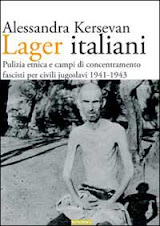



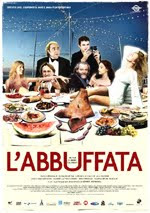















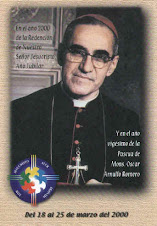










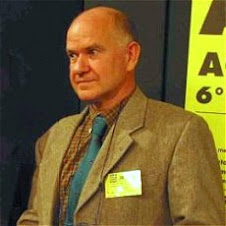




































































.jpg)
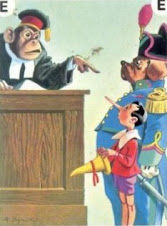







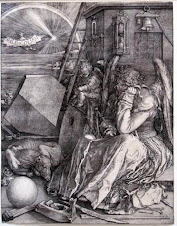


















.jpg)











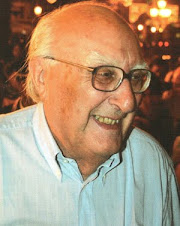









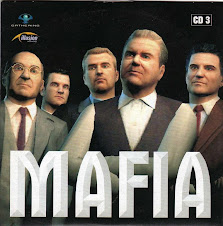















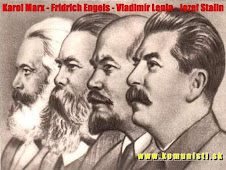



















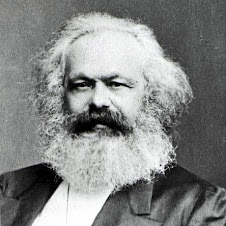























































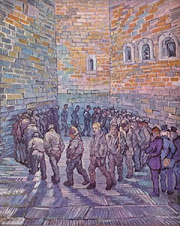
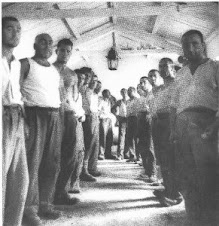




























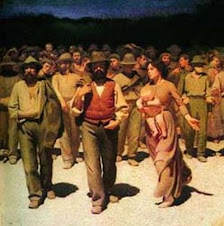













































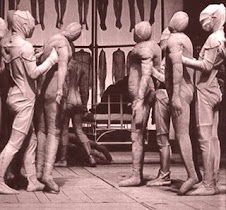


































































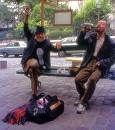



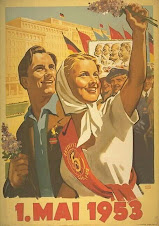
















































































































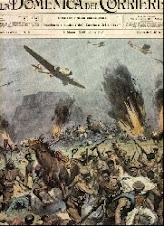






















































.jpg)















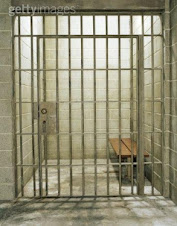







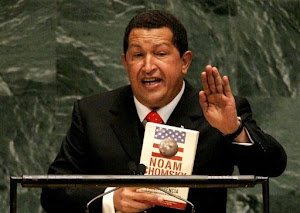







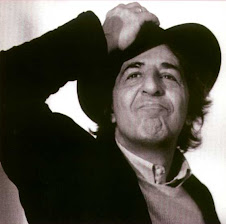










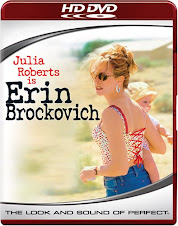






























1 commento:
buon post, che fa le pulci ai ragionamenti di Pietro Ancona...
http://www.giornalettismo.com/archives/132633/tremonti-brunetta-e-un-cretino/
Posta un commento