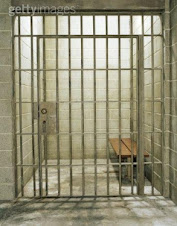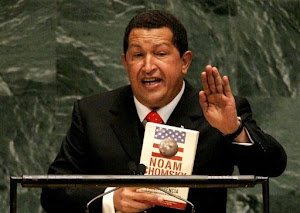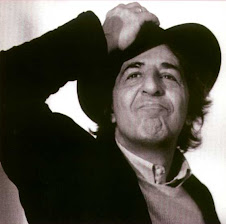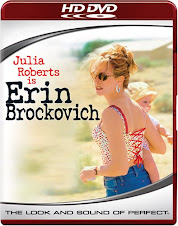Rispettare Gheddafi
L'Italietta con forti pulsioni razziste si è lasciata andare a sfottò, frizzi e lazzi, commenti volgari ed offensivi verso Gheddafi. Le divise sfoggiate dal Colonnello non gli sono piaciute, sono state oggetto di scherno e tantissimi si sono sentiti disturbati dalla sua presenza in Italia e dal risalto che il Governo ha dato a questo evento. Hanno avuto da ridire sui trecento cavalli berberi che si sono esibiti assieme ai carabinieri a cavallo in una caserma di Roma ed hanno naturalmente criticato tutto quello che Gheddafi ha detto e fatto.Questa campagna di respingimento e di denigrazione è stata orchestrata dai maggiori giornali italiani che obbediscono ad un forte riflesso condizionato dell'Occidente, in primo luogo degli americani, contro la Libia ed il suo Presidente. Non dimentichiamo che Reagan fece bombardare la tenda di Gheddafi riuscendo quasi ad ucciderlo assieme ai suoi familiari e massacrando una delle sue nipote. Motivo di tanto livore è probabilmente il fatto che il Colonnello, nonostante sia ritenuto una specie di buffone da circo, per quaranta anni ha preservato la libertà della Libia riuscendo a mantenere il controllo sulle sue immense ricchezze di petrolio. Quando parliamo della Libia teniamo presente le disgrazie che incombono sull'Irak e sull'Afghanistan e l'artiglio occidentale che si minaccia di ghermire l'Iran .
Repubblica fa da capofila a questa batteria massmediatica. L'opposizione parlamentare si sta comportando in modo irresponsabile e grottesco. Bersani ha mostrato di essere un politicante di poco spessore e Fini, Presidente della Camera, che si è recato qualche tempo fa in Israele per farsi sdoganare e che non dice una sola parola sul martirio del popolo palestinese storce il naso e disapprova gli onori che il governo Berlusconi sta rendendo al suo ospite.
Ma come ha ricordato Berlusconi la visita ed i festeggiamenti dell'anniversario del patto con l'Italia chiudono una ferita che risale al 1911. L'Italia ha occupato per moltissimi anni la Libia. Il suo dominio è stato di una ferocia apocalittica. Il generale Magliocco si divertiva a gasare la popolazione civile irrorandola di iprite dai suoi aerei appositamente adattati. Migliaia e migliaia di libici finirono impiccati, impalati o mitragliati. Le migliore terre furono assegnate dal fascismo a coloni italiani strappandole ai
loro legittimi proprietari. Bisogna rileggere Del Boca per avere una idea della crudeltà insensata e della violenza senza fine che hanno fatto degli italiani un incubo terribile per le popolazioni libiche.
L'Italia ha imparato dagli USA a chiedere diritti umani senza rispettarli. L'Italia delle pulizie etniche che distrugge le povere abitazioni dei rom, l'Italia dei respingimenti che hanno causato migliaia di morti nel Mediterraneo, delle carceri stracolme di essere umani allucinati, delle caserme in cui non sono rari le uccisioni di persone arrestate, indica in Gheddafi un tiranno torturatore dopo avere stipulato con lui accordi per la repressione.
La pulsione razzista e colonialista ha il sopravvento anche sugli interessi economici e sulle urgenze dell'Italia che sono ben più gravi di quelle della Libia. Come nota oggi il Professore Gallino l'Italia ha perso quasi tutto il suo patrimonio industriale. La stessa Fiat, ridimensionata e costretta a cercare luoghi di produzione a costo bassissimo all'estero, non sembra avere un grande futuro. La terziarizzazione dell'economia italiana è diventata quasi patologica e dipendiamo sempre di più dai paesi industrializzati.
Ebbene gli accordi con la Libia danno una grande boccata d'ossigeno. Basterebbe questo a indurre
alla prudenza gli isterici ed irresponsabili politicanti e pennivendoli che da giorni martellano di commenti offensivi ed ingiuriosi il colonnello Gheddafi.
Qualcuno non ha perduto la testa e non si è abbandonato a questa ridicola ed autolesionistica campagna antilibica. Valentino Parlato che ho sentito ieri sera a Rai24new non si è unito al coro della diffamazione.
Provo ad immaginare che cosa succedebbe se venisse in Italia il Presidente Ahmadinjed specialmente dopo la campagna per la lapidazione mai avvenuta ddlla signora Sakineh. Anche qui scatta un pregiudizio, un riflesso razzista e colonialista ed una grande voglia a fare da ascari agli USA
trascurando gli interessi veri per compiacere l'Imperatore di oltre oceano.
Eppure Iran e Libia sono stati vitali e continuano ad esserlo per la nostra prosperità.
Pietro Ancona
http://medioevosociale-pietro.blogspot.com/
www.spazioamico.it
lunedì 30 agosto 2010
Il nostro debito di sangue e di onore con la Libia
.
Il nostro debito di sangue e di onore con la Libia
pubblicata da Pietro Ancona il giorno lunedì 30 agosto 2010 alle ore 21.06
Le tue modifiche sono state salvate.
In occasione della visita del Presidente della Libia Gheddafi in Italia che si inscrive su una positiva linea di superamento dell'aggressione coloniale italiana durata molti decenni con delitti contro l'umanità spaventosi come l'uccisione di popolazioni inermi con il gas iprite e l'impalamento dei combattenti patrioti. desidero rinfrescare la memoria pubblicando questa scheda
======
Vent'anni di ostilità e di tentativi di "pacificazione" condotti dall'esercito a colpi di bombe all'iprite, massacri e deportazioni di popolazione civili. Una strategia della "terra bruciata" che trovò in Badoglio e Graziani i suoi più zelanti esecutori.
La sporca guerradi Libia (1911-1931)
di MICHELE STRAZZA
La conquista italiana della Libia prese il via tra il 4 e il 5 ottobre 1911 con gli sbarchi delle truppe italiane, rispettivamente a Tobruk e Tripoli, inviate da Giolitti contro l'Impero Ottomano. Il corpo di spedizione, al comando del generale Carlo Caneva, era forte di 35.000 uomini, saliti poi a 100.000 nei mesi successivi. Con il Trattato di Losanna (o di Ouchy) del 18 ottobre 1912 la Turchia conservava la sovranità formale sulla Libia ma demandava all'amministrazione italiana il controllo, anche militare, della fascia costiera tra Zuara e Tobruk.L'occupazione e il controllo del territorio si rivelarono più difficoltose del previsto, a causa della fiera opposizione dell'esercito turco prima e delle formazioni irregolari libiche poi. Tra il 1913 e il 1914 la presenza del regio esercito si estese alla Tripolitania settentrionale e il colonnello Miani guidò una colonna di ascari eritrei fino al Fezzan. Ma alcune sconfitte nell'inverno 1914-15 e lo scoppio della prima guerra mondiale costrinsero gli italiani a ripiegare sulla costa, tenendo saldamente alcune località come Tripoli, Zuara e Homs in Tripolitania, Bengasi, Derna e Tobruk in Cirenaica. I territori interni, invece, vennero, di fatto, governati da alcuni notabili locali in Tripolitania e dalla Senussia (organizzazione religiosa e politica mussulmana) in Cirenaica.
Terminato il primo conflitto mondiale, in Italia fu adottata la politica delle concessioni che portò, con gli "Statuti libici" accordati a Tripolitania e Cirenaica e l'accordo con i senussiti, a un periodo di sostanziale pacificazione del Paese africano. Con il capo dei senussiti, Mohammed Idris, infatti, furono conclusi i patti di Acroma (aprile 1917) e di Regima (ottobre 1920), in base ai quali Idris riconobbe la sovranità italiana sulla Cirenaica e il possesso della costa, avendo in cambio, dal governo italiano, il riconoscimento del
titolo di "emiro", nonché l'amministrazione delle zone interne e il diritto di tenere forze armate.L'anno prima, nel 1919, era stato concesso lo statuto alle due colonie, con la previsione dell'elezione di due parlamenti locali e di alcuni diritti alle popolazioni. A Tripoli, però, il parlamento non venne mai eletto mentre quello in Cirenaica funzionò per poco tempo e senza alcun risultato rilevante. La situazione in quest'ultima colonia, tuttavia, restò alquanto migliore rispetto alla prima. Il controllo dei senussiti, infatti, contribuì a garantire l'ordine, almeno per un certo periodo di tempo, cosa che invece non accadde in Tripolitania dove le lotte tra i capi locali e il contrasto tra arabi e berberi impedirono il funzionamento di quella "repubblica" tripolitana, proclamata dai ribelli nel novembre del 1919, creando incertezza e confusione.Nel 1921 fu istituito il Governatorato della Tripolitania e nominato governatore Giuseppe Volpe, industriale e futuro Ministro delle Finanze, che riprese l'avanzata militare occupando, tra gennaio e febbraio 1922, il porto di Misurata Marina. Tra aprile e maggio, grazie anche all'azione dell'allora colonnello Rodolfo Graziani, le forze arabe vennero respinte. Mentre in Italia, si svolge la marcia su Roma le truppe italiane occupavano Jefren.
La partita libica proseguì con l'arrivo di Mussolini al potere. I suoi sogni di conquista coloniale acutizzarono i problemi esistenti tra l'Italia e i senussiti tanto che l'emiro Mohammed Idris, non ritenendosi più al sicuro, nel gennaio del 1923 fuggì in Egitto dopo aver lasciato in patria, come suo rappresentante, il fratello Mohammed er-Ridà.Alla fine dello stesso mese di gennaio giunse a Bengasi il generale Bongiovanni, cui Mussolini in persona, prima di partire, aveva impartito poche ed eloquenti direttive: «Pestar sodo».Bongiovanni trovò una situazione abbastanza tranquilla nel nord della Tripolitania che gli consentì di procedere all'occupazione della parte meridionale. Sfruttando i dissidi tra le varie tribù locali la conquista fu completata senza grossi problemi nel 1926.Contemporaneamente le truppe italiane si apprestarono a invadere la Cirenaica, pur tra mille difficoltà, tra cui la forte presenza della Confraternita dei Senussiti.Nella notte tra il 5 e il 6 marzo 1923 le truppe italiane e quelle ascare del generale Bongiovanni entrarono nel Gebel al-Akdar sconfiggendo i senussiti e installandovi alcuni presidi con truppe eritree.In seguito, però, la resistenza indigena del Gebel, dove erano presenti circa 100.000 seminomadi, si riorganizzò sotto la guida dell'anziano Omar al-Mukhtar dando notevole filo da torcere agli italiani. Anzi, i senussiti riuscirono a creare una vera e propria amministrazione parallela (il cosiddetto "governo della notte") che continua addirittura a riscuotere le decime tradizionali dalle popolazioni, ad amministrare la giustizia e a minacciare gli insediamenti italiani. Anche i proventi del commercio con l'Egitto servirono a finanziare la lotta armata contro l'invasore.La risposta italiana fu micidiale: rastrellamenti a catena e bombardamenti per distruggere le coltivazioni di orzo al fine di impedire il commercio con l'Egitto.La strategia della "terra bruciata" indusse migliaia di famiglie indigene a fuggire verso la Tunisia, l'Algeria, il Ciad e l'Egitto.
Nel 1928 anche la piccola oasi di Gife, situata tra la costa mediterranea a sud di Nufilia e la catena dei monti Harugi fu distrutta da bombe italiane, alcune delle quali caricate a gas. Ciò costituiva una aperta violazione del diritto internazionale in quanto l'Italia fascista aveva firmato a Ginevra, il 17 giugno 1925, con altri 25 Paesi, il "Protocollo per la proibizione di gas asfissianti, tossici o di altri gas, e degli strumenti di guerra
Artiglieri italiani in Libia
batteriologici". La distruzione di Gife venne raccontata nelle memorie di guerra di Vincenzo Biani, un volume che riscosse gli elogi di Italo Balbo: «Una spedizione di otto apparecchi fu inviata su Gifa, località imprecisata dalle carte a nostra disposizione, che erano dei semplici schizzi ricavati da informazioni degli indigeni; importante però per una vasta conca, ricoperta di pascolo e provvista di acqua in abbondanza. Ma senza oasi e senza case: un punto nel deserto. Fu rintracciata perché gli equipaggi, navigando a pochi metri da terra, poterono seguire le piste dei fuggiaschi e trovarono finalmente sotto di sé un formicolio di genti in fermento; uomini, donne, cammelli, greggi; con quella promiscuità tumultuante che si riscontra solo nelle masse sotto l'incubo di un cataclisma; una moltitudine che non aveva forma, come lo spavento e la disperazione di cui era preda; e su di essa piovve, con gettate di acciaio rovente, la punizione che meritava. Quando le bombe furono esaurite, gli aeroplani scesero più bassi per provare le mitragliatrici. Funzionavano benissimo. Nessuno voleva essere il primo ad andarsene, perché ognuno aveva preso gusto a quel gioco nuovo e divertentissimo. E quando finalmente rientrammo a Sirte, il battesimo del fuoco fu festeggiato con parecchie bottiglie di spumante, mentre si preparavano gli apparecchi per un'altra spedizione. Ci si dava il cambio nelle diverse missioni. Alcuni andavano in ricognizione portandosi sempre un po'di bombe con le quali davano un primo regalo ai ribelli scoperti, e poi il resto arrivava poche ore dopo. In tutto il vasto territorio compreso tra El Machina, Nufilia e Gifa i più fortunati furono gli sciacalli che trovarono pasti abbondanti alla loro fame».
Ma nonostante i massicci bombardamenti la guerriglia senussita, equipaggiata di armi dall'Egitto, continuava a creare seri problemi al regio esercito. Per dare una svolta alla "pacificazione" il 18 dicembre 1928 Badoglio venne nominato governatore delle due province della Tripolitania e della Cirenaica, quindi, il 21 gennaio 1929, "governatore unico" di entrambe. Nel contempo, come da lui richiesto, il maresciallo conservava anche la carica di capo di stato maggiore generale.Sbarcato in Tripolitania, Badoglio si mise subito al lavoro per completare la riconquista della provincia. Tra i suoi primi provvedimenti un bando che garantiva l'amnistia ai ribelli che si fossero arresi e la minaccia di morte ai recidivi. Tra l'estate del 1929 e il gennaio del 1930, grazie anche alle colonne di Graziani, furono occupate tutte le oasi del Fezzan mentre gruppi di armati arabi sconfinarono in territorio francese. Ormai la Tripolitania era completamente conquistata, con le tribù nomadi decimate dai bombardamenti e dalla fame.Diversa, invece, la situazione in Cirenaica dove i guerriglieri senussiti, grazie a una efficiente organizzazione, dominano ancora il Gebel, l'altopiano centrale della regione.I gruppi di armati (duar), composti ciascuno di 3-400 uomini, davanti ai rastrellamenti italiani si nascondevano nei numerosi burroni del Gebel per poi riapparire dietro le linee italiane colpendo le installazioni militari. Qualche tentativo di trattare con i ribelli di Omar al-Mukhtar fu messo in atto nel giugno del 1929 dal vice-governatore Siciliani. Si concordò anche una tregua, che però non durò a lungo.Nel 1930 Mussolini, insoddisfatto di come andavano le cose in Cirenaica, inviò Rodolfo Graziani come vice governatore a Bengasi. Il risultato fu una grande operazione di rastrellamento la quale, tuttavia, non diede l'esito sperato. I "mujaheddin" di Omar al-Mukhtar potevano infatti contare sull'appoggio morale e materiale delle popolazioni locali. Dirà due anni dopo Graziani: «Avevamo contro di noi tutta la popolazione della Cirenaica che partecipava alla ribellione: da una parte, allo stato potenziale, i cosiddetti sottomessi; dall'altra, apertamente in campo, gli armati. Tutta la Cirenaica, in una parola, era ribelle».
Per rompere il collegamento tra popolazione e guerriglia non era sufficiente neanche l'esproprio integrale dei beni mobili e immobili delle zavie senussite, veri e propri centri spirituali ed assistenziali. Il 29 maggio i reali carabinieri penetrarono contemporaneamente nelle 49 zavie, arrestando 31 capi zavia e mettendo i sigilli alle proprietà (centinaia di abitazioni e circa 70.000 ettari di buona terra). I religiosi, dopo essere stati confinati in alcuni campi presso Benina, vennero quindi imbarcati per Ustica. Ma l'impostazione "tradizionale" della repressione messa in atto da Graziani non
Rodolfo Graziani
soddisfece Badoglio, che il 20 giugno 1930 scrisse al vice governatore per sollecitare nuovi metodi: «Bisogna anzitutto creare un distacco territoriale largo e ben preciso tra formazioni ribelli e popolazione sottomessa. Non mi nascondo la portata e la gravità di questo provvedimento, che vorrà dire la rovina della popolazione cosiddetta sottomessa. Ma ormai la via ci è stata tracciata e noi dobbiamo perseguirla sino alla fine anche se dovesse perire tutta la popolazione della Cirenaica. Urge dunque far rifluire in uno spazio ristretto tutta la popolazione sottomessa, in modo da poterla adeguatamente sorvegliare ed in modo che vi sia uno spazio di assoluto rispetto fra essa e i ribelli. Fatto questo allora si passa all'azione diretta contro i ribelli».Solo cinque giorni dopo Graziani ordinò il trasferimento delle popolazioni del Gebel. Iniziò così un massiccio spostamento dall'altipiano verso la costa: 900 tende Abid furono spostate nella piana di Barce, 1.400 tende Dorsa intorno a Tolmeta, altre 3.600 distribuite fra Cirene e Derna. Ma per completare quella che sarà la deportazione di ben 100.000 civili, quasi la metà dell'intera popolazione della Cirenaica, saranno necessarie ulteriori tappe. Il 16 luglio Badoglio diramò a Graziani le seguenti istruzioni: «1) Riunire tutti i parenti dei ribelli in uno stretto e molto sorvegliato campo di concentramento, ove le loro condizioni siano piuttosto disagiate. 2) Arrestare nelle varie cabile ed in Bengasi i notabili che notoriamente hanno esplicato azione contraria a noi e mandarli al confino in Italia».Graziani stesso, come racconterà in seguito, non ebbe alcuna esitazione: «Tutti i campi furono circondati da doppio reticolato; i viveri razionati; i pascoli contratti e controllati; la circolazione esterna resa soggetta a permessi speciali. Furono concentrati nel campo di el Agheila tutti i parenti dei ribelli, perché più facilmente portati alla connivenza [.] I capi e le popolazioni refrattarie e sorde ad ogni voce di persuasione e di richiamo ricevevano così il trattamento che si erano meritato. Il rigore estremo, senza remore né tregua, cadeva inesorabile su di esse».
Naturalmente la responsabilità della deportazione non va ascritta al solo Badoglio ma anche, come puntualizza Angelo Del Boca, al ministro De Bono che aveva da tempo sollecitato la misura e allo stesso Mussolini che l'aveva approvata.Le varie tribù, con vecchi, donne e bambini, furono sottoposte a terribili marce forzate per centinaia di chilometri che si trasformarono in vere e proprie "marce di sterminio". Chi indugiava o si attardava nelle poche soste viene immediatamente abbattuto. Numerosi gli episodi di crudeltà gratuita, come l'abbandono di 35 indigeni, tra cui donne e bambini, in pieno deserto, senza acqua né viveri, a causa di una rissa scoppiata tra loro. Senza contare i maltrattamenti, le fustigazioni, i morti per sete. La tribù degli Auaghir raggiunse il campo di concentramento di Soluch, circondato dal filo spinato, dopo 350 chilometri di marce forzate. Circa 6.500 tra Abeidat e Marmarici, che avevano tentato di ribellarsi, furono sottoposti a una marcia di 1.100 chilometri in pieno inverno verso la Sirtica. Secondo Del Boca furono 90.761 le persone giunte nei campi e quasi 10.000 quelle morte durante la marcia per stenti, mancanza di cibo, malattie e tentativi di fuga. Dopo le deportazioni e la creazione dei campi di concentramento la resistenza dei duar di Omar al Mukhtàr si trovò sempre più isolata. I gruppi ribelli furono costretti a dividersi per sfuggire agli accerchiamenti, riducendo però in tal modo la loro capacità offensiva. Le sconfitte minarono il morale e a nulla servirono le scorrerie delle bande di Abd el Gelil Sef en-Nasser e Saleh el Atèusc, rifugiatesi nell'oasi di Taizerbo, situata 250 chilometri a nordovest di Cufra.Ed è proprio su quest'oasi, dove si pensava fossero ancora i ribelli, che si concentrò l'attenzione italiana. Il 31 luglio 1930 quattro aerei al comando del tenente colonnello Roberto Lordi partono da Gialo con l'ordine di distruggere Taizerbo. Vengono lanciate 24 bombe da 21 chili caricate a iprite e 12 bombe da 12 chili e 320 da 2 chili con esplosivo convenzionale.Anche Cufra, città santa dei senussiti nella Libia sudorientale, dove intanto si erano ritirate le bande ribelle di Abd el Gelli Sef en-Nasser e Saleh el Atèusc, subì un attacco dal cielo prima di essere presa nel gennaio del 1931 da una colonna di "meharisti", mercenari libici su cammelli e autocarri.I guerriglieri sopravvissuti fuggirono con le proprie famiglie ma i reparti cammellati e l'aviazione li inseguirono per vari giorni fino ad annientarli in gran parte: tra le vittime anche donne e bambini. Cufra fu sottoposta a tre giorni di saccheggi e violenze: 17 capi senussiti furono impiccati, 35 indigeni evirati e lasciati morire dissanguati, 50 donne stuprate; si registrarono anche 50 fucilazioni e 40 esecuzioni con ascia, baionette e sciabole. Le truppe vittoriose si abbandonarono a ogni atrocità: alle donne incinte venne squartato il ventre e i feti infilzati, giovani furono donne violentate e sodomizzate con le candele, teste e testicoli mozzati portati in giro come trofei, tre bambini immersi in calderoni di acqua bollente, ad alcuni vecchi vennero estirpate le unghie per essere poi accecati.
Nonostante la caduta di Cufra, che generò un'ondata di sdegno in tutto il mondo
Pietro Badoglio
islamico, Omar al Mukhtàr continuò a resistere con le poche truppe rimaste grazie, secondo Graziani, al contrabbando con la frontiera egiziana. E' a questo punto che Badoglio e Graziani decidono di isolare del tutto i ribelli con la costruzione di una recinzione tra la Cirenaica e l'Egitto.Nonostante il parere contrario di De Bono e del sottosegretario alle Colonie Roberto Cantalupo, Mussolini dà il suo via libera e il reticolato - una barriera di filo spinato larga alcuni metri e lunga ben 270 chilometri, dal porto di Bardia all'oasi di Giarabub - viene costruito in sei mesi, da aprile a settembre del 1931. Bloccato ogni rifornimento, dunque, le bande ribelli erano destinate a soccombere. Il 9 settembre 1931 il settantatreenne capo della resistenza libica Omar al Mukhtàr venne catturato. La condanna a morte fu pronunciata il 16 settembre. Ferito, inutilmente tutelato dal diritto internazionale che avrebbe imposto un suo trattamento come prigioniero di guerra, fu impiccato nel campo di Soluch. Graziani raccontò che 20.000 beduini furono costretti ad assistere all'esecuzione per dimostrare loro che i giorni del compromesso e della debolezza italiana erano terminati.Dando per buono il censimento della Cirenaica del 1920 che annotava 225.000 abitanti e tenendo conto che 20.000 fuggirono in Egitto, ricordando poi il censimento italiano del 1931 che registrava solo 142.000 anime (oltre a 18.500 italiani), si deve dedurre che in undici anni la popolazione del Paese diminuì di circa 83.000 persone: 20.000 rifugiate in Egitto e ben 63.000 per la guerra, la deportazione e la prigionia.Anche il patrimonio zootecnico venne ampiamente distrutto: gli ovini da 800.000 nel 1926 si ridussero a 98.000 nel 1933, i cammelli da 75.000 a 2.600, i cavalli da 14.000 a 1.000, gli asini da 9.000 a 5.000.Una vera e propria carneficina, dunque, o, per meglio dire, un "genocidio" praticato dal "buon italiano" il cui ricordo risulta ancora rimosso dalla memoria collettiva dell'Italia nonostante gli sforzi di quegli storici che l'additano all'attenzione di chi non ha paura della verità.
BIBLIOGRAFIA
Ali italiane sul deserto, di V. Biani - Bemporad, Firenze 1933.
Storia dell'Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre, di G. Candeloro - Feltrinelli, Milano 2002.
Gli italiani in Libia. Tripoli bel suol d'amor, di A. Del Boca - Mondadori, Milano 1984.
Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi, di A. Del Boca - Laterza, Roma-Bari 1991.
Cirenaica pacificata, di R. Graziani - Mondadori, Milano 1932.
Gli italiani e il colonialismo. I campi di detenzione italiani in Africa, di G. Ottolenghi - Sugarco, Milano 1997.
Pietro Badoglio, di P. Pieri e G. Rochat - UTET, Torino 1974.
Guerre italiane in Libia e in Etiopia. Studi militari 1921-1939, di G. Rochat - Pagus, Treviso 1991.
Genocidio in Libia. Le atrocità nascoste dell'avventura coloniale (1911-1931), di E. Salerno - Manifestolibri, Roma 2005.
Omar al-Mukthar e la riconquista fascista della Libia, di E. Santarelli, G. Rochat, R. Rainero, L. Goglia - Marzorati, Milano 1981
Il nostro debito di sangue e di onore con la Libia
pubblicata da Pietro Ancona il giorno lunedì 30 agosto 2010 alle ore 21.06
Le tue modifiche sono state salvate.
In occasione della visita del Presidente della Libia Gheddafi in Italia che si inscrive su una positiva linea di superamento dell'aggressione coloniale italiana durata molti decenni con delitti contro l'umanità spaventosi come l'uccisione di popolazioni inermi con il gas iprite e l'impalamento dei combattenti patrioti. desidero rinfrescare la memoria pubblicando questa scheda
======
Vent'anni di ostilità e di tentativi di "pacificazione" condotti dall'esercito a colpi di bombe all'iprite, massacri e deportazioni di popolazione civili. Una strategia della "terra bruciata" che trovò in Badoglio e Graziani i suoi più zelanti esecutori.
La sporca guerradi Libia (1911-1931)
di MICHELE STRAZZA
La conquista italiana della Libia prese il via tra il 4 e il 5 ottobre 1911 con gli sbarchi delle truppe italiane, rispettivamente a Tobruk e Tripoli, inviate da Giolitti contro l'Impero Ottomano. Il corpo di spedizione, al comando del generale Carlo Caneva, era forte di 35.000 uomini, saliti poi a 100.000 nei mesi successivi. Con il Trattato di Losanna (o di Ouchy) del 18 ottobre 1912 la Turchia conservava la sovranità formale sulla Libia ma demandava all'amministrazione italiana il controllo, anche militare, della fascia costiera tra Zuara e Tobruk.L'occupazione e il controllo del territorio si rivelarono più difficoltose del previsto, a causa della fiera opposizione dell'esercito turco prima e delle formazioni irregolari libiche poi. Tra il 1913 e il 1914 la presenza del regio esercito si estese alla Tripolitania settentrionale e il colonnello Miani guidò una colonna di ascari eritrei fino al Fezzan. Ma alcune sconfitte nell'inverno 1914-15 e lo scoppio della prima guerra mondiale costrinsero gli italiani a ripiegare sulla costa, tenendo saldamente alcune località come Tripoli, Zuara e Homs in Tripolitania, Bengasi, Derna e Tobruk in Cirenaica. I territori interni, invece, vennero, di fatto, governati da alcuni notabili locali in Tripolitania e dalla Senussia (organizzazione religiosa e politica mussulmana) in Cirenaica.
Terminato il primo conflitto mondiale, in Italia fu adottata la politica delle concessioni che portò, con gli "Statuti libici" accordati a Tripolitania e Cirenaica e l'accordo con i senussiti, a un periodo di sostanziale pacificazione del Paese africano. Con il capo dei senussiti, Mohammed Idris, infatti, furono conclusi i patti di Acroma (aprile 1917) e di Regima (ottobre 1920), in base ai quali Idris riconobbe la sovranità italiana sulla Cirenaica e il possesso della costa, avendo in cambio, dal governo italiano, il riconoscimento del
titolo di "emiro", nonché l'amministrazione delle zone interne e il diritto di tenere forze armate.L'anno prima, nel 1919, era stato concesso lo statuto alle due colonie, con la previsione dell'elezione di due parlamenti locali e di alcuni diritti alle popolazioni. A Tripoli, però, il parlamento non venne mai eletto mentre quello in Cirenaica funzionò per poco tempo e senza alcun risultato rilevante. La situazione in quest'ultima colonia, tuttavia, restò alquanto migliore rispetto alla prima. Il controllo dei senussiti, infatti, contribuì a garantire l'ordine, almeno per un certo periodo di tempo, cosa che invece non accadde in Tripolitania dove le lotte tra i capi locali e il contrasto tra arabi e berberi impedirono il funzionamento di quella "repubblica" tripolitana, proclamata dai ribelli nel novembre del 1919, creando incertezza e confusione.Nel 1921 fu istituito il Governatorato della Tripolitania e nominato governatore Giuseppe Volpe, industriale e futuro Ministro delle Finanze, che riprese l'avanzata militare occupando, tra gennaio e febbraio 1922, il porto di Misurata Marina. Tra aprile e maggio, grazie anche all'azione dell'allora colonnello Rodolfo Graziani, le forze arabe vennero respinte. Mentre in Italia, si svolge la marcia su Roma le truppe italiane occupavano Jefren.
La partita libica proseguì con l'arrivo di Mussolini al potere. I suoi sogni di conquista coloniale acutizzarono i problemi esistenti tra l'Italia e i senussiti tanto che l'emiro Mohammed Idris, non ritenendosi più al sicuro, nel gennaio del 1923 fuggì in Egitto dopo aver lasciato in patria, come suo rappresentante, il fratello Mohammed er-Ridà.Alla fine dello stesso mese di gennaio giunse a Bengasi il generale Bongiovanni, cui Mussolini in persona, prima di partire, aveva impartito poche ed eloquenti direttive: «Pestar sodo».Bongiovanni trovò una situazione abbastanza tranquilla nel nord della Tripolitania che gli consentì di procedere all'occupazione della parte meridionale. Sfruttando i dissidi tra le varie tribù locali la conquista fu completata senza grossi problemi nel 1926.Contemporaneamente le truppe italiane si apprestarono a invadere la Cirenaica, pur tra mille difficoltà, tra cui la forte presenza della Confraternita dei Senussiti.Nella notte tra il 5 e il 6 marzo 1923 le truppe italiane e quelle ascare del generale Bongiovanni entrarono nel Gebel al-Akdar sconfiggendo i senussiti e installandovi alcuni presidi con truppe eritree.In seguito, però, la resistenza indigena del Gebel, dove erano presenti circa 100.000 seminomadi, si riorganizzò sotto la guida dell'anziano Omar al-Mukhtar dando notevole filo da torcere agli italiani. Anzi, i senussiti riuscirono a creare una vera e propria amministrazione parallela (il cosiddetto "governo della notte") che continua addirittura a riscuotere le decime tradizionali dalle popolazioni, ad amministrare la giustizia e a minacciare gli insediamenti italiani. Anche i proventi del commercio con l'Egitto servirono a finanziare la lotta armata contro l'invasore.La risposta italiana fu micidiale: rastrellamenti a catena e bombardamenti per distruggere le coltivazioni di orzo al fine di impedire il commercio con l'Egitto.La strategia della "terra bruciata" indusse migliaia di famiglie indigene a fuggire verso la Tunisia, l'Algeria, il Ciad e l'Egitto.
Nel 1928 anche la piccola oasi di Gife, situata tra la costa mediterranea a sud di Nufilia e la catena dei monti Harugi fu distrutta da bombe italiane, alcune delle quali caricate a gas. Ciò costituiva una aperta violazione del diritto internazionale in quanto l'Italia fascista aveva firmato a Ginevra, il 17 giugno 1925, con altri 25 Paesi, il "Protocollo per la proibizione di gas asfissianti, tossici o di altri gas, e degli strumenti di guerra
Artiglieri italiani in Libia
batteriologici". La distruzione di Gife venne raccontata nelle memorie di guerra di Vincenzo Biani, un volume che riscosse gli elogi di Italo Balbo: «Una spedizione di otto apparecchi fu inviata su Gifa, località imprecisata dalle carte a nostra disposizione, che erano dei semplici schizzi ricavati da informazioni degli indigeni; importante però per una vasta conca, ricoperta di pascolo e provvista di acqua in abbondanza. Ma senza oasi e senza case: un punto nel deserto. Fu rintracciata perché gli equipaggi, navigando a pochi metri da terra, poterono seguire le piste dei fuggiaschi e trovarono finalmente sotto di sé un formicolio di genti in fermento; uomini, donne, cammelli, greggi; con quella promiscuità tumultuante che si riscontra solo nelle masse sotto l'incubo di un cataclisma; una moltitudine che non aveva forma, come lo spavento e la disperazione di cui era preda; e su di essa piovve, con gettate di acciaio rovente, la punizione che meritava. Quando le bombe furono esaurite, gli aeroplani scesero più bassi per provare le mitragliatrici. Funzionavano benissimo. Nessuno voleva essere il primo ad andarsene, perché ognuno aveva preso gusto a quel gioco nuovo e divertentissimo. E quando finalmente rientrammo a Sirte, il battesimo del fuoco fu festeggiato con parecchie bottiglie di spumante, mentre si preparavano gli apparecchi per un'altra spedizione. Ci si dava il cambio nelle diverse missioni. Alcuni andavano in ricognizione portandosi sempre un po'di bombe con le quali davano un primo regalo ai ribelli scoperti, e poi il resto arrivava poche ore dopo. In tutto il vasto territorio compreso tra El Machina, Nufilia e Gifa i più fortunati furono gli sciacalli che trovarono pasti abbondanti alla loro fame».
Ma nonostante i massicci bombardamenti la guerriglia senussita, equipaggiata di armi dall'Egitto, continuava a creare seri problemi al regio esercito. Per dare una svolta alla "pacificazione" il 18 dicembre 1928 Badoglio venne nominato governatore delle due province della Tripolitania e della Cirenaica, quindi, il 21 gennaio 1929, "governatore unico" di entrambe. Nel contempo, come da lui richiesto, il maresciallo conservava anche la carica di capo di stato maggiore generale.Sbarcato in Tripolitania, Badoglio si mise subito al lavoro per completare la riconquista della provincia. Tra i suoi primi provvedimenti un bando che garantiva l'amnistia ai ribelli che si fossero arresi e la minaccia di morte ai recidivi. Tra l'estate del 1929 e il gennaio del 1930, grazie anche alle colonne di Graziani, furono occupate tutte le oasi del Fezzan mentre gruppi di armati arabi sconfinarono in territorio francese. Ormai la Tripolitania era completamente conquistata, con le tribù nomadi decimate dai bombardamenti e dalla fame.Diversa, invece, la situazione in Cirenaica dove i guerriglieri senussiti, grazie a una efficiente organizzazione, dominano ancora il Gebel, l'altopiano centrale della regione.I gruppi di armati (duar), composti ciascuno di 3-400 uomini, davanti ai rastrellamenti italiani si nascondevano nei numerosi burroni del Gebel per poi riapparire dietro le linee italiane colpendo le installazioni militari. Qualche tentativo di trattare con i ribelli di Omar al-Mukhtar fu messo in atto nel giugno del 1929 dal vice-governatore Siciliani. Si concordò anche una tregua, che però non durò a lungo.Nel 1930 Mussolini, insoddisfatto di come andavano le cose in Cirenaica, inviò Rodolfo Graziani come vice governatore a Bengasi. Il risultato fu una grande operazione di rastrellamento la quale, tuttavia, non diede l'esito sperato. I "mujaheddin" di Omar al-Mukhtar potevano infatti contare sull'appoggio morale e materiale delle popolazioni locali. Dirà due anni dopo Graziani: «Avevamo contro di noi tutta la popolazione della Cirenaica che partecipava alla ribellione: da una parte, allo stato potenziale, i cosiddetti sottomessi; dall'altra, apertamente in campo, gli armati. Tutta la Cirenaica, in una parola, era ribelle».
Per rompere il collegamento tra popolazione e guerriglia non era sufficiente neanche l'esproprio integrale dei beni mobili e immobili delle zavie senussite, veri e propri centri spirituali ed assistenziali. Il 29 maggio i reali carabinieri penetrarono contemporaneamente nelle 49 zavie, arrestando 31 capi zavia e mettendo i sigilli alle proprietà (centinaia di abitazioni e circa 70.000 ettari di buona terra). I religiosi, dopo essere stati confinati in alcuni campi presso Benina, vennero quindi imbarcati per Ustica. Ma l'impostazione "tradizionale" della repressione messa in atto da Graziani non
Rodolfo Graziani
soddisfece Badoglio, che il 20 giugno 1930 scrisse al vice governatore per sollecitare nuovi metodi: «Bisogna anzitutto creare un distacco territoriale largo e ben preciso tra formazioni ribelli e popolazione sottomessa. Non mi nascondo la portata e la gravità di questo provvedimento, che vorrà dire la rovina della popolazione cosiddetta sottomessa. Ma ormai la via ci è stata tracciata e noi dobbiamo perseguirla sino alla fine anche se dovesse perire tutta la popolazione della Cirenaica. Urge dunque far rifluire in uno spazio ristretto tutta la popolazione sottomessa, in modo da poterla adeguatamente sorvegliare ed in modo che vi sia uno spazio di assoluto rispetto fra essa e i ribelli. Fatto questo allora si passa all'azione diretta contro i ribelli».Solo cinque giorni dopo Graziani ordinò il trasferimento delle popolazioni del Gebel. Iniziò così un massiccio spostamento dall'altipiano verso la costa: 900 tende Abid furono spostate nella piana di Barce, 1.400 tende Dorsa intorno a Tolmeta, altre 3.600 distribuite fra Cirene e Derna. Ma per completare quella che sarà la deportazione di ben 100.000 civili, quasi la metà dell'intera popolazione della Cirenaica, saranno necessarie ulteriori tappe. Il 16 luglio Badoglio diramò a Graziani le seguenti istruzioni: «1) Riunire tutti i parenti dei ribelli in uno stretto e molto sorvegliato campo di concentramento, ove le loro condizioni siano piuttosto disagiate. 2) Arrestare nelle varie cabile ed in Bengasi i notabili che notoriamente hanno esplicato azione contraria a noi e mandarli al confino in Italia».Graziani stesso, come racconterà in seguito, non ebbe alcuna esitazione: «Tutti i campi furono circondati da doppio reticolato; i viveri razionati; i pascoli contratti e controllati; la circolazione esterna resa soggetta a permessi speciali. Furono concentrati nel campo di el Agheila tutti i parenti dei ribelli, perché più facilmente portati alla connivenza [.] I capi e le popolazioni refrattarie e sorde ad ogni voce di persuasione e di richiamo ricevevano così il trattamento che si erano meritato. Il rigore estremo, senza remore né tregua, cadeva inesorabile su di esse».
Naturalmente la responsabilità della deportazione non va ascritta al solo Badoglio ma anche, come puntualizza Angelo Del Boca, al ministro De Bono che aveva da tempo sollecitato la misura e allo stesso Mussolini che l'aveva approvata.Le varie tribù, con vecchi, donne e bambini, furono sottoposte a terribili marce forzate per centinaia di chilometri che si trasformarono in vere e proprie "marce di sterminio". Chi indugiava o si attardava nelle poche soste viene immediatamente abbattuto. Numerosi gli episodi di crudeltà gratuita, come l'abbandono di 35 indigeni, tra cui donne e bambini, in pieno deserto, senza acqua né viveri, a causa di una rissa scoppiata tra loro. Senza contare i maltrattamenti, le fustigazioni, i morti per sete. La tribù degli Auaghir raggiunse il campo di concentramento di Soluch, circondato dal filo spinato, dopo 350 chilometri di marce forzate. Circa 6.500 tra Abeidat e Marmarici, che avevano tentato di ribellarsi, furono sottoposti a una marcia di 1.100 chilometri in pieno inverno verso la Sirtica. Secondo Del Boca furono 90.761 le persone giunte nei campi e quasi 10.000 quelle morte durante la marcia per stenti, mancanza di cibo, malattie e tentativi di fuga. Dopo le deportazioni e la creazione dei campi di concentramento la resistenza dei duar di Omar al Mukhtàr si trovò sempre più isolata. I gruppi ribelli furono costretti a dividersi per sfuggire agli accerchiamenti, riducendo però in tal modo la loro capacità offensiva. Le sconfitte minarono il morale e a nulla servirono le scorrerie delle bande di Abd el Gelil Sef en-Nasser e Saleh el Atèusc, rifugiatesi nell'oasi di Taizerbo, situata 250 chilometri a nordovest di Cufra.Ed è proprio su quest'oasi, dove si pensava fossero ancora i ribelli, che si concentrò l'attenzione italiana. Il 31 luglio 1930 quattro aerei al comando del tenente colonnello Roberto Lordi partono da Gialo con l'ordine di distruggere Taizerbo. Vengono lanciate 24 bombe da 21 chili caricate a iprite e 12 bombe da 12 chili e 320 da 2 chili con esplosivo convenzionale.Anche Cufra, città santa dei senussiti nella Libia sudorientale, dove intanto si erano ritirate le bande ribelle di Abd el Gelli Sef en-Nasser e Saleh el Atèusc, subì un attacco dal cielo prima di essere presa nel gennaio del 1931 da una colonna di "meharisti", mercenari libici su cammelli e autocarri.I guerriglieri sopravvissuti fuggirono con le proprie famiglie ma i reparti cammellati e l'aviazione li inseguirono per vari giorni fino ad annientarli in gran parte: tra le vittime anche donne e bambini. Cufra fu sottoposta a tre giorni di saccheggi e violenze: 17 capi senussiti furono impiccati, 35 indigeni evirati e lasciati morire dissanguati, 50 donne stuprate; si registrarono anche 50 fucilazioni e 40 esecuzioni con ascia, baionette e sciabole. Le truppe vittoriose si abbandonarono a ogni atrocità: alle donne incinte venne squartato il ventre e i feti infilzati, giovani furono donne violentate e sodomizzate con le candele, teste e testicoli mozzati portati in giro come trofei, tre bambini immersi in calderoni di acqua bollente, ad alcuni vecchi vennero estirpate le unghie per essere poi accecati.
Nonostante la caduta di Cufra, che generò un'ondata di sdegno in tutto il mondo
Pietro Badoglio
islamico, Omar al Mukhtàr continuò a resistere con le poche truppe rimaste grazie, secondo Graziani, al contrabbando con la frontiera egiziana. E' a questo punto che Badoglio e Graziani decidono di isolare del tutto i ribelli con la costruzione di una recinzione tra la Cirenaica e l'Egitto.Nonostante il parere contrario di De Bono e del sottosegretario alle Colonie Roberto Cantalupo, Mussolini dà il suo via libera e il reticolato - una barriera di filo spinato larga alcuni metri e lunga ben 270 chilometri, dal porto di Bardia all'oasi di Giarabub - viene costruito in sei mesi, da aprile a settembre del 1931. Bloccato ogni rifornimento, dunque, le bande ribelli erano destinate a soccombere. Il 9 settembre 1931 il settantatreenne capo della resistenza libica Omar al Mukhtàr venne catturato. La condanna a morte fu pronunciata il 16 settembre. Ferito, inutilmente tutelato dal diritto internazionale che avrebbe imposto un suo trattamento come prigioniero di guerra, fu impiccato nel campo di Soluch. Graziani raccontò che 20.000 beduini furono costretti ad assistere all'esecuzione per dimostrare loro che i giorni del compromesso e della debolezza italiana erano terminati.Dando per buono il censimento della Cirenaica del 1920 che annotava 225.000 abitanti e tenendo conto che 20.000 fuggirono in Egitto, ricordando poi il censimento italiano del 1931 che registrava solo 142.000 anime (oltre a 18.500 italiani), si deve dedurre che in undici anni la popolazione del Paese diminuì di circa 83.000 persone: 20.000 rifugiate in Egitto e ben 63.000 per la guerra, la deportazione e la prigionia.Anche il patrimonio zootecnico venne ampiamente distrutto: gli ovini da 800.000 nel 1926 si ridussero a 98.000 nel 1933, i cammelli da 75.000 a 2.600, i cavalli da 14.000 a 1.000, gli asini da 9.000 a 5.000.Una vera e propria carneficina, dunque, o, per meglio dire, un "genocidio" praticato dal "buon italiano" il cui ricordo risulta ancora rimosso dalla memoria collettiva dell'Italia nonostante gli sforzi di quegli storici che l'additano all'attenzione di chi non ha paura della verità.
BIBLIOGRAFIA
Ali italiane sul deserto, di V. Biani - Bemporad, Firenze 1933.
Storia dell'Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre, di G. Candeloro - Feltrinelli, Milano 2002.
Gli italiani in Libia. Tripoli bel suol d'amor, di A. Del Boca - Mondadori, Milano 1984.
Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi, di A. Del Boca - Laterza, Roma-Bari 1991.
Cirenaica pacificata, di R. Graziani - Mondadori, Milano 1932.
Gli italiani e il colonialismo. I campi di detenzione italiani in Africa, di G. Ottolenghi - Sugarco, Milano 1997.
Pietro Badoglio, di P. Pieri e G. Rochat - UTET, Torino 1974.
Guerre italiane in Libia e in Etiopia. Studi militari 1921-1939, di G. Rochat - Pagus, Treviso 1991.
Genocidio in Libia. Le atrocità nascoste dell'avventura coloniale (1911-1931), di E. Salerno - Manifestolibri, Roma 2005.
Omar al-Mukthar e la riconquista fascista della Libia, di E. Santarelli, G. Rochat, R. Rainero, L. Goglia - Marzorati, Milano 1981
domenica 29 agosto 2010
Il Tallone di Ferro di Jack London. Secondo capitolo
Capitolo 2
SFIDE
Quando gli invitati andarono via, mio padre si lasciò cadere su una sedia e s'abbandonò a una risata pantagruelica. Dalla morte di mia madre non lo avevo mai visto ridere così di cuore.
"Scommetto che il reverendo Hammerfield non s'è mai trovato in una situazione del genere in vita sua", disse fra le risa. "Il tono cortese delle dispute ecclesiastiche! Hai notato che sulle prime sembrava una pecorella, parlo di Everhard, per mutarsi subito dopo in un leone ruggente? Ha un notevole rigore intellettuale, quell'uomo; sarebbe diventato uno scienziato di prim'ordine se avesse indirizzato le sue energie in tal senso".
Non sarà necessario dire, a questo punto, che Ernest Everhard mi interessava molto: non soltanto per quanto aveva detto, e per il modo in cui l'aveva detto, ma per se stesso, come uomo. Non avevo mai incontrato uno come lui, e credo che per questo, a ventiquattro anni compiuti, non ero ancora sposata. Mi piaceva, dovetti ammetterlo, e questa mia simpatia era dovuta non alla sua intelligenza e alla sua dialettica, ma ad altro. Nonostante quei suoi muscoli e quel suo torace da pugile, mi aveva fatto l'impressione di un giovane dall'animo puro. Sentivo che sotto quell'apparenza del chiacchierone intellettuale, c'era un animo, uno spirito delicato e sensibile. Lo avvertivo, in modo che potevo attribuire soltanto al mio intuito femminile.
C'era nel suo dire tonante qualcosa che mi era andato a cuore, e mi sembrava sempre di udirlo. Desideravo udirlo ancora, vedere ancora nei suoi occhi quel lampo di gaiezza che smentiva l'impassibilità del resto del viso. E ancora altri sentimenti vaghi, indistinti, ma più profondi, si agitavano in me. Quasi lo amavo già, sebbene sia sicura che, se non lo avessi più rivisto, quel vago sentimento si sarebbe spento e, facilmente, avrei finito col dimenticarlo.
Ma non era nel mio destino non rivederlo più: il nuovo interesse che mio padre aveva preso a nutrire per la sociologia, e i pranzi che dava regolarmente, non lo avrebbero permesso. Mio padre non era un sociologo. Il suo matrimonio con mia madre era stato felice, e felice lo avevano reso le sue ricerche di fisica; ma dopo la morte di mia madre quelle ricerche non erano più riuscite a colmare l'orribile vuoto. Si era occupato di filosofia, con poco interesse agli inizi, poi con sempre maggiore impegno, finendo con l'occuparsi di economia politica e scienze sociali. Possedeva un vivo sentimento della giustizia, e così non tardò ad accendersi di passione per la riparazione dei torti. Dal canto mio, notavo con somma gioia questi segni di rinascente interesse per la vita, pur non immaginando quale sarebbe stato il risultato. Con l'entusiasmo di un ragazzo, s'immerse così in nuove ricerche, senza neppure chiedersi dove l'avrebbero portato.
Abituato da sempre al lavoro di laboratorio, aveva dunque trasformato la sala da pranzo in un laboratorio di sociologia: vi si trovava riunita gente di ogni tipo e condizione: scienziati, uomini politici, banchieri, commercianti, professori, sindacalisti, socialisti e anarchici. Lui li sollecitava alla discussione e analizzava le loro idee sulla vita e sulla società.
Aveva conosciuto Ernest poco tempo prima della "serata dei predicatori", e dopo che gli ospiti furono andati via seppi come l'aveva conosciuto. Una sera, per strada, si era fermato ad ascoltare un uomo che, in piedi su una cassetta di legno, parlava a un gruppo di operai. Era Ernest. Ma non era un oratore da strapazzo. Era molto apprezzato dalla direzione del partito socialista, considerato uno dei dirigenti e riconosciuto come tale dai dottrinari del socialismo. Aveva il dono di presentare in forma semplice e chiara anche i problemi ardui, era un educatore nato e non credeva di avvilirsi salendo su una cassetta di legno per spiegare l'economia politica ai lavoratori.
Mio padre s'era dunque fermato ad ascoltarlo ed era rimasto interessato. Aveva poi avvicinato l'oratore, s'era presentato e lo aveva invitato al pranzo dei reverendi. E solo dopo quel pranzo mi rivelò il poco che era riuscito a sapere. Era figlio di operai, sebbene discendesse da un'antica famiglia stabilitasi da più di duecento anni in America (1). A dieci anni aveva cominciato a lavorare in fabbrica e in seguito aveva imparato il mestiere di maniscalco. Era un autodidatta, aveva studiato il francese e il tedesco, e a quel tempo si guadagnava modestamente la vita traducendo opere scientifiche e filosofiche per una traballante casa editrice socialista di Chicago. Arrotondava poi il guadagno con i diritti ricavati dalla vendita, ristretta, delle proprie opere di economia e filosofia.
Questo appresi su di lui quella sera prima di andare a letto, dove stetti a lungo sveglia ascoltando ancora, nel ricordo, il suono della sua voce. Mi spaventai dei miei stessi pensieri. Somigliava così poco agli uomini della mia classe! Sembrava così estraneo, così forte! La sua padronanza di sé mi piaceva e insieme mi spaventava, e la mia fantasia galoppava tanto che mi sorpresi a considerarlo come amante e come marito. Avevo sempre sentito dire che la forza degli uomini è un'attrattiva irresistibile per le donne; ma Ernest era troppo forte. "No, no!" esclamai, "è impossibile, è assurdo!". E il giorno dopo, svegliandomi, provai il desiderio fortissimo di rivederlo, di assistere alla sua vittoria in una nuova discussione, di vibrare ancora al suono bellissimo della sua voce, di ammirarlo nella sua sicurezza e nella sua forza, quando spezzava la loro albagia e distoglieva il loro pensiero dal solito circolo vizioso. Che importavano le sue smargiassate? Come lui stesso aveva detto, "funzionavano", erano efficaci. Inoltre, erano belle a sentirsi, eccitanti come l'inizio di una battaglia.
Passarono parecchi giorni durante i quali lessi i libri di Ernest prestatimi da mio padre. Scritta, la sua parola era come quella parlata, chiara e convincente. La sua semplicità assoluta ti convinceva anche se il tuo dubbio continuava. Aveva il dono della lucidità, di esporre in maniera perfetta. E tuttavia, nonostante il suo stile, molte cose non mi piacevano. Dava troppa importanza a ciò che chiamava la lotta di classe, all'antagonismo fra lavoro e capitale, al conflitto degli interessi.
Mio padre, compiaciuto, mi riferì il giudizio del dottor Hammerfield su Ernest: "Un botolo insolente reso borioso da poca e inadeguata preparazione". Inoltre, il dottor Hammerfield si rifiutava di rivederlo.
Il vescovo Morehouse, invece, era rimasto molto colpito, ed era ansioso di incontrarlo di nuovo. "Un giovane forte", aveva dichiarato, "e vivace, molto vivace. Ma troppo sicuro di sé, troppo sicuro!".
Ernest ritornò un pomeriggio, in compagnia di mio padre. Il vescovo era già arrivato e stavamo prendendo il tè sulla veranda.
La prolungata presenza di Ernest a Berkeley, tra l'altro, era dovuta al fatto che seguiva dei corsi speciali di biologia all'università; in più, a quel tempo lavorava intensamente a una nuova opera intitolata: "Filosofia e Rivoluzione" (2).
Quando entrò, improvvisamente la veranda parve troppo piccola. Non perché lui fosse molto alto (era alto un metro e settantadue), ma perché sembrava irradiare un'atmosfera di grandezza. Nel salutarmi, tradì una lieve esitazione che contrastava stranamente con il suo sguardo ardito e la sua stretta di mano ferma e sicura.
I suoi occhi non erano meno sicuri, ma, questa volta, sembravano interrogare, mentre mi guardavano, come il primo giorno, indugiando un po' troppo.
"Ho letto il suo libro: 'Filosofia della classe lavoratrice'", dissi, e scorsi nei suoi occhi un lampo di compiacimento.
"Naturalmente", rispose, "avrà tenuto conto del pubblico al quale è rivolto".
"Sì, e appunto per questo non sono d'accordo con lei".
"Neppure io", disse il vescovo Morehouse, "sono d'accordo con lei".
Ernest scrollò le spalle con aria rassegnata, e accettò una tazza di tè.
Il vescovo mi cedette la parola con un inchino.
"Lei fomenta l'odio di classe", cominciai. "E a me pare un errore, un delitto, fare appello a tutto ciò che vi è di limitato e brutale nella classe operaia. L'odio di classe è anti-sociale".
"Proclamo la mia innocenza", rispose lui. "Non c'è odio di classe né nel testo né nello spirito di nessuna mia opera".
"Oh!" esclamai con aria di rimprovero. Presi il libro e lo aprii.
Lui sorseggiava il tè e mi sorrideva, mentre io sfogliavo le pagine.
"Pagina centotrentadue", dissi, e lessi ad alta voce: "'Pertanto, nell'attuale stadio dello sviluppo sociale, tra i datori di lavoro e i salariati esiste lotta sociale'!".
Lo guardai con aria di trionfo.
"Ma non vi si parla di odio di classe", rispose lui, sorridendo.
"Ma parla di 'lotta di classe'".
"Non sono certo la stessa cosa. Mi creda, noi non fomentiamo l'odio. Sosteniamo soltanto che la lotta di classe è una legge dell'evoluzione sociale. Non ne siamo responsabili. Non è una nostra invenzione. Ci limitiamo a spiegarla, come Newton spiegava la gravitazione. Noi esaminiamo la natura del conflitto d'interessi che provoca la lotta di classe".
"Ma non dovrebbe esserci nessun conflitto d'interessi!" esclamai.
"Sono perfettamente d'accordo con lei", rispose. "E noi socialisti tendiamo appunto all'abolizione di questo conflitto di interessi.
Scusi, mi lasci leggere un altro punto". Prese il libro e ne voltò alcuni fogli. "Pagina centoventisei: 'Il ciclo della lotta di classe, iniziato con la dissoluzione del comunismo primitivo della tribù e la nascita della proprietà privata, si concluderà con l'abolizione della proprietà individuale dei mezzi dell'esistenza sociale'".
"Non sono d'accordo con lei", lo interruppe il vescovo, tradendo con un lieve rossore nel volto ascetico l'intensità dei suoi sentimenti. "Le sue premesse sono false. Non esiste conflitto d'interessi fra lavoro e capitale, o, almeno, non dovrebbe esistere".
"La ringrazio", disse con aria grave Ernest, "di avermi restituito le mie premesse con questa sua affermazione".
Ma perché dovrebbe esserci conflitto?" incalzò il vescovo con calore.
Ernest si strinse nelle spalle.
"Perché siamo fatti così, immagino".
"Ma non siamo fatti così!" esclamò l'altro.
"Stiamo forse parlando dell'uomo ideale, divino, privo di egoismo?" ribatté Ernest. "Ce n'è tanto pochi che si possono considerare inesistenti. Oppure dell'uomo comune, ordinario?".
"Dell'uomo ordinario".
"Debole, fallibile e soggetto a errare?".
Il vescovo Morehouse annuì.
"E meschino, egoista?" Il prelato annuì ancora.
"Badi bene", avvertì Ernest. "Ho detto 'egoista'".
"L'uomo comune è egoista", affermò il vescovo con calore.
"Che vuole avere tutto ciò che può?".
"Vuole avere il più possibile. E' deplorevole, ma è vero".
"Allora ci è cascato". La mascella di Ernest scattò come una trappola. "Glielo dimostro. Prenda un uomo che lavora sui tram".
"Non potrebbe lavorare se non ci fosse il capitale", l'interruppe il vescovo.
"E' vero, ma ammetterà che il capitale perirebbe se non guadagnasse i suoi dividendi sulla mano d'opera".
Il vescovo non rispose.
"Non è d'accordo?" insistette Ernest.
Il prelato annuì.
"Allora le nostre due proposizioni si annullano reciprocamente, e ci troviamo al punto di partenza. Ricominciamo. I tranvieri forniscono la mano d'opera e gli azionisti il capitale. Da quest'unione del lavoro col capitale nasce il guadagno (3).
Entrambi si dividono questo guadagno: la parte che tocca al capitale si chiama dividendo, quella che tocca al lavoro si chiama salario".
"Benissimo", l'interruppe il vescovo. "Ma non c'è motivo perché questa divisione non avvenga amichevolmente".
"Ha già dimenticato le premesse", replicò Ernest. "Eravamo d'accordo nell'ammettere che l'uomo ordinario è egoista. L'uomo ordinario è quello che è. Ora invece lei parte per la tangente e vuol fare una distinzione fra quest'uomo e gli uomini come dovrebbero essere, ma come non sono in realtà. Ritorniamo sulla terra: il lavoratore, essendo egoista, vuole avere quanto più può nella divisione; il capitalista, essendo egoista, vuole, del pari, avere tutto ciò che può prendere. Quando una cosa esiste in quantità limitata, e due uomini vogliono averne ciascuno la parte maggiore, nasce un conflitto d'interessi. E' il conflitto che esiste fra capitale e lavoro, ed è uno scontro inconciliabile.
Finché esisteranno operai e capitalisti, litigheranno per la divisione del guadagno. Se fosse stato a San Francisco questo pomeriggio, sarebbe stato costretto ad andare a piedi, non circola neppure un tram".
"Un altro sciopero?" (4) domandò il vescovo, allarmato.
"Sì, litigano per l'equa divisione dei guadagni delle tranvie".
Il vescovo si irritò.
"Hanno torto!" esclamò. "Gli operai non vedono al di là del loro naso. Come possono sperare di conservare la nostra simpatia?...".
"Quando ci obbligano ad andare a piedi", disse maliziosamente Ernest.
E il vescovo concluse senza badargli:
"Il loro punto di vista è troppo meschino. Gli uomini devono agire da uomini e non da bestie. Ci saranno ancora violenze e uccisioni, e vedove e orfani addolorati. Capitale e lavoro dovrebbero essere uniti, dovrebbero procedere insieme, per il reciproco interesse".
"Ecco che parte di nuovo per la tangente", osservò freddamente Ernest. "Vediamo di ritornare sulla terra e di non perdere di vista la nostra asserzione: l'uomo è egoista".
Ma non dovrebbe esserlo!" esclamò il vescovo.
"Su questo punto sono d'accordo con lei. Non dovrebbe essere egoista, ma lo sarà sempre finché vivrà in un sistema sociale fondato su una morale meschina".
Il prelato parve spaventato; mio padre entro di sé rideva.
"Sì, una morale meschina", riprese Ernest, senza esitazioni. "Ed è l'ultima parola del vostro sistema capitalistico, è ciò che sostiene la vostra chiesa, ciò che voi predicate ogni volta che salite sul pulpito: meschina, non c'è altro nome".
Il vescovo si rivolse per aiuto a mio padre, il quale scosse il capo, ridendo.
"Credo che il signor Everhard abbia ragione", disse poi. "E' la politica del 'laissez-faire', dell'ognuno per sé e dio per tutti.
Come disse l'altra sera il signor Everhard, il compito di voi gente di chiesa consiste nel mantenere l'ordine stabilito e la società è fondata su questo principio!".
"Ma questo non è l'insegnamento di Cristo!" esclamò il vescovo.
"Oggi la chiesa non insegna la dottrina di Cristo", rispose Ernest. "Per questo gli operai non vogliono niente a che farci. La chiesa approva la terribile brutalità, la ferocia con la quale il capitalista tratta la classe lavoratrice".
"Non l'approva affatto", obiettò il vescovo.
"Ma non protesta neppure", replicò Ernest "e perciò approva, perché non bisogna dimenticare che la chiesa è sostenuta dalla classe capitalistica".
"Non avevo mai considerato la cosa da questo punto di vista", disse ingenuamente il vescovo. "Ma credo che sbagli. So che le tristezze e le brutture del mondo sono molte; so che la chiesa ha perduto il... quello che voi chiamate proletariato" (5).
"Non è mai stato con voi", esclamò Ernest. "Si è sviluppato fuori della chiesa e senza di essa".
"Non la seguo più", replicò debolmente il vescovo.
"Le spiego. Dopo l'introduzione della macchina e del sistema industriale, verso la fine del diciottesimo secolo, la grande massa dei lavoratori fu allontanata dalla terra e l'antico sistema di lavoro mutò. Tolti dai loro villaggi, i lavoratori si trovarono rinchiusi nelle città industriali; le madri e i fanciulli furono messi a lavorare alle nuove macchine; la vita di famiglia cessò e le condizioni divennero atroci. E' una pagina di storia scritta con sangue e lacrime".
"Lo so", l'interruppe il vescovo, con un'espressione d'angoscia in viso. "Fu terribile, ma ciò avvenne in Inghilterra, un secolo e mezzo fa".
"E lì, un secolo e mezzo fa, nacque il proletariato moderno", continuò Ernest. "Mentre il paese veniva trasformato dai capitalisti in un vero e proprio macello, la chiesa taceva, non protestò allora come non protesta oggi. Come dice Austin Lewis (6), parlando di quell'epoca, coloro che avevano ricevuto il comandamento: 'Pascete i miei agnelli', hanno assistito senza protestare alla vendita e al massacro di quegli agnelli (7). Prima di continuare la prego di dirmi sinceramente se è o no d'accordo.
La chiesa protestò a quel tempo?".
Il vescovo Morehouse esitò: come il dottor Hammerfield, non era abituato a quel violento "corpo a corpo", come lo chiamava Ernest.
"La storia del secolo diciottesimo è stata scritta", suggerì questi. "Se la chiesa tacque allora, non avrà taciuto anche nei libri".
"Purtroppo temo che sia rimasta muta", ammise il prelato.
"E rimane muta anche oggi".
"Su questo non sono d'accordo".
Ernest tacque, guardò attentamente il suo interlocutore e accettò la sfida.
"Benissimo", disse, "vedremo. Ci sono, a Chicago, donne che lavorano tutta la settimana per novanta centesimi. Protesta forse la chiesa?".
"E' una novità per me", fu la risposta. "Novanta centesimi? E' orribile!".
"La chiesa ha forse protestato?" insistette Ernest.
"La chiesa lo ignora". Il vescovo appariva penosamente agitato.
"Eppure la chiesa ha ricevuto il comandamento: 'Pasci i miei agnelli!'" disse Ernest, con amara ironia. Poi, riprendendosi:
"Perdoni la mia ironia, monsignore, ma c'è da meravigliarsi se perdiamo la pazienza con voi? Avete forse protestato presso le vostre congreghe capitalistiche per l'impiego dei fanciulli nelle filande di cotone del Sud? (8). Bimbi di sei o sette anni lavorano tutte le notti, in turni di dodici ore: non vedono mai la santa luce del giorno, e muoiono come mosche. I dividendi sono pagati con il loro sangue e con quel denaro si costruiscono chiese magnifiche nel New England, nelle quali voi predicate piacevoli banalità ai lustri e panciuti beneficiari di quei dividendi".
"Non sapevo", mormorò il vescovo, con un filo di voce e il viso pallido, come se soffrisse di nausea.
"E quindi non avete protestato, vero?".
Il vescovo fece un debole cenno di diniego.
"Così la chiesa tace oggi come tacque nel secolo diciottesimo".
Il vescovo non rispose e, per una volta tanto, Ernest non insistette oltre.
"E non dimentichi; ogni volta che un membro del clero protesta, lo si congeda".
"Questo non mi sembra giusto".
"Lei protesterebbe?".
"Fatemi vedere, nella vostra comunità, dei mali come quelli di cui ha parlato lei e io farò sentire la mia voce".
"Mi metto a sua disposizione per mostrarglieli", rispose tranquillamente Ernest. "Le farò fare un viaggio attraverso l'inferno".
"E io protesterò!". Il vescovo si era raddrizzato sulla sedia e il dolce viso gli si tese nella fiera durezza del guerriero. "La chiesa non rimarrà muta".
"Sarà congedato", lo avvertì Ernest.
"Le fornirò la prova del contrario", replicò l'altro. "Le dimostrerò che, se tutto ciò che dice è vero, la chiesa ha sbagliato per ignoranza; che tutto quanto c'è di orribile nella società industriale è dovuto all'ignoranza della classe capitalistica. Essa rimedierà al male appena riceverà il messaggio che la chiesa avrà il dovere di comunicarle".
Ernest scoppiò a ridere, una risata così brutale che mi sentii portata a prendere le difese del vescovo.
"Ricordi", dissi, "che lei vede un solo lato della medaglia. Anche se lei non ci crede capaci di bontà, sappia che c'è molto di buono in noi. Il vescovo Morehouse ha ragione. I mali dell'industria, per quanto terribili, sono dovuti all'ignoranza. Le diversità delle condizioni sociali sono troppo profonde".
"L'indiano selvaggio è meno crudele e meno implacabile della classe capitalistica", rispose lui, e in quel momento l'odiai.
"Lei non ci conosce, non siamo né crudeli né implacabili".
"Lo dimostri", disse lui, in tono di sfida.
"Come posso dimostrarlo... a lei?". Cominciavo a irritarmi.
Scosse il capo. "Non pretendo che lo dimostri a me; le chiedo di dimostrarlo a se stessa".
"So cosa pensare in proposito".
"Non sa proprio nulla", rispose lui, brutalmente.
"Andiamo, andiamo, figlioli", disse mio padre, conciliante.
"Me ne infischio..." cominciai, indignata; ma lui mi interruppe.
"Credo che lei abbia dei capitali investiti nelle filande Sierra; o che li abbia suo padre, il che è lo stesso".
"Cosa c'entra questo?" esclamai.
"Non molto", rispose lui, parlando lentamente, "solo che l'abito che indossa è macchiato di sangue. Le travi del tetto che vi ripara, gocciolano del sangue di fanciulli e di giovani validi e forti. Mi basta chiudere gli occhi per sentirlo colare goccia a goccia, intorno a me".
E accompagnando la parola con il gesto, si allungò nella poltrona e chiuse gli occhi.
Scoppiai in lacrime, per la mortificazione e la vanità ferita. Non ero mai stata trattata tanto brutalmente in vita mia. Anche il vescovo e mio padre erano a disagio e turbati. Cercarono di sviare la conversazione rivolgendola verso un argomento meno scottante, ma Ernest aprì gli occhi, mi guardò e volse altrove lo sguardo. La piega della sua bocca era severa, e il suo sguardo anche; non c'era nei suoi occhi il minimo lampo di gaiezza. Cosa stesse per dire, quale nuova crudeltà stesse per infliggermi, non l'avrei mai saputo, perché in quell'istante un uomo che passava sul marciapiede si fermò a guardarci. Era un giovane robusto, vestito poveramente, che portava sulla schiena un pesante carico di cavalletti, sedie e parafuochi di bambù e panno. Guardava la casa come se non osasse entrare per tentare di vendere la sua merce.
"Quell'uomo si chiama Jackson", disse Ernest.
"Robusto com'è," osservai seccamente, "dovrebbe lavorare, invece di fare il merciaio ambulante" (9).
"Osservi la sua manica sinistra", disse Ernest gentilmente.
Gettai uno sguardo e vidi che la manica del giovane era vuota .
"Anche da quel braccio scorre un po' del sangue che sentivo gocciolare dal vostro soffitto", continuò lui, con lo stesso tono dolce e triste. "Ha perduto il braccio nella filanda Sierra, e voi l'avete gettato sul lastrico a morire come un cavallo mutilato.
Dicendo voi, intendo il direttore e le altre persone impiegate da voi e gli altri azionisti che dirigono per voi le filande. Fu una disgrazia, dovuta allo zelo di quell'operaio per far risparmiare qualche dollaro all'azienda. Il braccio gli venne preso dal cilindro dentato della cardatrice. Avrebbe potuto lasciar passare il sassolino che aveva notato fra i denti della macchina, avrebbe spezzato una doppia fila di punte; volle invece toglierlo e il braccio gli si impigliò e fu sfracellato, dalla punta delle dita alla spalla. Era notte: nella filanda si facevano turni straordinari di lavoro. In quel trimestre fu pagato un forte dividendo. Quella notte Jackson lavorava da molte ore e i suoi muscoli avevano perduto la solita vivacità: per questo venne afferrato dalla macchina. Ha moglie e tre bambini".
"E che cosa fece la società per lui?" chiesi.
"Assolutamente niente. No, mi scusi, qualcosa ha fatto. E' riuscita a far respingere l'istanza per danni e interessi che l'operaio aveva presentato quando uscì dall'ospedale. La società ha degli avvocati abilissimi".
"Non ha detto tutto", feci con convinzione, "e forse non conoscete tutta la storia. Forse quell'uomo era un insolente".
"Insolente! Ah! Ah!". Quella sua risata era mefistofelica. "Gran dio, insolente col braccio sfracellato! Era un servitore dolce e umile, e non risulta che sia mai stato un insolente".
"Ma il tribunale", insistetti, "non avrebbe deciso in suo sfavore se non ci fosse sotto qualcos'altro".
"Il principale avvocato consulente della società è il colonnello Ingram, un uomo di legge, molto abile".
Mi guardò con aria grave per un momento, quindi continuò:
"Voglio darle un consiglio, signorina Cunnigham: fare un'inchiesta sul caso Jackson".
"Avevo già deciso di farlo", risposi, gelida.
"Benissimo", ribatté lui, allegro. "E le dirò dove potrà trovare il nostro uomo. Ma fremo al pensiero della conclusione alla quale arriverà grazie al braccio di Jackson".
E così il vescovo e io accettammo la sfida di Ernest. Poco dopo se ne andarono, insieme, lasciandomi scossa per l'ingiustizia fatta alla mia classe sociale e a me stessa. Quel giovanotto era un bruto. Lo odiavo, in quel momento, e mi consolavo al pensiero che la sua condotta era come bisognava aspettarsela da un membro della classe operaia.
NOTE:
1) A quei tempi, la distinzione fra le famiglie natie nel paese e quelle venute di fuori, era nettamente e gelosamente segnata.
2) Questo libro continuò a essere stampato clandestinamente durante i tre secoli del Tallone di Ferro. Parecchie copie delle sue diverse edizioni si trovano nella biblioteca nazionale di Ardis.
3) A quel tempo, gruppi di uomini rapaci controllavano tutti i mezzi di trasporto, per il cui uso imponevano tariffe al pubblico.
4) Queste manifestazioni erano molto diffuse in quei tempi di caos e anarchia. A volte gli operai rifiutavano di lavorare, altre volte i capitalisti rifiutavano di lasciare lavorare gli operai.
Nella violenza e nel disordine di questi dissidi, molta proprietà veniva distrutta e molte vite umane perivano. Tutto questo oggi ci sembra inconcepibile come inconcepibile ci risulterebbe l'altra abitudine di quel tempo, quella dei mariti di fracassare mobili quando litigavano con le mogli.
5) "Proletariato" - dal latino "proletarius
SFIDE
Quando gli invitati andarono via, mio padre si lasciò cadere su una sedia e s'abbandonò a una risata pantagruelica. Dalla morte di mia madre non lo avevo mai visto ridere così di cuore.
"Scommetto che il reverendo Hammerfield non s'è mai trovato in una situazione del genere in vita sua", disse fra le risa. "Il tono cortese delle dispute ecclesiastiche! Hai notato che sulle prime sembrava una pecorella, parlo di Everhard, per mutarsi subito dopo in un leone ruggente? Ha un notevole rigore intellettuale, quell'uomo; sarebbe diventato uno scienziato di prim'ordine se avesse indirizzato le sue energie in tal senso".
Non sarà necessario dire, a questo punto, che Ernest Everhard mi interessava molto: non soltanto per quanto aveva detto, e per il modo in cui l'aveva detto, ma per se stesso, come uomo. Non avevo mai incontrato uno come lui, e credo che per questo, a ventiquattro anni compiuti, non ero ancora sposata. Mi piaceva, dovetti ammetterlo, e questa mia simpatia era dovuta non alla sua intelligenza e alla sua dialettica, ma ad altro. Nonostante quei suoi muscoli e quel suo torace da pugile, mi aveva fatto l'impressione di un giovane dall'animo puro. Sentivo che sotto quell'apparenza del chiacchierone intellettuale, c'era un animo, uno spirito delicato e sensibile. Lo avvertivo, in modo che potevo attribuire soltanto al mio intuito femminile.
C'era nel suo dire tonante qualcosa che mi era andato a cuore, e mi sembrava sempre di udirlo. Desideravo udirlo ancora, vedere ancora nei suoi occhi quel lampo di gaiezza che smentiva l'impassibilità del resto del viso. E ancora altri sentimenti vaghi, indistinti, ma più profondi, si agitavano in me. Quasi lo amavo già, sebbene sia sicura che, se non lo avessi più rivisto, quel vago sentimento si sarebbe spento e, facilmente, avrei finito col dimenticarlo.
Ma non era nel mio destino non rivederlo più: il nuovo interesse che mio padre aveva preso a nutrire per la sociologia, e i pranzi che dava regolarmente, non lo avrebbero permesso. Mio padre non era un sociologo. Il suo matrimonio con mia madre era stato felice, e felice lo avevano reso le sue ricerche di fisica; ma dopo la morte di mia madre quelle ricerche non erano più riuscite a colmare l'orribile vuoto. Si era occupato di filosofia, con poco interesse agli inizi, poi con sempre maggiore impegno, finendo con l'occuparsi di economia politica e scienze sociali. Possedeva un vivo sentimento della giustizia, e così non tardò ad accendersi di passione per la riparazione dei torti. Dal canto mio, notavo con somma gioia questi segni di rinascente interesse per la vita, pur non immaginando quale sarebbe stato il risultato. Con l'entusiasmo di un ragazzo, s'immerse così in nuove ricerche, senza neppure chiedersi dove l'avrebbero portato.
Abituato da sempre al lavoro di laboratorio, aveva dunque trasformato la sala da pranzo in un laboratorio di sociologia: vi si trovava riunita gente di ogni tipo e condizione: scienziati, uomini politici, banchieri, commercianti, professori, sindacalisti, socialisti e anarchici. Lui li sollecitava alla discussione e analizzava le loro idee sulla vita e sulla società.
Aveva conosciuto Ernest poco tempo prima della "serata dei predicatori", e dopo che gli ospiti furono andati via seppi come l'aveva conosciuto. Una sera, per strada, si era fermato ad ascoltare un uomo che, in piedi su una cassetta di legno, parlava a un gruppo di operai. Era Ernest. Ma non era un oratore da strapazzo. Era molto apprezzato dalla direzione del partito socialista, considerato uno dei dirigenti e riconosciuto come tale dai dottrinari del socialismo. Aveva il dono di presentare in forma semplice e chiara anche i problemi ardui, era un educatore nato e non credeva di avvilirsi salendo su una cassetta di legno per spiegare l'economia politica ai lavoratori.
Mio padre s'era dunque fermato ad ascoltarlo ed era rimasto interessato. Aveva poi avvicinato l'oratore, s'era presentato e lo aveva invitato al pranzo dei reverendi. E solo dopo quel pranzo mi rivelò il poco che era riuscito a sapere. Era figlio di operai, sebbene discendesse da un'antica famiglia stabilitasi da più di duecento anni in America (1). A dieci anni aveva cominciato a lavorare in fabbrica e in seguito aveva imparato il mestiere di maniscalco. Era un autodidatta, aveva studiato il francese e il tedesco, e a quel tempo si guadagnava modestamente la vita traducendo opere scientifiche e filosofiche per una traballante casa editrice socialista di Chicago. Arrotondava poi il guadagno con i diritti ricavati dalla vendita, ristretta, delle proprie opere di economia e filosofia.
Questo appresi su di lui quella sera prima di andare a letto, dove stetti a lungo sveglia ascoltando ancora, nel ricordo, il suono della sua voce. Mi spaventai dei miei stessi pensieri. Somigliava così poco agli uomini della mia classe! Sembrava così estraneo, così forte! La sua padronanza di sé mi piaceva e insieme mi spaventava, e la mia fantasia galoppava tanto che mi sorpresi a considerarlo come amante e come marito. Avevo sempre sentito dire che la forza degli uomini è un'attrattiva irresistibile per le donne; ma Ernest era troppo forte. "No, no!" esclamai, "è impossibile, è assurdo!". E il giorno dopo, svegliandomi, provai il desiderio fortissimo di rivederlo, di assistere alla sua vittoria in una nuova discussione, di vibrare ancora al suono bellissimo della sua voce, di ammirarlo nella sua sicurezza e nella sua forza, quando spezzava la loro albagia e distoglieva il loro pensiero dal solito circolo vizioso. Che importavano le sue smargiassate? Come lui stesso aveva detto, "funzionavano", erano efficaci. Inoltre, erano belle a sentirsi, eccitanti come l'inizio di una battaglia.
Passarono parecchi giorni durante i quali lessi i libri di Ernest prestatimi da mio padre. Scritta, la sua parola era come quella parlata, chiara e convincente. La sua semplicità assoluta ti convinceva anche se il tuo dubbio continuava. Aveva il dono della lucidità, di esporre in maniera perfetta. E tuttavia, nonostante il suo stile, molte cose non mi piacevano. Dava troppa importanza a ciò che chiamava la lotta di classe, all'antagonismo fra lavoro e capitale, al conflitto degli interessi.
Mio padre, compiaciuto, mi riferì il giudizio del dottor Hammerfield su Ernest: "Un botolo insolente reso borioso da poca e inadeguata preparazione". Inoltre, il dottor Hammerfield si rifiutava di rivederlo.
Il vescovo Morehouse, invece, era rimasto molto colpito, ed era ansioso di incontrarlo di nuovo. "Un giovane forte", aveva dichiarato, "e vivace, molto vivace. Ma troppo sicuro di sé, troppo sicuro!".
Ernest ritornò un pomeriggio, in compagnia di mio padre. Il vescovo era già arrivato e stavamo prendendo il tè sulla veranda.
La prolungata presenza di Ernest a Berkeley, tra l'altro, era dovuta al fatto che seguiva dei corsi speciali di biologia all'università; in più, a quel tempo lavorava intensamente a una nuova opera intitolata: "Filosofia e Rivoluzione" (2).
Quando entrò, improvvisamente la veranda parve troppo piccola. Non perché lui fosse molto alto (era alto un metro e settantadue), ma perché sembrava irradiare un'atmosfera di grandezza. Nel salutarmi, tradì una lieve esitazione che contrastava stranamente con il suo sguardo ardito e la sua stretta di mano ferma e sicura.
I suoi occhi non erano meno sicuri, ma, questa volta, sembravano interrogare, mentre mi guardavano, come il primo giorno, indugiando un po' troppo.
"Ho letto il suo libro: 'Filosofia della classe lavoratrice'", dissi, e scorsi nei suoi occhi un lampo di compiacimento.
"Naturalmente", rispose, "avrà tenuto conto del pubblico al quale è rivolto".
"Sì, e appunto per questo non sono d'accordo con lei".
"Neppure io", disse il vescovo Morehouse, "sono d'accordo con lei".
Ernest scrollò le spalle con aria rassegnata, e accettò una tazza di tè.
Il vescovo mi cedette la parola con un inchino.
"Lei fomenta l'odio di classe", cominciai. "E a me pare un errore, un delitto, fare appello a tutto ciò che vi è di limitato e brutale nella classe operaia. L'odio di classe è anti-sociale".
"Proclamo la mia innocenza", rispose lui. "Non c'è odio di classe né nel testo né nello spirito di nessuna mia opera".
"Oh!" esclamai con aria di rimprovero. Presi il libro e lo aprii.
Lui sorseggiava il tè e mi sorrideva, mentre io sfogliavo le pagine.
"Pagina centotrentadue", dissi, e lessi ad alta voce: "'Pertanto, nell'attuale stadio dello sviluppo sociale, tra i datori di lavoro e i salariati esiste lotta sociale'!".
Lo guardai con aria di trionfo.
"Ma non vi si parla di odio di classe", rispose lui, sorridendo.
"Ma parla di 'lotta di classe'".
"Non sono certo la stessa cosa. Mi creda, noi non fomentiamo l'odio. Sosteniamo soltanto che la lotta di classe è una legge dell'evoluzione sociale. Non ne siamo responsabili. Non è una nostra invenzione. Ci limitiamo a spiegarla, come Newton spiegava la gravitazione. Noi esaminiamo la natura del conflitto d'interessi che provoca la lotta di classe".
"Ma non dovrebbe esserci nessun conflitto d'interessi!" esclamai.
"Sono perfettamente d'accordo con lei", rispose. "E noi socialisti tendiamo appunto all'abolizione di questo conflitto di interessi.
Scusi, mi lasci leggere un altro punto". Prese il libro e ne voltò alcuni fogli. "Pagina centoventisei: 'Il ciclo della lotta di classe, iniziato con la dissoluzione del comunismo primitivo della tribù e la nascita della proprietà privata, si concluderà con l'abolizione della proprietà individuale dei mezzi dell'esistenza sociale'".
"Non sono d'accordo con lei", lo interruppe il vescovo, tradendo con un lieve rossore nel volto ascetico l'intensità dei suoi sentimenti. "Le sue premesse sono false. Non esiste conflitto d'interessi fra lavoro e capitale, o, almeno, non dovrebbe esistere".
"La ringrazio", disse con aria grave Ernest, "di avermi restituito le mie premesse con questa sua affermazione".
Ma perché dovrebbe esserci conflitto?" incalzò il vescovo con calore.
Ernest si strinse nelle spalle.
"Perché siamo fatti così, immagino".
"Ma non siamo fatti così!" esclamò l'altro.
"Stiamo forse parlando dell'uomo ideale, divino, privo di egoismo?" ribatté Ernest. "Ce n'è tanto pochi che si possono considerare inesistenti. Oppure dell'uomo comune, ordinario?".
"Dell'uomo ordinario".
"Debole, fallibile e soggetto a errare?".
Il vescovo Morehouse annuì.
"E meschino, egoista?" Il prelato annuì ancora.
"Badi bene", avvertì Ernest. "Ho detto 'egoista'".
"L'uomo comune è egoista", affermò il vescovo con calore.
"Che vuole avere tutto ciò che può?".
"Vuole avere il più possibile. E' deplorevole, ma è vero".
"Allora ci è cascato". La mascella di Ernest scattò come una trappola. "Glielo dimostro. Prenda un uomo che lavora sui tram".
"Non potrebbe lavorare se non ci fosse il capitale", l'interruppe il vescovo.
"E' vero, ma ammetterà che il capitale perirebbe se non guadagnasse i suoi dividendi sulla mano d'opera".
Il vescovo non rispose.
"Non è d'accordo?" insistette Ernest.
Il prelato annuì.
"Allora le nostre due proposizioni si annullano reciprocamente, e ci troviamo al punto di partenza. Ricominciamo. I tranvieri forniscono la mano d'opera e gli azionisti il capitale. Da quest'unione del lavoro col capitale nasce il guadagno (3).
Entrambi si dividono questo guadagno: la parte che tocca al capitale si chiama dividendo, quella che tocca al lavoro si chiama salario".
"Benissimo", l'interruppe il vescovo. "Ma non c'è motivo perché questa divisione non avvenga amichevolmente".
"Ha già dimenticato le premesse", replicò Ernest. "Eravamo d'accordo nell'ammettere che l'uomo ordinario è egoista. L'uomo ordinario è quello che è. Ora invece lei parte per la tangente e vuol fare una distinzione fra quest'uomo e gli uomini come dovrebbero essere, ma come non sono in realtà. Ritorniamo sulla terra: il lavoratore, essendo egoista, vuole avere quanto più può nella divisione; il capitalista, essendo egoista, vuole, del pari, avere tutto ciò che può prendere. Quando una cosa esiste in quantità limitata, e due uomini vogliono averne ciascuno la parte maggiore, nasce un conflitto d'interessi. E' il conflitto che esiste fra capitale e lavoro, ed è uno scontro inconciliabile.
Finché esisteranno operai e capitalisti, litigheranno per la divisione del guadagno. Se fosse stato a San Francisco questo pomeriggio, sarebbe stato costretto ad andare a piedi, non circola neppure un tram".
"Un altro sciopero?" (4) domandò il vescovo, allarmato.
"Sì, litigano per l'equa divisione dei guadagni delle tranvie".
Il vescovo si irritò.
"Hanno torto!" esclamò. "Gli operai non vedono al di là del loro naso. Come possono sperare di conservare la nostra simpatia?...".
"Quando ci obbligano ad andare a piedi", disse maliziosamente Ernest.
E il vescovo concluse senza badargli:
"Il loro punto di vista è troppo meschino. Gli uomini devono agire da uomini e non da bestie. Ci saranno ancora violenze e uccisioni, e vedove e orfani addolorati. Capitale e lavoro dovrebbero essere uniti, dovrebbero procedere insieme, per il reciproco interesse".
"Ecco che parte di nuovo per la tangente", osservò freddamente Ernest. "Vediamo di ritornare sulla terra e di non perdere di vista la nostra asserzione: l'uomo è egoista".
Ma non dovrebbe esserlo!" esclamò il vescovo.
"Su questo punto sono d'accordo con lei. Non dovrebbe essere egoista, ma lo sarà sempre finché vivrà in un sistema sociale fondato su una morale meschina".
Il prelato parve spaventato; mio padre entro di sé rideva.
"Sì, una morale meschina", riprese Ernest, senza esitazioni. "Ed è l'ultima parola del vostro sistema capitalistico, è ciò che sostiene la vostra chiesa, ciò che voi predicate ogni volta che salite sul pulpito: meschina, non c'è altro nome".
Il vescovo si rivolse per aiuto a mio padre, il quale scosse il capo, ridendo.
"Credo che il signor Everhard abbia ragione", disse poi. "E' la politica del 'laissez-faire', dell'ognuno per sé e dio per tutti.
Come disse l'altra sera il signor Everhard, il compito di voi gente di chiesa consiste nel mantenere l'ordine stabilito e la società è fondata su questo principio!".
"Ma questo non è l'insegnamento di Cristo!" esclamò il vescovo.
"Oggi la chiesa non insegna la dottrina di Cristo", rispose Ernest. "Per questo gli operai non vogliono niente a che farci. La chiesa approva la terribile brutalità, la ferocia con la quale il capitalista tratta la classe lavoratrice".
"Non l'approva affatto", obiettò il vescovo.
"Ma non protesta neppure", replicò Ernest "e perciò approva, perché non bisogna dimenticare che la chiesa è sostenuta dalla classe capitalistica".
"Non avevo mai considerato la cosa da questo punto di vista", disse ingenuamente il vescovo. "Ma credo che sbagli. So che le tristezze e le brutture del mondo sono molte; so che la chiesa ha perduto il... quello che voi chiamate proletariato" (5).
"Non è mai stato con voi", esclamò Ernest. "Si è sviluppato fuori della chiesa e senza di essa".
"Non la seguo più", replicò debolmente il vescovo.
"Le spiego. Dopo l'introduzione della macchina e del sistema industriale, verso la fine del diciottesimo secolo, la grande massa dei lavoratori fu allontanata dalla terra e l'antico sistema di lavoro mutò. Tolti dai loro villaggi, i lavoratori si trovarono rinchiusi nelle città industriali; le madri e i fanciulli furono messi a lavorare alle nuove macchine; la vita di famiglia cessò e le condizioni divennero atroci. E' una pagina di storia scritta con sangue e lacrime".
"Lo so", l'interruppe il vescovo, con un'espressione d'angoscia in viso. "Fu terribile, ma ciò avvenne in Inghilterra, un secolo e mezzo fa".
"E lì, un secolo e mezzo fa, nacque il proletariato moderno", continuò Ernest. "Mentre il paese veniva trasformato dai capitalisti in un vero e proprio macello, la chiesa taceva, non protestò allora come non protesta oggi. Come dice Austin Lewis (6), parlando di quell'epoca, coloro che avevano ricevuto il comandamento: 'Pascete i miei agnelli', hanno assistito senza protestare alla vendita e al massacro di quegli agnelli (7). Prima di continuare la prego di dirmi sinceramente se è o no d'accordo.
La chiesa protestò a quel tempo?".
Il vescovo Morehouse esitò: come il dottor Hammerfield, non era abituato a quel violento "corpo a corpo", come lo chiamava Ernest.
"La storia del secolo diciottesimo è stata scritta", suggerì questi. "Se la chiesa tacque allora, non avrà taciuto anche nei libri".
"Purtroppo temo che sia rimasta muta", ammise il prelato.
"E rimane muta anche oggi".
"Su questo non sono d'accordo".
Ernest tacque, guardò attentamente il suo interlocutore e accettò la sfida.
"Benissimo", disse, "vedremo. Ci sono, a Chicago, donne che lavorano tutta la settimana per novanta centesimi. Protesta forse la chiesa?".
"E' una novità per me", fu la risposta. "Novanta centesimi? E' orribile!".
"La chiesa ha forse protestato?" insistette Ernest.
"La chiesa lo ignora". Il vescovo appariva penosamente agitato.
"Eppure la chiesa ha ricevuto il comandamento: 'Pasci i miei agnelli!'" disse Ernest, con amara ironia. Poi, riprendendosi:
"Perdoni la mia ironia, monsignore, ma c'è da meravigliarsi se perdiamo la pazienza con voi? Avete forse protestato presso le vostre congreghe capitalistiche per l'impiego dei fanciulli nelle filande di cotone del Sud? (8). Bimbi di sei o sette anni lavorano tutte le notti, in turni di dodici ore: non vedono mai la santa luce del giorno, e muoiono come mosche. I dividendi sono pagati con il loro sangue e con quel denaro si costruiscono chiese magnifiche nel New England, nelle quali voi predicate piacevoli banalità ai lustri e panciuti beneficiari di quei dividendi".
"Non sapevo", mormorò il vescovo, con un filo di voce e il viso pallido, come se soffrisse di nausea.
"E quindi non avete protestato, vero?".
Il vescovo fece un debole cenno di diniego.
"Così la chiesa tace oggi come tacque nel secolo diciottesimo".
Il vescovo non rispose e, per una volta tanto, Ernest non insistette oltre.
"E non dimentichi; ogni volta che un membro del clero protesta, lo si congeda".
"Questo non mi sembra giusto".
"Lei protesterebbe?".
"Fatemi vedere, nella vostra comunità, dei mali come quelli di cui ha parlato lei e io farò sentire la mia voce".
"Mi metto a sua disposizione per mostrarglieli", rispose tranquillamente Ernest. "Le farò fare un viaggio attraverso l'inferno".
"E io protesterò!". Il vescovo si era raddrizzato sulla sedia e il dolce viso gli si tese nella fiera durezza del guerriero. "La chiesa non rimarrà muta".
"Sarà congedato", lo avvertì Ernest.
"Le fornirò la prova del contrario", replicò l'altro. "Le dimostrerò che, se tutto ciò che dice è vero, la chiesa ha sbagliato per ignoranza; che tutto quanto c'è di orribile nella società industriale è dovuto all'ignoranza della classe capitalistica. Essa rimedierà al male appena riceverà il messaggio che la chiesa avrà il dovere di comunicarle".
Ernest scoppiò a ridere, una risata così brutale che mi sentii portata a prendere le difese del vescovo.
"Ricordi", dissi, "che lei vede un solo lato della medaglia. Anche se lei non ci crede capaci di bontà, sappia che c'è molto di buono in noi. Il vescovo Morehouse ha ragione. I mali dell'industria, per quanto terribili, sono dovuti all'ignoranza. Le diversità delle condizioni sociali sono troppo profonde".
"L'indiano selvaggio è meno crudele e meno implacabile della classe capitalistica", rispose lui, e in quel momento l'odiai.
"Lei non ci conosce, non siamo né crudeli né implacabili".
"Lo dimostri", disse lui, in tono di sfida.
"Come posso dimostrarlo... a lei?". Cominciavo a irritarmi.
Scosse il capo. "Non pretendo che lo dimostri a me; le chiedo di dimostrarlo a se stessa".
"So cosa pensare in proposito".
"Non sa proprio nulla", rispose lui, brutalmente.
"Andiamo, andiamo, figlioli", disse mio padre, conciliante.
"Me ne infischio..." cominciai, indignata; ma lui mi interruppe.
"Credo che lei abbia dei capitali investiti nelle filande Sierra; o che li abbia suo padre, il che è lo stesso".
"Cosa c'entra questo?" esclamai.
"Non molto", rispose lui, parlando lentamente, "solo che l'abito che indossa è macchiato di sangue. Le travi del tetto che vi ripara, gocciolano del sangue di fanciulli e di giovani validi e forti. Mi basta chiudere gli occhi per sentirlo colare goccia a goccia, intorno a me".
E accompagnando la parola con il gesto, si allungò nella poltrona e chiuse gli occhi.
Scoppiai in lacrime, per la mortificazione e la vanità ferita. Non ero mai stata trattata tanto brutalmente in vita mia. Anche il vescovo e mio padre erano a disagio e turbati. Cercarono di sviare la conversazione rivolgendola verso un argomento meno scottante, ma Ernest aprì gli occhi, mi guardò e volse altrove lo sguardo. La piega della sua bocca era severa, e il suo sguardo anche; non c'era nei suoi occhi il minimo lampo di gaiezza. Cosa stesse per dire, quale nuova crudeltà stesse per infliggermi, non l'avrei mai saputo, perché in quell'istante un uomo che passava sul marciapiede si fermò a guardarci. Era un giovane robusto, vestito poveramente, che portava sulla schiena un pesante carico di cavalletti, sedie e parafuochi di bambù e panno. Guardava la casa come se non osasse entrare per tentare di vendere la sua merce.
"Quell'uomo si chiama Jackson", disse Ernest.
"Robusto com'è," osservai seccamente, "dovrebbe lavorare, invece di fare il merciaio ambulante" (9).
"Osservi la sua manica sinistra", disse Ernest gentilmente.
Gettai uno sguardo e vidi che la manica del giovane era vuota .
"Anche da quel braccio scorre un po' del sangue che sentivo gocciolare dal vostro soffitto", continuò lui, con lo stesso tono dolce e triste. "Ha perduto il braccio nella filanda Sierra, e voi l'avete gettato sul lastrico a morire come un cavallo mutilato.
Dicendo voi, intendo il direttore e le altre persone impiegate da voi e gli altri azionisti che dirigono per voi le filande. Fu una disgrazia, dovuta allo zelo di quell'operaio per far risparmiare qualche dollaro all'azienda. Il braccio gli venne preso dal cilindro dentato della cardatrice. Avrebbe potuto lasciar passare il sassolino che aveva notato fra i denti della macchina, avrebbe spezzato una doppia fila di punte; volle invece toglierlo e il braccio gli si impigliò e fu sfracellato, dalla punta delle dita alla spalla. Era notte: nella filanda si facevano turni straordinari di lavoro. In quel trimestre fu pagato un forte dividendo. Quella notte Jackson lavorava da molte ore e i suoi muscoli avevano perduto la solita vivacità: per questo venne afferrato dalla macchina. Ha moglie e tre bambini".
"E che cosa fece la società per lui?" chiesi.
"Assolutamente niente. No, mi scusi, qualcosa ha fatto. E' riuscita a far respingere l'istanza per danni e interessi che l'operaio aveva presentato quando uscì dall'ospedale. La società ha degli avvocati abilissimi".
"Non ha detto tutto", feci con convinzione, "e forse non conoscete tutta la storia. Forse quell'uomo era un insolente".
"Insolente! Ah! Ah!". Quella sua risata era mefistofelica. "Gran dio, insolente col braccio sfracellato! Era un servitore dolce e umile, e non risulta che sia mai stato un insolente".
"Ma il tribunale", insistetti, "non avrebbe deciso in suo sfavore se non ci fosse sotto qualcos'altro".
"Il principale avvocato consulente della società è il colonnello Ingram, un uomo di legge, molto abile".
Mi guardò con aria grave per un momento, quindi continuò:
"Voglio darle un consiglio, signorina Cunnigham: fare un'inchiesta sul caso Jackson".
"Avevo già deciso di farlo", risposi, gelida.
"Benissimo", ribatté lui, allegro. "E le dirò dove potrà trovare il nostro uomo. Ma fremo al pensiero della conclusione alla quale arriverà grazie al braccio di Jackson".
E così il vescovo e io accettammo la sfida di Ernest. Poco dopo se ne andarono, insieme, lasciandomi scossa per l'ingiustizia fatta alla mia classe sociale e a me stessa. Quel giovanotto era un bruto. Lo odiavo, in quel momento, e mi consolavo al pensiero che la sua condotta era come bisognava aspettarsela da un membro della classe operaia.
NOTE:
1) A quei tempi, la distinzione fra le famiglie natie nel paese e quelle venute di fuori, era nettamente e gelosamente segnata.
2) Questo libro continuò a essere stampato clandestinamente durante i tre secoli del Tallone di Ferro. Parecchie copie delle sue diverse edizioni si trovano nella biblioteca nazionale di Ardis.
3) A quel tempo, gruppi di uomini rapaci controllavano tutti i mezzi di trasporto, per il cui uso imponevano tariffe al pubblico.
4) Queste manifestazioni erano molto diffuse in quei tempi di caos e anarchia. A volte gli operai rifiutavano di lavorare, altre volte i capitalisti rifiutavano di lasciare lavorare gli operai.
Nella violenza e nel disordine di questi dissidi, molta proprietà veniva distrutta e molte vite umane perivano. Tutto questo oggi ci sembra inconcepibile come inconcepibile ci risulterebbe l'altra abitudine di quel tempo, quella dei mariti di fracassare mobili quando litigavano con le mogli.
5) "Proletariato" - dal latino "proletarius
canto dei "briganti" del Sud
LIBERTA'
Ammu pusato chitarra e tammure
pecche' sta musica s'adda cagna'
simmo briganti e facimmo paure
e cu' 'a scuppetta vulimmo canta'
E mo'cantammo 'na nova canzona
tutta la gente se l'adda 'mpara'
nuie cumbattimmo p' 'o rre burbone
e 'a terra nosta nun s'adda tucca'
Chi ha visto 'o lupo e s'e' miso paure
nun sape buono qual e' 'a verita'
'o vero lupo ca magna e criature
e' 'o piemuntese c'avimm' a caccia'
Tutte 'e paise d' 'a Basilicata
se so' scetate e vonno lutta'
pure 'a Calabria s'e' arrevotata
e stu nemico facimmo tremma'
Femmene belle ca date lu core
si lu brigante vulite aiuta'
nun lo cercate, scurdateve 'o nomme
chi ce fa guerra nun tene pieta'
Ommo se nasce, brigante se more
e fino all'urdemo avimm' a spara'
ma si murimmo menate nu sciore
e 'na preghiera pe sta liberta'
per sentire il canto
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=6977370879490872834
da: "BRIGANTI & PARTIGIANI" - a cura di: Barone, Ciano, Pagano, Romano - Edizione Campania Bella
HOME PRINCIPALE
Ammu pusato chitarra e tammure
pecche' sta musica s'adda cagna'
simmo briganti e facimmo paure
e cu' 'a scuppetta vulimmo canta'
E mo'cantammo 'na nova canzona
tutta la gente se l'adda 'mpara'
nuie cumbattimmo p' 'o rre burbone
e 'a terra nosta nun s'adda tucca'
Chi ha visto 'o lupo e s'e' miso paure
nun sape buono qual e' 'a verita'
'o vero lupo ca magna e criature
e' 'o piemuntese c'avimm' a caccia'
Tutte 'e paise d' 'a Basilicata
se so' scetate e vonno lutta'
pure 'a Calabria s'e' arrevotata
e stu nemico facimmo tremma'
Femmene belle ca date lu core
si lu brigante vulite aiuta'
nun lo cercate, scurdateve 'o nomme
chi ce fa guerra nun tene pieta'
Ommo se nasce, brigante se more
e fino all'urdemo avimm' a spara'
ma si murimmo menate nu sciore
e 'na preghiera pe sta liberta'
per sentire il canto
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=6977370879490872834
da: "BRIGANTI & PARTIGIANI" - a cura di: Barone, Ciano, Pagano, Romano - Edizione Campania Bella
HOME PRINCIPALE
I bersaglieri a Pontelandolfo come i Nazisti alle Fosse Ardeatine
Il massacro dimenticato di Pontelandolfo
Quando i bersaglieri fucilarono gli innocenti
Il 14 agosto 1861 per vendicare i loro quaranta morti i soldati sabaudi uccisero 400 inermi. Un eccidio come quello delle Fosse Ardeatine. Il sindaco oggi si batte perché alla città sia riconosciuto lo status di "martire". E promette: se l'esercito chiede scusa, invitiamo la loro fanfara a suonare come atto di riconciliazione
di PAOLO RUMIZ
Illustrazione di Riccardo Mannelli
SIGNOR presidente della Repubblica, signori ministri, autorità incaricate delle celebrazioni del centocinquantenario, questa storia è per voi. Non voltate pagina e ascoltate il racconto di questo soldato, se credete al motto "fratelli d'Italia" e tenete all'onestà della memoria sul 1861, anno uno della Nazione.
"Al mattino del giorno 14 ricevemmo l'ordine di entrare nel paese, fucilare gli abitanti, meno i figli, le donne e gli infermi, e incendiarlo. Subito abbiamo cominciato a fucilare... quanti capitava, indi il soldato saccheggiava, ed infine abbiamo dato l'incendio al paese, di circa 4.500 abitanti. Quale desolazione... non si poteva stare d'intorno per il gran calore; e quale rumore facevano quei poveri diavoli che la sorte era di morire abbrustoliti, e chi sotto le rovine delle case. Noi invece durante l'incendio avevamo di tutto: pollastri, pane, vino e capponi, niente mancava". Olocausto firmato dagli Einsatzkommando? No, soldati italiani, al comando di ufficiali italiani. E il villaggio non sta in Etiopia ma in Italia, nel Beneventano. Il suo nome è Pontelandolfo. Massacro a opera dei bersaglieri, data 14 agosto 1861, meno di un anno dopo l'ingresso trionfale di Garibaldi a Napoli. Pontelandolfo, nome cancellato dai libri perché ricorda che al Sud ci fu guerra, sporca e terribile, e non solo annessione.
Andiamoci dunque, luogotenente Cariolato, per capire cosa accadde; perdiamoci nel labirinto di strade sannitiche già ostiche ai Romani, e saliamo verso quel promontorio di case, in un profumo ubriacante di ginestre e faggete secolari. Penso a un viaggio nella storia e invece mi trovo immerso in un oggi che scotta, davanti a una giunta comunale che aspetta, sindaco in testa. Delegazione agguerrita, di centrosinistra, schierata per avere giustizia. Raccontano, come di cosa appena accaduta. C'è una rivolta, alla falsa notizia che i Borboni sono tornati. Scattano regolamenti di conti con due morti, i briganti scendono dai monti, il prete suona le campane per salutare la restaurazione. Un distaccamento di bersaglieri va a vedere, ma nella notte vengono aggrediti da una banda in un paese vicino e lasciano sul terreno 41 morti. Ci sono buoni motivi per pensare che il responsabile sia un proprietario terriero, impegnato in un subdolo doppio gioco: eccitare le masse per poi invocare la mannaia e rafforzare il suo status. Ma non importa: si manda una spedizione punitiva con l'incarico di "non mostrare misericordia", e alla fine si contano 400 morti. Morti innocenti perché gli assassini si sono dati alla macchia.
Quattrocento per quaranta. Dieci uccisi per ogni soldato, come alle Fosse Ardeatine. Oggi a Pontelandolfo c'è solo un monumentino con tredici nomi e una lapide in memoria di Concetta Biondi, violentata e uccisa dai soldati. Mancano centinaia di nomi, scritti solo nei registri parrocchiali. Il sindaco: "A marzo siamo stati finalmente riconosciuti come "luogo della memoria". Ma non ci basta: vogliamo essere "città martire" e che questo nome sia scritto sulla segnaletica. Vogliamo che l'esercito riconosca la sua ferocia. Lo dico al ministro: se i bersaglieri chiedono scusa, noi invitiamo ufficialmente le loro fanfare a suonare in paese come atto di riconciliazione. I nostri e i loro morti vanno ricordati insieme. Io ho giurato sulla fascia tricolore. Voglio dar senso alle celebrazioni, e non lasciare spazio ai rancori anti-unitari". Renato Rinaldi è un ex ufficiale di marina che si è tuffato in quelle pagine nere. Anche lui ha giurato sul Tricolore e anche a lui pesa il silenzio del Quirinale di fronte a vent'anni di lettere miranti al "ricupero della dignità del paese". Mi spiega che i bersaglieri erano agli ordini di un generale vicentino - vicentino, sì, come il mio buon Cariolato - di nome Pier Eleonoro Negri. E anche qui c'è silenzio. L'Italia non fa mai i conti col suo passato. Nessuna risposta da Vicenza alla richiesta di dedicare una via a Pontelandolfo o di togliere la lapide celebrativa del generale sterminatore.
Cielo limpido sulle verdissime foreste del Sannio. Perché si parla di Bronte e non di Pontelandolfo? Perché sono rimasti nella memoria gli errori garibaldini e non gli orrori savoiardi? E che cosa si sa della teoria dell'inferiorità razziale dei meridionali - infidi, pigri e riottosi - impostata da un giovane ufficiale medico piemontese di nome Cesare Lombroso, spedito al Sud nel '61 e seguire la cosiddetta guerra al brigantaggio? Che "fratelli d'Italia" potevano esistere se mezzo Paese era "razza maledetta" dal cranio "anomalo", condannata all'arretratezza e alla delinquenza? Leggo: "Dio, che cosa abbiamo fatto!", parole scritte nel '62 da Garibaldi in merito allo stato del Sud. Lettera alla vedova Cairoli, che per fare l'Italia - un'altra Italia - gli ha dato la vita di tre figli e del marito. Non si parla dei vinti. E senza i vinti le celebrazioni sono ipocrisia. Che fine ha fatto per esempio Josè Borjes, il generale di cui mi ha parlato Andrea Camilleri? Parlo dell'uomo che sempre nel '61, quasi da solo, tentò di sollevare le Sicilie contro i Savoia. Perché non si dice nulla della sua epopea e del mistero della sua morte? Perché non si riconosce il valore di questo Rolando che galoppa verso una fatale Roncisvalle dopo essere sbarcato con soli dodici uomini in Calabria, alla disperata, sulla costa crudele dei fallimenti, la stessa di Murat, dei Fratelli Bandiera, di Pisacane, dei curdi disperati, dei monaci in fuga dagli scismi bizantini?
Ed ecco, in una sera straziante color indaco, arrivare come da un fonografo lontano la voce di Sergio Tau, scrittore e regista che ha dedicato anni alla storia del generale catalano. "All'inizio degli anni Sessanta feci un film sul brigantaggio post-unitario. Volevo fare qualcosa di simile a un western, ma la pellicola non fu mai trasmessa. Allora era ancora impossibile parlarne. Ora vedo che la storia di Borjes può tornare fuori... Filmicamente è grandiosa, con la sua traversata invernale dell'Appennino". Ne terrà conto qualcuno? Borjes punta sullo Stato pontificio, ma a Tagliacozzo viene "venduto" da una guida traditrice ai bersaglieri, che lo fucilano insieme ai suoi. "Conservate quel corpo, potrete passarlo ai Borboni", dice un misterioso francese e venti giorni dopo la salma è consegnata alla guardia papalina, scende via Tivoli fino al Tevere e al funerale nella chiesa del Gesù a Roma. Poi c'è una messa per l'anima sua a Barcellona, ma del corpo più nessuna traccia. Resta un suo diario, stranamente in francese, lingua che lui non conosceva. L'ha davvero scritto lui o l'hanno scritto i "servizi" di allora, per occultare la repressione in atto? Il giallo di una vita vissuta anch'essa, bene o male, alla garibaldina.
23. continua
=========
Napolitano come Willy Brandt
Il Presidente Napolitano dovrebbe ispirarsi al grande statista socialdemocratico europeo Willy Brand
che si inginocchiò davanti il monumento del ghetto di Varsavia e chiese perdono per i crimini dei nazisti. Dovrebbe inginocchiarsi davanti la fortezza di Fenestrelle nell'alto Piemonte dove venivano deportati i resistenti meridionali i tantissimi contadini definiti "briganti" per morirvi squagliati nella calce viva o di fame e di freddo.L'unità d'Italia non si fa con la retorica patriottarda o intonando tutti insieme l'inno di Mameli. Si fa facendo conoscere la verità finora nascosta agli italiani da una storiografia fatta di menzogne. Soltanto la verità accompagnata da un atto di riconoscimento delle terribili colpe del genocidio nordista può mettere le basi, a 150 anni della fondazione dello Stato, di una vera nazione. La partecipazione alla prima guerra mondiale del tutto inutile e priva di senso non
ha avvicinato gli italiani sebbene abbia compiuto fraternizzazioni specialmente tra i soldati. La prima guerra mondiale fu la guerra dei feroci ufficiali dello Stato Sabaudo contro i loro soldati che venivano mandati deliberatamente al massacro oppure decimati e fucilati per futili motivi. Non è bastata a fare dell'Italia una Nazione.
Bisogna quindi fare piena luce sugli anni che vanno dal 1861 alla grande emigrazione transeoceanica del novecento. Elencare tutti i delitti ad uno ad uno. Rievocare i paesi rasi al suolo, le famiglie distrutte,le devastazioni e le ruberie in danno degli sventurati abitanti del Regno delle Due Sicilie. Tutto avvenne dopo la spedizione dei Mille ma già se ne sentivano i presagi nella strage di Bronte.
Si dovrebbero rimuovere i resti umani dei combattenti meridionali dal Museo Lombrosiano. Una vera vergogna che Borghezio vorrebbe conservare a dimostrazione della inferiorità etnica della gente del Sud.
Pietro Ancona
http://medioevosociale-pietro.blogspot.com/
www.spazioamico.it
mercoledì, ottobre 21, 2009By Web & Books
Quando i bersaglieri fucilarono gli innocenti
Il 14 agosto 1861 per vendicare i loro quaranta morti i soldati sabaudi uccisero 400 inermi. Un eccidio come quello delle Fosse Ardeatine. Il sindaco oggi si batte perché alla città sia riconosciuto lo status di "martire". E promette: se l'esercito chiede scusa, invitiamo la loro fanfara a suonare come atto di riconciliazione
di PAOLO RUMIZ
Illustrazione di Riccardo Mannelli
SIGNOR presidente della Repubblica, signori ministri, autorità incaricate delle celebrazioni del centocinquantenario, questa storia è per voi. Non voltate pagina e ascoltate il racconto di questo soldato, se credete al motto "fratelli d'Italia" e tenete all'onestà della memoria sul 1861, anno uno della Nazione.
"Al mattino del giorno 14 ricevemmo l'ordine di entrare nel paese, fucilare gli abitanti, meno i figli, le donne e gli infermi, e incendiarlo. Subito abbiamo cominciato a fucilare... quanti capitava, indi il soldato saccheggiava, ed infine abbiamo dato l'incendio al paese, di circa 4.500 abitanti. Quale desolazione... non si poteva stare d'intorno per il gran calore; e quale rumore facevano quei poveri diavoli che la sorte era di morire abbrustoliti, e chi sotto le rovine delle case. Noi invece durante l'incendio avevamo di tutto: pollastri, pane, vino e capponi, niente mancava". Olocausto firmato dagli Einsatzkommando? No, soldati italiani, al comando di ufficiali italiani. E il villaggio non sta in Etiopia ma in Italia, nel Beneventano. Il suo nome è Pontelandolfo. Massacro a opera dei bersaglieri, data 14 agosto 1861, meno di un anno dopo l'ingresso trionfale di Garibaldi a Napoli. Pontelandolfo, nome cancellato dai libri perché ricorda che al Sud ci fu guerra, sporca e terribile, e non solo annessione.
Andiamoci dunque, luogotenente Cariolato, per capire cosa accadde; perdiamoci nel labirinto di strade sannitiche già ostiche ai Romani, e saliamo verso quel promontorio di case, in un profumo ubriacante di ginestre e faggete secolari. Penso a un viaggio nella storia e invece mi trovo immerso in un oggi che scotta, davanti a una giunta comunale che aspetta, sindaco in testa. Delegazione agguerrita, di centrosinistra, schierata per avere giustizia. Raccontano, come di cosa appena accaduta. C'è una rivolta, alla falsa notizia che i Borboni sono tornati. Scattano regolamenti di conti con due morti, i briganti scendono dai monti, il prete suona le campane per salutare la restaurazione. Un distaccamento di bersaglieri va a vedere, ma nella notte vengono aggrediti da una banda in un paese vicino e lasciano sul terreno 41 morti. Ci sono buoni motivi per pensare che il responsabile sia un proprietario terriero, impegnato in un subdolo doppio gioco: eccitare le masse per poi invocare la mannaia e rafforzare il suo status. Ma non importa: si manda una spedizione punitiva con l'incarico di "non mostrare misericordia", e alla fine si contano 400 morti. Morti innocenti perché gli assassini si sono dati alla macchia.
Quattrocento per quaranta. Dieci uccisi per ogni soldato, come alle Fosse Ardeatine. Oggi a Pontelandolfo c'è solo un monumentino con tredici nomi e una lapide in memoria di Concetta Biondi, violentata e uccisa dai soldati. Mancano centinaia di nomi, scritti solo nei registri parrocchiali. Il sindaco: "A marzo siamo stati finalmente riconosciuti come "luogo della memoria". Ma non ci basta: vogliamo essere "città martire" e che questo nome sia scritto sulla segnaletica. Vogliamo che l'esercito riconosca la sua ferocia. Lo dico al ministro: se i bersaglieri chiedono scusa, noi invitiamo ufficialmente le loro fanfare a suonare in paese come atto di riconciliazione. I nostri e i loro morti vanno ricordati insieme. Io ho giurato sulla fascia tricolore. Voglio dar senso alle celebrazioni, e non lasciare spazio ai rancori anti-unitari". Renato Rinaldi è un ex ufficiale di marina che si è tuffato in quelle pagine nere. Anche lui ha giurato sul Tricolore e anche a lui pesa il silenzio del Quirinale di fronte a vent'anni di lettere miranti al "ricupero della dignità del paese". Mi spiega che i bersaglieri erano agli ordini di un generale vicentino - vicentino, sì, come il mio buon Cariolato - di nome Pier Eleonoro Negri. E anche qui c'è silenzio. L'Italia non fa mai i conti col suo passato. Nessuna risposta da Vicenza alla richiesta di dedicare una via a Pontelandolfo o di togliere la lapide celebrativa del generale sterminatore.
Cielo limpido sulle verdissime foreste del Sannio. Perché si parla di Bronte e non di Pontelandolfo? Perché sono rimasti nella memoria gli errori garibaldini e non gli orrori savoiardi? E che cosa si sa della teoria dell'inferiorità razziale dei meridionali - infidi, pigri e riottosi - impostata da un giovane ufficiale medico piemontese di nome Cesare Lombroso, spedito al Sud nel '61 e seguire la cosiddetta guerra al brigantaggio? Che "fratelli d'Italia" potevano esistere se mezzo Paese era "razza maledetta" dal cranio "anomalo", condannata all'arretratezza e alla delinquenza? Leggo: "Dio, che cosa abbiamo fatto!", parole scritte nel '62 da Garibaldi in merito allo stato del Sud. Lettera alla vedova Cairoli, che per fare l'Italia - un'altra Italia - gli ha dato la vita di tre figli e del marito. Non si parla dei vinti. E senza i vinti le celebrazioni sono ipocrisia. Che fine ha fatto per esempio Josè Borjes, il generale di cui mi ha parlato Andrea Camilleri? Parlo dell'uomo che sempre nel '61, quasi da solo, tentò di sollevare le Sicilie contro i Savoia. Perché non si dice nulla della sua epopea e del mistero della sua morte? Perché non si riconosce il valore di questo Rolando che galoppa verso una fatale Roncisvalle dopo essere sbarcato con soli dodici uomini in Calabria, alla disperata, sulla costa crudele dei fallimenti, la stessa di Murat, dei Fratelli Bandiera, di Pisacane, dei curdi disperati, dei monaci in fuga dagli scismi bizantini?
Ed ecco, in una sera straziante color indaco, arrivare come da un fonografo lontano la voce di Sergio Tau, scrittore e regista che ha dedicato anni alla storia del generale catalano. "All'inizio degli anni Sessanta feci un film sul brigantaggio post-unitario. Volevo fare qualcosa di simile a un western, ma la pellicola non fu mai trasmessa. Allora era ancora impossibile parlarne. Ora vedo che la storia di Borjes può tornare fuori... Filmicamente è grandiosa, con la sua traversata invernale dell'Appennino". Ne terrà conto qualcuno? Borjes punta sullo Stato pontificio, ma a Tagliacozzo viene "venduto" da una guida traditrice ai bersaglieri, che lo fucilano insieme ai suoi. "Conservate quel corpo, potrete passarlo ai Borboni", dice un misterioso francese e venti giorni dopo la salma è consegnata alla guardia papalina, scende via Tivoli fino al Tevere e al funerale nella chiesa del Gesù a Roma. Poi c'è una messa per l'anima sua a Barcellona, ma del corpo più nessuna traccia. Resta un suo diario, stranamente in francese, lingua che lui non conosceva. L'ha davvero scritto lui o l'hanno scritto i "servizi" di allora, per occultare la repressione in atto? Il giallo di una vita vissuta anch'essa, bene o male, alla garibaldina.
23. continua
=========
Napolitano come Willy Brandt
Il Presidente Napolitano dovrebbe ispirarsi al grande statista socialdemocratico europeo Willy Brand
che si inginocchiò davanti il monumento del ghetto di Varsavia e chiese perdono per i crimini dei nazisti. Dovrebbe inginocchiarsi davanti la fortezza di Fenestrelle nell'alto Piemonte dove venivano deportati i resistenti meridionali i tantissimi contadini definiti "briganti" per morirvi squagliati nella calce viva o di fame e di freddo.L'unità d'Italia non si fa con la retorica patriottarda o intonando tutti insieme l'inno di Mameli. Si fa facendo conoscere la verità finora nascosta agli italiani da una storiografia fatta di menzogne. Soltanto la verità accompagnata da un atto di riconoscimento delle terribili colpe del genocidio nordista può mettere le basi, a 150 anni della fondazione dello Stato, di una vera nazione. La partecipazione alla prima guerra mondiale del tutto inutile e priva di senso non
ha avvicinato gli italiani sebbene abbia compiuto fraternizzazioni specialmente tra i soldati. La prima guerra mondiale fu la guerra dei feroci ufficiali dello Stato Sabaudo contro i loro soldati che venivano mandati deliberatamente al massacro oppure decimati e fucilati per futili motivi. Non è bastata a fare dell'Italia una Nazione.
Bisogna quindi fare piena luce sugli anni che vanno dal 1861 alla grande emigrazione transeoceanica del novecento. Elencare tutti i delitti ad uno ad uno. Rievocare i paesi rasi al suolo, le famiglie distrutte,le devastazioni e le ruberie in danno degli sventurati abitanti del Regno delle Due Sicilie. Tutto avvenne dopo la spedizione dei Mille ma già se ne sentivano i presagi nella strage di Bronte.
Si dovrebbero rimuovere i resti umani dei combattenti meridionali dal Museo Lombrosiano. Una vera vergogna che Borghezio vorrebbe conservare a dimostrazione della inferiorità etnica della gente del Sud.
Pietro Ancona
http://medioevosociale-pietro.blogspot.com/
www.spazioamico.it
mercoledì, ottobre 21, 2009By Web & Books
venerdì 27 agosto 2010
il vero problema è la confindustria
Il vero problema è la Confindustria
E se il problema dell'Italia, delle sue difficoltà che la fanno annaspare non fossero le resistenze frapposte dalla Fiom all'editto Marchionne, ma la Confindustria e la sua incapacità ad indicare una linea di sviluppo e di produzione di profitti che non sia quella dell'assistenzialismo e dei bassi salari?
La Confindustria tedesca credo che abbia molto da insegnare ai sempre più lividi portavoce degli industriali italiani. L'industria tedesca regge con salari quasi doppi di quelli italiani. L'economia generale del Paese è armoniosa ed i negozi non sono deserti come avviene da noi dove la gente non
ha più soldi da spendere oltre quelli necessari alla mera sopravvivenza,.
I sindacati tedeschi assolvono ad un ruolo di responsabilità con la pratica della codecisione.
Ma i loro lavoratori non sono disperati e ridotti alla fame come quelli iscritti ai sindacati italiani di Bonanni, Angeletti ed Epifani che dal 1993 ad oggi tengono i salari fermi e cedono consistenti quote di diritti e di welfare ogni volta che si incontrano con Governo ed Imprenditori. La codecisione tedesca in Italia si traduce in una mera presa d'atto delle decisioni unilaterali delle imprese.
Mettete in fila le dichiarazioni della Marcegaglia ed i documenti di Confindustria degli ultimi venti anni. Un piagnucolio senza fine per chiedere soldi, soldi, soldi (di quelli buoni diceva la Marcegaglia). La Marcegaglia che oramai sfiora la volgarità con la brutalità e le bassezze delle sue accuse verso i lavoratori con accenti sempre più queruli ed isterici chiede favori fiscali per le imprese, sempre meno welfare e sopratutto la riduzione al silenzio dei sindacati di lavoratori che ancora si ostinano a essere tali.
Tutto quello che ha ottenuto non basta mai. Vuole ancora di più, sempre di più. L'ideale è portare il lavoratore italiano allo stesso livello di quello polacco o, meglio, di quello tunisimo. Azzerare quasi il costo della manodopera anche se questo incide sempre di meno sui costi di produzione anche nella industria manifatturiera. Azzerare la spesa sociale dello Stato. La scuola italiana sta per essere ridotta in maceria dalla drastica cura dimagrante della Gelmini. Una scuola al livello della peggiore scuola pubblica delle periferie americane con programmi sempre più dequalificati.
Ora l'abbattimento dei salari già ultimi tra i paesi OCSE non basta più. Tremonti propone anche di evitare i costi per la sicurezza del lavoro. La difettosa ed insufficiente legge italiana gli sembra "un lusso" e pensa di mettere le mani sull'Inail e sull'INPS magari per sfasciarli privatizzandoli. Sembra attirato dalla buona salute finanziaria di cui godono due istituzioni importanti del welfare italiano.
Marchionne si è unito ai pellegrini che ogni anno si recano a Rimini al "famoso" meeting di Comunione e Liberazione una organizzazione che in Italia svolge il ruolo di certe associazioni fondamentaliste della destra statunitense che gli italiani conoscono per le sue intolleranti convinzioni neocon e non per quella che è: un enorme parassita che ha creato un impero economico con appalti si servizi e forniture dalla pubblica amministrazione, con la cosidetta sussidiarietà, i bassissimi salari che corrisponde alle persone che lavorano alle sue dipendenze. Ogni anno l'appuntamento al meeting di CL, come la relazione del governatore della banca d'Utalia, come il Convegno di Cernobbio, scandisce il calendario politico. Gli Oligarchi della politica italiana smaniano per un invito che viene
accordato soltanto a coloro che si distinguono nella lotta contro la classe lavoratrice e la sinistra.
Sarebbe opportuna un approfondimento di CL un esame dei bilanci della Compagnia delle Opere,
e magari scopriremmo quanto è bello, quanto è redditizio e facile, gridare contro lo statalismo e profittare a piene mani delle sue risorse.
L'idea di usare la globalizzazione per ridurre l'Italia al livello dell'Egitto o della Polonia di oggi rottamando i diritti delle persone, distruggendo la scuola e la sanità, svendendo il patrimonio dello Stato ai privati ha fatto in Italia troppo strada. L'idea di considerare la lotta di classe un reperto del passato è autolesionistica. Ill conflitto sociale è l'unico regolatore bilaterale o multilaterale dei rapporti interni alla società. La dialettica del conflitto sociale produce progresso. Stimola le imprese verso le innovazioni. Quando le imprese risolvono i problemi riducendo i salari o i diritti invecchiano e vengono superate e diventano presto fuori mercato. La fiat, scaricando da sempre sui salari e sullo Stato le sue difficoltà, produce auto poco competitive e meno buone e solide di quelle della concorrenza. Perde quota e deve produrre in Serbia per competere con coloro che producono auto in Germania o in Francia pagando alti salari e rispettando contratti e leggi sociali che Marchionne vorrebbe stracciare.
Pietro Ancona
già consigliere CNEL
Il peso di tasse e contributi sui salari, il cosiddetto cuneo fiscale, è in Italia al 46,5%. Nella classifica dei maggiori trenta Paesi, aggiornata al 2009, l’Italia è al sesto posto per tassazione sugli stipendi, dopo Belgio (55,2%), Ungheria (53,4%), Germania (50,9%), Francia (49,2%), Austria (47,9%). Il peso di imposte e contributi sui salari in Italia è rimasto stabile dal 2008 al 2009, registrando solo un lieve calo (-0,03%).
http://www.polisblog.it/galleria/classifica-ocse-salari-italia-al-23-posto
E se il problema dell'Italia, delle sue difficoltà che la fanno annaspare non fossero le resistenze frapposte dalla Fiom all'editto Marchionne, ma la Confindustria e la sua incapacità ad indicare una linea di sviluppo e di produzione di profitti che non sia quella dell'assistenzialismo e dei bassi salari?
La Confindustria tedesca credo che abbia molto da insegnare ai sempre più lividi portavoce degli industriali italiani. L'industria tedesca regge con salari quasi doppi di quelli italiani. L'economia generale del Paese è armoniosa ed i negozi non sono deserti come avviene da noi dove la gente non
ha più soldi da spendere oltre quelli necessari alla mera sopravvivenza,.
I sindacati tedeschi assolvono ad un ruolo di responsabilità con la pratica della codecisione.
Ma i loro lavoratori non sono disperati e ridotti alla fame come quelli iscritti ai sindacati italiani di Bonanni, Angeletti ed Epifani che dal 1993 ad oggi tengono i salari fermi e cedono consistenti quote di diritti e di welfare ogni volta che si incontrano con Governo ed Imprenditori. La codecisione tedesca in Italia si traduce in una mera presa d'atto delle decisioni unilaterali delle imprese.
Mettete in fila le dichiarazioni della Marcegaglia ed i documenti di Confindustria degli ultimi venti anni. Un piagnucolio senza fine per chiedere soldi, soldi, soldi (di quelli buoni diceva la Marcegaglia). La Marcegaglia che oramai sfiora la volgarità con la brutalità e le bassezze delle sue accuse verso i lavoratori con accenti sempre più queruli ed isterici chiede favori fiscali per le imprese, sempre meno welfare e sopratutto la riduzione al silenzio dei sindacati di lavoratori che ancora si ostinano a essere tali.
Tutto quello che ha ottenuto non basta mai. Vuole ancora di più, sempre di più. L'ideale è portare il lavoratore italiano allo stesso livello di quello polacco o, meglio, di quello tunisimo. Azzerare quasi il costo della manodopera anche se questo incide sempre di meno sui costi di produzione anche nella industria manifatturiera. Azzerare la spesa sociale dello Stato. La scuola italiana sta per essere ridotta in maceria dalla drastica cura dimagrante della Gelmini. Una scuola al livello della peggiore scuola pubblica delle periferie americane con programmi sempre più dequalificati.
Ora l'abbattimento dei salari già ultimi tra i paesi OCSE non basta più. Tremonti propone anche di evitare i costi per la sicurezza del lavoro. La difettosa ed insufficiente legge italiana gli sembra "un lusso" e pensa di mettere le mani sull'Inail e sull'INPS magari per sfasciarli privatizzandoli. Sembra attirato dalla buona salute finanziaria di cui godono due istituzioni importanti del welfare italiano.
Marchionne si è unito ai pellegrini che ogni anno si recano a Rimini al "famoso" meeting di Comunione e Liberazione una organizzazione che in Italia svolge il ruolo di certe associazioni fondamentaliste della destra statunitense che gli italiani conoscono per le sue intolleranti convinzioni neocon e non per quella che è: un enorme parassita che ha creato un impero economico con appalti si servizi e forniture dalla pubblica amministrazione, con la cosidetta sussidiarietà, i bassissimi salari che corrisponde alle persone che lavorano alle sue dipendenze. Ogni anno l'appuntamento al meeting di CL, come la relazione del governatore della banca d'Utalia, come il Convegno di Cernobbio, scandisce il calendario politico. Gli Oligarchi della politica italiana smaniano per un invito che viene
accordato soltanto a coloro che si distinguono nella lotta contro la classe lavoratrice e la sinistra.
Sarebbe opportuna un approfondimento di CL un esame dei bilanci della Compagnia delle Opere,
e magari scopriremmo quanto è bello, quanto è redditizio e facile, gridare contro lo statalismo e profittare a piene mani delle sue risorse.
L'idea di usare la globalizzazione per ridurre l'Italia al livello dell'Egitto o della Polonia di oggi rottamando i diritti delle persone, distruggendo la scuola e la sanità, svendendo il patrimonio dello Stato ai privati ha fatto in Italia troppo strada. L'idea di considerare la lotta di classe un reperto del passato è autolesionistica. Ill conflitto sociale è l'unico regolatore bilaterale o multilaterale dei rapporti interni alla società. La dialettica del conflitto sociale produce progresso. Stimola le imprese verso le innovazioni. Quando le imprese risolvono i problemi riducendo i salari o i diritti invecchiano e vengono superate e diventano presto fuori mercato. La fiat, scaricando da sempre sui salari e sullo Stato le sue difficoltà, produce auto poco competitive e meno buone e solide di quelle della concorrenza. Perde quota e deve produrre in Serbia per competere con coloro che producono auto in Germania o in Francia pagando alti salari e rispettando contratti e leggi sociali che Marchionne vorrebbe stracciare.
Pietro Ancona
già consigliere CNEL
Il peso di tasse e contributi sui salari, il cosiddetto cuneo fiscale, è in Italia al 46,5%. Nella classifica dei maggiori trenta Paesi, aggiornata al 2009, l’Italia è al sesto posto per tassazione sugli stipendi, dopo Belgio (55,2%), Ungheria (53,4%), Germania (50,9%), Francia (49,2%), Austria (47,9%). Il peso di imposte e contributi sui salari in Italia è rimasto stabile dal 2008 al 2009, registrando solo un lieve calo (-0,03%).
http://www.polisblog.it/galleria/classifica-ocse-salari-italia-al-23-posto
una poesia zigana in onore del popolo rom perseguitato dai governi nazisti francese ed italiano
Libero come la musica zigana
Sono nato sotto una tenda
in una notte d’estate
in un accampamento zingaro
ai margini della citta.
I grilli mi cantavano la ninna nanna
la luna mi fasciava di raggi d’oro
e le donne vestivano gonne fiorite.
Sono crescutio su un carro
dalle ruote scricchiolanti.
Eravamo ragazzi
senza ieri e senza domani
mendicavamo il pane nella pioggia e al sole
correvamo incontro ai nostri sogni
alle nostre fantasie nel bosco.
Ora sono diventato grande
la mia tenda e distrutta
il mio carro si e fermato.
Ma cammino ancora per essere libero
come il vento che scuote il bosco
come l’acqua che scorre verso il mare
come la musica di un violino zigano.
*
Súne fan térne džipén Sinténgre
Dinkráo zénale ves
táli fan súni
smáka kafeiákri tassárla
kráčamen fan u rad
kuándo vúrdia džána veg
an u lámbsko drom.
Bindžeráo u ves
bindžeráo u drom
bindžeráo u fráiapen.
U ruk unt u bar
sikrésman vágane permísse
vágane bráuxa.
E vínta rakrés mánge
vágane gíja
fan bássapen sinténgro.
Kamáo u ves
kamáo u drom
kamáo u fráiapen.
U súni fan u térne džipén
svintíslo ha furt.
Kálča unt máuro
unt kher ápi húfka.
Bus jek drom
dživés man papáli.
Hóski lé mándar u ves
hóski lé mándar u drom
hóski lé mándar u fráiapen?
Sogno d’infanzia zingara
Ricordo verdi boschi
vallate di sogni
profumo di caffe al mattino
scricchiolio di ruote
alla partenza dei carri
verso il lungo cammino.
Conosco il bosco
Sono nato sotto una tenda
in una notte d’estate
in un accampamento zingaro
ai margini della citta.
I grilli mi cantavano la ninna nanna
la luna mi fasciava di raggi d’oro
e le donne vestivano gonne fiorite.
Sono crescutio su un carro
dalle ruote scricchiolanti.
Eravamo ragazzi
senza ieri e senza domani
mendicavamo il pane nella pioggia e al sole
correvamo incontro ai nostri sogni
alle nostre fantasie nel bosco.
Ora sono diventato grande
la mia tenda e distrutta
il mio carro si e fermato.
Ma cammino ancora per essere libero
come il vento che scuote il bosco
come l’acqua che scorre verso il mare
come la musica di un violino zigano.
*
Súne fan térne džipén Sinténgre
Dinkráo zénale ves
táli fan súni
smáka kafeiákri tassárla
kráčamen fan u rad
kuándo vúrdia džána veg
an u lámbsko drom.
Bindžeráo u ves
bindžeráo u drom
bindžeráo u fráiapen.
U ruk unt u bar
sikrésman vágane permísse
vágane bráuxa.
E vínta rakrés mánge
vágane gíja
fan bássapen sinténgro.
Kamáo u ves
kamáo u drom
kamáo u fráiapen.
U súni fan u térne džipén
svintíslo ha furt.
Kálča unt máuro
unt kher ápi húfka.
Bus jek drom
dživés man papáli.
Hóski lé mándar u ves
hóski lé mándar u drom
hóski lé mándar u fráiapen?
Sogno d’infanzia zingara
Ricordo verdi boschi
vallate di sogni
profumo di caffe al mattino
scricchiolio di ruote
alla partenza dei carri
verso il lungo cammino.
Conosco il bosco
giovedì 26 agosto 2010
attacco al diritto alla vita
Attacco al diritto alla vita
Tremonti ha sferrato un attacco frontale alla legge 626 che protegge, parzialmente, la sicurezza dei lavoratori. L'ha definita sprezzantemente "una roba", un lusso che l'Italia non può permettersi. Parla dell'Italia che destina una montagna di soldi all'Oligarchia politica la più privilegiata esistente al mondo e che ha ridotto la fetta di reddito del lavoro dipendente di quindici punti negli ultimi dieci anni. Lo stipendio di Tremonti ministro è maggiore di quello percepito dal presidente degli USA. Non credo che abbia le carte in regola per chiedere al Paese di risparmiare sulla tutela della vita dei lavoratori con una improntitudine e la superbia di chi ha la certezza di non essere contraddetto da sindacati felloni
e da una "sinistra"che non è più tale e pietisce la benevolenza dei ricconi italiani.
L'attacco di Tremonti è generale ed è rivolto a tutta la legge ma credo che punti subito a sollevare le aziende dall'obbligo del pagamento dei salari nei tre giorni cosidetti di carenza in caso di infortunio e probabilmente si propone l'obiettivo di una privatizzazione dell'Inail. Oggi il lavoratore viene curato ed indennizzato ed è possibile che Tremonti pensi ad un regime in cui se un operaio si rompe un braccio o una gamba dovrebbe sbrigarsela da solo. D'altronde la stessa 626 in caso di morte del lavoratore non prevede alcun indennizzo per le famiglie che, per ottenerlo, debbono instaurare una difficile e costosa e magari ventennale causa civile. Può darsi che Tremonti pensa di estendere questa grave inadempienza agli infortuni non mortali. Si tratta di una massa enorme di assistiti.
Da quando il Presidente della Repubblica è intervenuto dando una risposta che non senza escludere le ragioni della Fiat ha indicato nel rispetto della sentenza del Giudice e nel reintegro dei lavoratori la strada maestra da seguire c'è stato un gioco pirotecnico di dichiarazioni di segno opposto. La Marcegaglia è intervenuta per reclamare i diritti della Azienda che per lei sono naturalmente prioritari su quelli dei lavoratori che addirittura andrebbero cancellati. La signora Gelmini, Ministro come Tremonti, ha spezzato la sua lancia a favore della Fiat collocandosi tra i falchi dell'ala destra berlusconiana e preparandosi alla successione secondo il piano da lei stipulato a Siracusa con le altre due sue colleghe di governo.Tremonti che in questi giorni gode della cottura a fuoco lento di Berlusconi e freme per prenderne il posto al più presto non poteva restare indietro. Ha alzato il tiro rispetto la sua collega concorrente e propone addirittura la smobilitazione di una legge che in qualche modo ha ridotto il mostruoso andamento degli infortuni mortali e gravi che avvengono quotidianamente nel lavoro italiano. Siccome è uomo di legge ed è stato per anni commercialista ed estensore materiale della dichiarazione dei redditi delle elites della borghesia padana, non ignora che la 626 recepisce in grande parte normative ineludibili della Unione Europea e per questo naturalmente ha chiesto la sua messa in discussione non soltanto in Italia ma anche in Europa. Il colbertista all'occasione diventa superfalco!
Ricordo che il varo dei decreti delegati della 626 fu assai faticoso. Il governo Prodi ci mise molto tempo e tanti contorcimenti prima di vararli. La Confindustria non li firmò ma ottenne l'abbassamento della pena per i responsabili di infortuni mortali da due anni ad un anno e sei mesi. Ricordo perfettamente che la Cisl ebbe molte esitazioni prima di accettare il testo proponendo diversi emendamenti di alleggerimento delle penali. Inoltre, la legge che Tremonti vorrebbe abrogare, prevede penalità inferiori ai costi che le aziende dovrebbero sopportare per mettersi in regola. Potete immaginare quello che succede nella maggioranza dei casi.....
A distanza di quasi un giorno dalla strabiliante e grave sortita di Tremonti, non ci sono reazioni ufficiali della Cisl e della UIL. La CGIl si è fatta viva, dopo molte ore, con la dichiarazione di una dirigente di secondo piano addetta al settore sicurezza. Ha detto cose giuste e condivisibili ma che tuttavia non costituiscono una reazione adeguata ad un Ministro che è certamente il più importante del governo Berlusconi.
E' come vedere scorrere la storia all'indietro. Altro che le picconate di Cossiga! Ogni giorno c'è qualcosa di fondamentale del nostro ordine civile e democratico che viene aggredito. Dal diritto dei lavoratori di non stare digiuni per otto ore secondo il modulo wmc della fabbrica Italia alla sicurezza stessa della vita dei lavoratori. Chi se ne frega! Importante che le sorti magnifiche e progressive
della ricca e feroce borghesia italiana vengano salvaguardate!
Pietro Ancona
già componente del CNEL
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_626
Tremonti ha sferrato un attacco frontale alla legge 626 che protegge, parzialmente, la sicurezza dei lavoratori. L'ha definita sprezzantemente "una roba", un lusso che l'Italia non può permettersi. Parla dell'Italia che destina una montagna di soldi all'Oligarchia politica la più privilegiata esistente al mondo e che ha ridotto la fetta di reddito del lavoro dipendente di quindici punti negli ultimi dieci anni. Lo stipendio di Tremonti ministro è maggiore di quello percepito dal presidente degli USA. Non credo che abbia le carte in regola per chiedere al Paese di risparmiare sulla tutela della vita dei lavoratori con una improntitudine e la superbia di chi ha la certezza di non essere contraddetto da sindacati felloni
e da una "sinistra"che non è più tale e pietisce la benevolenza dei ricconi italiani.
L'attacco di Tremonti è generale ed è rivolto a tutta la legge ma credo che punti subito a sollevare le aziende dall'obbligo del pagamento dei salari nei tre giorni cosidetti di carenza in caso di infortunio e probabilmente si propone l'obiettivo di una privatizzazione dell'Inail. Oggi il lavoratore viene curato ed indennizzato ed è possibile che Tremonti pensi ad un regime in cui se un operaio si rompe un braccio o una gamba dovrebbe sbrigarsela da solo. D'altronde la stessa 626 in caso di morte del lavoratore non prevede alcun indennizzo per le famiglie che, per ottenerlo, debbono instaurare una difficile e costosa e magari ventennale causa civile. Può darsi che Tremonti pensa di estendere questa grave inadempienza agli infortuni non mortali. Si tratta di una massa enorme di assistiti.
Da quando il Presidente della Repubblica è intervenuto dando una risposta che non senza escludere le ragioni della Fiat ha indicato nel rispetto della sentenza del Giudice e nel reintegro dei lavoratori la strada maestra da seguire c'è stato un gioco pirotecnico di dichiarazioni di segno opposto. La Marcegaglia è intervenuta per reclamare i diritti della Azienda che per lei sono naturalmente prioritari su quelli dei lavoratori che addirittura andrebbero cancellati. La signora Gelmini, Ministro come Tremonti, ha spezzato la sua lancia a favore della Fiat collocandosi tra i falchi dell'ala destra berlusconiana e preparandosi alla successione secondo il piano da lei stipulato a Siracusa con le altre due sue colleghe di governo.Tremonti che in questi giorni gode della cottura a fuoco lento di Berlusconi e freme per prenderne il posto al più presto non poteva restare indietro. Ha alzato il tiro rispetto la sua collega concorrente e propone addirittura la smobilitazione di una legge che in qualche modo ha ridotto il mostruoso andamento degli infortuni mortali e gravi che avvengono quotidianamente nel lavoro italiano. Siccome è uomo di legge ed è stato per anni commercialista ed estensore materiale della dichiarazione dei redditi delle elites della borghesia padana, non ignora che la 626 recepisce in grande parte normative ineludibili della Unione Europea e per questo naturalmente ha chiesto la sua messa in discussione non soltanto in Italia ma anche in Europa. Il colbertista all'occasione diventa superfalco!
Ricordo che il varo dei decreti delegati della 626 fu assai faticoso. Il governo Prodi ci mise molto tempo e tanti contorcimenti prima di vararli. La Confindustria non li firmò ma ottenne l'abbassamento della pena per i responsabili di infortuni mortali da due anni ad un anno e sei mesi. Ricordo perfettamente che la Cisl ebbe molte esitazioni prima di accettare il testo proponendo diversi emendamenti di alleggerimento delle penali. Inoltre, la legge che Tremonti vorrebbe abrogare, prevede penalità inferiori ai costi che le aziende dovrebbero sopportare per mettersi in regola. Potete immaginare quello che succede nella maggioranza dei casi.....
A distanza di quasi un giorno dalla strabiliante e grave sortita di Tremonti, non ci sono reazioni ufficiali della Cisl e della UIL. La CGIl si è fatta viva, dopo molte ore, con la dichiarazione di una dirigente di secondo piano addetta al settore sicurezza. Ha detto cose giuste e condivisibili ma che tuttavia non costituiscono una reazione adeguata ad un Ministro che è certamente il più importante del governo Berlusconi.
E' come vedere scorrere la storia all'indietro. Altro che le picconate di Cossiga! Ogni giorno c'è qualcosa di fondamentale del nostro ordine civile e democratico che viene aggredito. Dal diritto dei lavoratori di non stare digiuni per otto ore secondo il modulo wmc della fabbrica Italia alla sicurezza stessa della vita dei lavoratori. Chi se ne frega! Importante che le sorti magnifiche e progressive
della ricca e feroce borghesia italiana vengano salvaguardate!
Pietro Ancona
già componente del CNEL
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_626
mercoledì 25 agosto 2010
Torniamo alla grande allo schiavismo delle origini dell'Occidente
Poveri e ricchi Gli uomini antichi potevano essere diversi tra loro per lingua, religione, modo di vestire, ma una cosa accomunava la stragrande maggioranza di essi: la povertà. A Sparta come a Siracusa, a Cartagine come a Roma, le masse popolari avevano appena di che vestirsi e sfamarsi. Eppure abbiamo spesso parlato di terre fertili e ben coltivate, di fonti inesauribili di materie prime, di botteghe artigiane attive e fiorenti, di traffici su vasta scala. Come spiegare il meccanismo che nonostante queste condizioni, produceva tanta miseria? Rispondere a questa domanda significa affrontare il complesso problema dell'economia antica.II modo di produzione schiavisticoUn sistema economico si identifica con il suo « modo di produzione ». Il modo di produzione è determinato da due fattori:le forze produttive, che comprendono: i mezzi di produzione, cioè le materie prime da una parte, gli strumenti di lavoro dall'altra; la forza-lavoro, cioè il lavoro degli uomini che, avvalendosi degli strumenti, trasformano le materie prime in prodotti finiti (ad esempio trasformano il ferro in una falce, l'argilla in un vaso); 2. i rapporti di produzione, cioè i rapporti che legano il lavoratore al proprietario dei mezzi di produzione.Nel mondo classico i mezzi di produzione consistevano soprattutto nella terra; la forza-lavoro era prevalentemente costituita da schiavi; i rapporti di produzione erano quelli tra proprietari di terra (e di schiavi) e schiavi. Proprio per questo la sua economia viene definita modo di produzione schiavistico.L'impiego massiccio della schiavitù cominciò ad Atene nel v secolo, raggiunse il culmine a Roma tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C. e declinò nei secoli successivi. Gli schiavi lavoravano come domestici nelle case private, come operai nelle botteghe artigiane o come minatori nelle cave o nelle miniere; ma soprattutto costituivano la larghissima maggioranza dei lavoratori agricoli. I grandi proprietari terrieri ne possedevano a centinaia, i piccoli contadini ne avevano solo due o tre, ma nessuno poteva farne a meno.Lo schiavo era un oggetto nelle mani del suo padrone. Una volta che questi l'aveva comprato, il rapporto economico tra i due diventava estremamente semplice: lo schiavo era uno strumento che faceva parte integrante della terra, come l'aratro, il bue che lo tirava e le altre attrezzature agricole.La ricchezza, come abbiamo detto, era soprattutto agraria. Ciò non vuol dire che non esistessero altre attività economiche al di fuori dell'agricoltura; esse però erano attività nettamente marginali. Il proprietario terriero, che ricavava dai suoi campi una certa rendita, poteva farla fruttare investendola nel commercio; non era difficile per lui riempire la stiva di una nave e farne vendere il carico in terre lontane. Ma la destinazione ultima della ricchezza era sempre la terra; qualsiasi guadagno, appena possibile, veniva impiegato per acquistare nuovi campi, nuovi poderi.È vero anche che nell'antichità esistevano popolazioni (per esempio i Fenici) o città (per esempio Corinto) la cui attività era prevalentemente commerciale; ma il loro ruolo era del tutto secondario rispetto alla maggioranza assoluta dei popoli che basavano la loro economia sull'agricoltura.Industria e consumatoriGli uomini di condizione libera che non possedevano terra praticavano attività di vario genere: erano bottegai, artigiani, braccianti utilizzati saltuariamente nei lavori agricoli accanto agli schiavi; oppure campavano di espedienti, si arruolavano come mercenari in eserciti stranieri, vivevano di elemosina. Tutti costoro, a parte qualche eccezione, avevano appena di che sfamarsi e vestirsi ed erano poveri proprio perché erano esclusi dal settore fondamentale della produzione, che si fondava sul lavoro schiavile.Il ruolo della schiavitù è dunque centrale per comprendere la netta distinzione tra poveri e ricchi, che caratterizza il mondo classico, e per valutare appieno le differenze tra l'economia degli antichi e quella del mondo moderno. Alla base dell'economia moderna c'è la grande industria; essa presuppone una richiesta continua da parte dei consumatori, sufficientemente ampia da giustificare l'enorme impiego di capitali investiti nell'acquisto di macchinari. Questi consumatori sono in grandissima parte gli stessi operai salariati che lavorano nell'industria. Nel mondo antico una produzione industriale su vasta scala, paragonabile a quella moderna, non si è mai sviluppata proprio perché mancava la sua condizione di base: una massa di consumatori sufficientemente estesa; gli schiavi infatti, che costituivano la manodopera prevalente, non avevano capacità d'acquisto perché non ricevevano salario. Ecco per quale ragione i grossi capitali derivati dall'agricoltura e dalle altre attività economiche non avevano altra destinazione che l'acquisto di terre.Le spese dei ricchiÈ chiaro tuttavia che le ricchezze, talvolta enormi, di cui disponevano i grandi proprietari, non erano interamente devolute all'acquisto di nuove terre; restava sempre una quantità cospicua di denaro che i ricchi spendevano in altro modo.Il lussoSomme ingenti venivano profuse nell'acquisto di case, gioielli, vasellame prezioso, opere d'arte, mobilio pregiato, stoffe o per organizzare ricevimenti sfarzosi. Tutto questo lusso rientrava nei piacevoli « doveri » dell'uomo ricco, il cui prestigio sociale era proporzionale all'esibizione delle sue ricchezze.L'evergetismoQuesto prestigio costava caro anche per un altro motivo. Feste e spettacoli pubblici, distribuzioni di viveri, costruzione di templi e di altri monumenti, contributi in caso di calamità naturali o di guerre, forniture di armi, infatti, erano in gran parte a carico dei cittadini più in vista. I ricchi dunque erano tenuti a elargire alla collettività una fetta, spesso notevole, dei loro guadagni. Questo fenomeno, tipico del mondo greco-romano, è noto come « evergetismo » da euergétes, « benefattore ».Alcuni andavano fieri di questo ruolo di pubblici finanziatori, che sentivano come un obbligo morale e come un onore, tanto più che queste dimostrazioni di generosità verso i concittadini erano la forma di propaganda migliore per chi voleva intraprendere la carriera politica. Ad Alcibiade, per esempio, era capitato un vero e proprio colpo di fortuna quando dei sette cocchi che aveva equipaggiato in nome della città di Atene per le gare di Olimpia, uno aveva vinto, un altro aveva ottenuto il secondo posto e un altro ancora il quarto; questo piazzamento, eccezionale nella storia delle Olimpiadi, era stato il migliore trampolino di lancio per la sua carriera politica.Il peso di questi contributi, però, era enorme, tanto da far vacillare alcune fortune. A un ricco giovanotto che scialacquava il proprio denaro senza pensare al futuro, il suo maestro ricordava così i gravi obblighi che lo attendevano una volta entrato a far parte del corpo sociale:Sarai obbligato a offrire spessissimo sontuosi sacrifici, altrimenti cadrai in disgrazia con gli uomini e con gli dei. Ti toccherà anche ricevere molti ospiti stranieri, e non potrai certo mostrarti avaro. Dovrai offrire pasti ai concittadini, altrimenti non avrai nessuno dalla tua parte. Ma non è finita qui; la città t'imporrà tutta una serie di spese assai gravose: allevare cavalli, mettere in scena tragedie e commedie, finanziare gare di ginnastica. Se scoppia la guerra, sarai tenuto ad armare parecchie triremi o a versare contributi straordinari. Insomma, ti troverai a malpartito con tutte queste spese; ma stai bene attento: se darai l'impressione di non assolvere a questi obblighi come si deve, gli Ateniesi ti puniranno severamente, come se ti cogliessero a rubare nelle loro case. (Senofonte)Di fronte a questa lunga serie t'impegni finanziari imposti dalla comunità, non stupisce che qualcuno tentasse di sottrarvisi, anche a costo di suscitare disprezzo, odio, o addirittura violente reazioni popolari. Cittadini e tasseTra i tanti privilegi dei cittadini di pieno diritto, c'era quello di non pagare tasse. Qualsiasi greco avrebbe sentito come un'umiliazione e un sopruso l'imposizione fiscale sui propri rettiti; nelle comunità antiche le tasse le pagavano soltanto i « sudditi » o gli stranieri residenti. Ad Atene, per esempio, buona parte delle entrate finanziarie dipendevano dai tributi versati dalle città della lega di Delo o dai meteci; le uniche tasse che pagavano anche i cittadini erano i dazi doganali sull'importazione, l'esportazione o la vendita delle merci, riscossi nei porti, all'entrata delle città o nei mercati.Questo sistema rendeva estremamente precarie le finanze delle poleis antiche, soprattutto di quelle che non avevano un « impero » da sfruttare. Il loro funzionamento, in pace come in guerra, non poteva quindi fare a meno della « beneficenza » dei ricchi.
lunedì 23 agosto 2010
arroganza del pd
Fa bene Franceschini a dire di non temere le elezioni e di pensare di poterle vincere. Il ricatto dello scioglimento delle Camere deve essere respinto. Sono convinto che non ci sarà un plebiscito per riportare la Cricca P3 ed il suo Capo al governo! Sono anche dell'opinione che non dobbiamo aspettarci dai prossimi tre anni che disgrazie violenze e sfascio dell'ordinamento costituzionale dello Stato ed altri sfasci nel sistema economico. Tutto sommato, anche se il voto è una sorta di salto nel buio è meglio che assistere all'agonia dello Stato e della sua Costituzione.
La situazione sociale è diventata davvero critica mentre il mare antistante Villa Certosa è popolato di panfili di lusso sfacciato della imprenditoria ladrona e scroccona.
Le privatizzazioni volute bipartisan hanno aumentato i costi di tutti i servizi e spesso hanno mancato
i loro obiettivi. Dovunque i privati si sono inseriti nella gestione dell'acqua o della nettezza urbana le tariffe sono diventate insopportabili, esosissime ed i servizi sono peggiorati. Le privatizzazioni del sistema di notificazione e riscossione delle imposte ha portato agghiaccianti ed inaccettabili vessazioni per chi ha avuto la disgrazia di saltare qualche pagamento. Casa e beni ipotecati. Ganasce alle auto o alle moto. La devastazione dei licenziamenti per chiusura o delocalizzazione degli impianti (che sembra non interessare nessuno neppure i sindacati) ha creato una compressione dei salari durissima che ha effetti sui consumi. Solo i negozi di lusso non subiscono crisi. Ma i grandi empori popolari registrano le difficoltà di una clientela impoverita che forse entra nei supermercati solo per godersi il fresco o fare compere rituali come la famiglia del Marcovaldo di Calvino. La scuola è stata sfasciata dalla signora Gelmini assistita all'uopo da un micidiale "genio" di guastatori, conoscitore profondo della foresta quasi impenetrabile degli insegnanti. Non avevo mai visto piangere un professore. L'ho visto oggi, a Palermo, dove sono stati fatti saltare seimila posti di lavoro. Gente che da venti anni non ha fatto altro che insegnare dove potremmo occuparla? Di che cosa camperanno le loro famiglie? Che cosa sta diventando la scuola italiana? Il panico si è impadronito di migliaia di famiglie che non sanno cosa faranno a ottobre. Anche la Sanità corre i suoi grossi rischi ma la tengono in vita perchè nutre i nuovi imperi economici della scroccona e ricchissima borghesia italiana capace di esportare trecento miliardi di euro in grande parte sottratti ai loro dipendenti ed allo Stato. L'impero di Ajello a Palermo, quello degli Angelucci nel Lazio e altrove, la fantastica e quasi miracolistica opera di Don Verzè in Lombardia. In abruzzo abbiamo avuto le mirabolanti vicende di Del Turco ed Angelini. Insomma, la sanità fornisce il carburante ad un sistema di cliniche convenzionate che non durerebbe due giorni se dovesse reggersi da solo. Nel mezzogiorno d'Italia stanno bene soltanto coloro che si sono ammanigliati alle Regioni. Migliaia e migliaia di persone vivono di politica accanto agli Oligarchi superpagati e superprivilegiati mentre attorno a loro si fa il deserto. Il Sud aveva una sua risorsa sin dalla fondazione della Repubblica nella pubblica amministrazione: forniva quadri alla magistratura, alla scuola, all'esercito. L'attacco al welfare ha chiuso questo vitale sbocco ai figli della media borghesia e del ceto popolare. Una ragione della unità d'Italia sta venendo meno e un'area grande quando il Regno delle Due Sicilie è stata spinta alla disperazione. Quanto tempo potranno resistere ancora i cassintegrati dell'Asinara giunti al 173° giorno senza che l'Eni, una multinazionale tra le più potenti del mondo di proprietà dello Stato , li abbia degnati di uno sguardo? Nei prossimi quattro mesi conteremo le macerie di quel che resta del sistema industriale meridionale.
Sei milioni di giovani vivono dei contratti-truffa inventati dalla Legge Biagi. Guadagnano la metà dei minimi salariali e galleggiano per la ciambella di salvataggio delle famiglie dove le pensioni ancora decenti dei loro genitori integrano il meschinissimo reddito cocopro o partita iva o interinale o altro.
Questi sono alcuni tratti della realtà del lavoro italiano. Eppure l'Italia è la settima potenza industriale del mondo per PIL. Ma è al trentesimo posto dell'OCSE per salari. Anche i diritti cominciano ad essere seriamente intaccati.
Ora al PD di Franceschini e dei suoi colleghi questa situazione che ho accennato non sembra interessare. Nessuno dei problemi che ho evocato è nella loro agenda.
L'unica scienza della quale si occupano è la politologia.Con arroganza eguale a quella di Berlusconi
chiedono a tutte le opposizioni di unirsi a loro per abbattere Berlusconi. Ma non dicono la verità e cioè che la loro vera intenzione è quella di avere con loro Casini dal momento che il loro programma è simile a quello del centro-destra. Pare che continuino a pensare ad una sorta di conventio ad excludendum per i comunisti ed i verdi rimasti fuori dal Parlamento dopo essere stati dissanguati dal sostegno al governo Prodi. Hanno ancora qualche esitazione su Vendola e sul suo raggruppamento ma non intendono cedergli la leadership del centro-sinistra.
L'Italia è tra l'incudine ed il martello. Il PD sta con Marchionne e la Marcegaglia e fa prediche "moderniste" ai metalmeccanici e la Fiom. Nessuna condanna per Marchionne da parte del Pd e della CGIL. Solo una tiratina d'orecchie da Epifani che lo accusa di "non fare gli interessi della Fiat!" E' impressionante notare nel successore di Di Vittorio come il suo ragionamento riguardi soltanto l'azienda e la sua strategia che - consiglia - dovrebbe essere più scaltra. I consigli che rivolge non sono di cambiare linea ma di essere più prudente per non creare imbarazzi negli amici sindacalisti. . Il sindacato italiano non è ancora al livello dei Kapò americani che spiano e controllano il rendimento degli operai e quanti minuti si prendono per fare la pipì ma è sulla buona strada...
Pietro Ancona
http://medioevosociale-pietro.blogspot.com/
www.spazioamico.it
La situazione sociale è diventata davvero critica mentre il mare antistante Villa Certosa è popolato di panfili di lusso sfacciato della imprenditoria ladrona e scroccona.
Le privatizzazioni volute bipartisan hanno aumentato i costi di tutti i servizi e spesso hanno mancato
i loro obiettivi. Dovunque i privati si sono inseriti nella gestione dell'acqua o della nettezza urbana le tariffe sono diventate insopportabili, esosissime ed i servizi sono peggiorati. Le privatizzazioni del sistema di notificazione e riscossione delle imposte ha portato agghiaccianti ed inaccettabili vessazioni per chi ha avuto la disgrazia di saltare qualche pagamento. Casa e beni ipotecati. Ganasce alle auto o alle moto. La devastazione dei licenziamenti per chiusura o delocalizzazione degli impianti (che sembra non interessare nessuno neppure i sindacati) ha creato una compressione dei salari durissima che ha effetti sui consumi. Solo i negozi di lusso non subiscono crisi. Ma i grandi empori popolari registrano le difficoltà di una clientela impoverita che forse entra nei supermercati solo per godersi il fresco o fare compere rituali come la famiglia del Marcovaldo di Calvino. La scuola è stata sfasciata dalla signora Gelmini assistita all'uopo da un micidiale "genio" di guastatori, conoscitore profondo della foresta quasi impenetrabile degli insegnanti. Non avevo mai visto piangere un professore. L'ho visto oggi, a Palermo, dove sono stati fatti saltare seimila posti di lavoro. Gente che da venti anni non ha fatto altro che insegnare dove potremmo occuparla? Di che cosa camperanno le loro famiglie? Che cosa sta diventando la scuola italiana? Il panico si è impadronito di migliaia di famiglie che non sanno cosa faranno a ottobre. Anche la Sanità corre i suoi grossi rischi ma la tengono in vita perchè nutre i nuovi imperi economici della scroccona e ricchissima borghesia italiana capace di esportare trecento miliardi di euro in grande parte sottratti ai loro dipendenti ed allo Stato. L'impero di Ajello a Palermo, quello degli Angelucci nel Lazio e altrove, la fantastica e quasi miracolistica opera di Don Verzè in Lombardia. In abruzzo abbiamo avuto le mirabolanti vicende di Del Turco ed Angelini. Insomma, la sanità fornisce il carburante ad un sistema di cliniche convenzionate che non durerebbe due giorni se dovesse reggersi da solo. Nel mezzogiorno d'Italia stanno bene soltanto coloro che si sono ammanigliati alle Regioni. Migliaia e migliaia di persone vivono di politica accanto agli Oligarchi superpagati e superprivilegiati mentre attorno a loro si fa il deserto. Il Sud aveva una sua risorsa sin dalla fondazione della Repubblica nella pubblica amministrazione: forniva quadri alla magistratura, alla scuola, all'esercito. L'attacco al welfare ha chiuso questo vitale sbocco ai figli della media borghesia e del ceto popolare. Una ragione della unità d'Italia sta venendo meno e un'area grande quando il Regno delle Due Sicilie è stata spinta alla disperazione. Quanto tempo potranno resistere ancora i cassintegrati dell'Asinara giunti al 173° giorno senza che l'Eni, una multinazionale tra le più potenti del mondo di proprietà dello Stato , li abbia degnati di uno sguardo? Nei prossimi quattro mesi conteremo le macerie di quel che resta del sistema industriale meridionale.
Sei milioni di giovani vivono dei contratti-truffa inventati dalla Legge Biagi. Guadagnano la metà dei minimi salariali e galleggiano per la ciambella di salvataggio delle famiglie dove le pensioni ancora decenti dei loro genitori integrano il meschinissimo reddito cocopro o partita iva o interinale o altro.
Questi sono alcuni tratti della realtà del lavoro italiano. Eppure l'Italia è la settima potenza industriale del mondo per PIL. Ma è al trentesimo posto dell'OCSE per salari. Anche i diritti cominciano ad essere seriamente intaccati.
Ora al PD di Franceschini e dei suoi colleghi questa situazione che ho accennato non sembra interessare. Nessuno dei problemi che ho evocato è nella loro agenda.
L'unica scienza della quale si occupano è la politologia.Con arroganza eguale a quella di Berlusconi
chiedono a tutte le opposizioni di unirsi a loro per abbattere Berlusconi. Ma non dicono la verità e cioè che la loro vera intenzione è quella di avere con loro Casini dal momento che il loro programma è simile a quello del centro-destra. Pare che continuino a pensare ad una sorta di conventio ad excludendum per i comunisti ed i verdi rimasti fuori dal Parlamento dopo essere stati dissanguati dal sostegno al governo Prodi. Hanno ancora qualche esitazione su Vendola e sul suo raggruppamento ma non intendono cedergli la leadership del centro-sinistra.
L'Italia è tra l'incudine ed il martello. Il PD sta con Marchionne e la Marcegaglia e fa prediche "moderniste" ai metalmeccanici e la Fiom. Nessuna condanna per Marchionne da parte del Pd e della CGIL. Solo una tiratina d'orecchie da Epifani che lo accusa di "non fare gli interessi della Fiat!" E' impressionante notare nel successore di Di Vittorio come il suo ragionamento riguardi soltanto l'azienda e la sua strategia che - consiglia - dovrebbe essere più scaltra. I consigli che rivolge non sono di cambiare linea ma di essere più prudente per non creare imbarazzi negli amici sindacalisti. . Il sindacato italiano non è ancora al livello dei Kapò americani che spiano e controllano il rendimento degli operai e quanti minuti si prendono per fare la pipì ma è sulla buona strada...
Pietro Ancona
http://medioevosociale-pietro.blogspot.com/
www.spazioamico.it
domenica 22 agosto 2010
le donne della repubblica di ieri e di oggi: Carla Voltolina
nel leggere le squallide vicende di tante prime donne della politica italiana di oggi tutte impastate di concreti interessi e spesso animate dall'avidità, dalla avarizia, dal lusso, dal giro frenetico di soldi, di case, di panfili e quanto altro oggi distingue una casta di Oligarchi con Oligarche e famiglie di voraci parassiti
ho ricordato che non sempre l'Italia è stata così e che al vertice dello Stato abbiamo avuto mogli e compagne di grande spessore morale e politico che hanno anche contribuito a fare l'Italia con la Resistenza e la Lotta di Liberazione ed anche le lotte per l'emancipazione dei lavoratori ed i diritti delle donne.
Comincio quindi a ricordare le biografie di alcune grandi donne con Carla Voltolina, moglie di Sandro Pertini.
==0========
Corriere della Sera >Archivio >Muore la moglie di Pertini «Sandro, un grande amore»Archivio storico
IL PERSONAGGIO / Sposò l' ex presidente nel ' 46: un uomo affascinante, forte ed educato. Mi insegnò a dissentire, ma con educazioneMuore la moglie di Pertini «Sandro, un grande amore»Carla Voltolina, ex staffetta partigiana, aveva 84 anni Al Quirinale preferì la vita ritirata: io lì? Mai e poi maiROMA - Carla Voltolina, ovvero l' antiretorica fatta moglie di un personaggio come Sandro Pertini. Dal febbraio 1990, quando il suo mondo s' era sfigurato per sempre con la morte di quell' uomo, aveva scelto uno slogan che ripeteva alle cerimonie o agli incontri con i ragazzi delle nuove generazioni: «Che volete che dica ancora? Sandro è stato per me un grande amore, un grande maestro, un grande socialista». Ancora più completa una definizione affidata a Mario Capanna, che la raccoglie e la scrive su Sette nel settembre 1996: «Un uomo affascinante, educato, forte, altruista, generoso, mai una slealtà. Un grande amore. Un grande compagno». Un solo aggettivo per espressioni diverse: grande. Conosce Pertini nel 1944 a Torino e lo sposa l' 8 giugno 1946. Lui le ha insegnato (ancora Capanna) a «dissentire ma con educazione». Sarebbe ingeneroso ridurre la sua personale storia di vita a quel patto matrimoniale. Alta, bruna, una bellezza da foto Luxardo, gran temperamento, eccellente nuotatrice, nasce a Torino nel 1921 da una famiglia borghese. Insomma, impossibile non notarla. Diventa staffetta partigiana nella sua città (dove conosce Sandro e i 25 anni di differenza non ostacolano un amore lungo quasi mezzo secolo) poi nelle Marche, dove viene arrestata dalle SS, a Roma (accanto a Eugenio Colorni) e a Milano. Due lauree (Scienze politiche e Psicologia), lunghe collaborazioni a Il lavoro di Genova e a Noi donne: inchieste sulle carceri, sulle prostitute, sugli anziani. Per le edizioni de L' avanti pubblica con Lina Merlin il volume Lettere dalle case chiuse, in pieno appoggio all' abolizione della prostituzione organizzata. Quindi il lungo impegno come psicologa nei servizi romani di farmacodipendenza, alcolismo e cura psichiatrica. A tutto questo, cioè tantissimo, occorre aggiungere la vita di Carla Pertini, come non si è mai fatta chiamare davvero. A lei, di quello specialissimo lui, per prima cosa piace la voce. Il legame diventa d' acciaio («lui mi ha amato moltissimo, certo. Ma anch' io l' ho amato. Forse di più») cementato da mille interessi comuni. Ovviamente la passione politica, la fede socialista. La pittura e l' amicizia con tanti artisti: Guttuso, Vedova, Turcato, Manzù. Il teatro: li incontravi spesso, a Roma, lui con la pipa spenta tra i denti e lei nelle sue indicibili toilettes, famoso fu un suo smoking da uomo (pantaloni, cravatta nera, fascia) indossato a una prima all' Argentina. La presidenza della Camera non modifica i loro ritmi. Ogni tanto la vita pubblica irrompe nella privata. Capita dopo l' uccisione di Moro, due mesi prima di arrivare al Quirinale: «Se le Br mi rapissero, considerate falsi ed estorti i miei eventuali scritti», scrive alla moglie, l' unica di cui si fida davvero. Ma nemmeno la presidenza della Repubblica altera un equilibrio assai strano per i riti e le ambizioni della politica italiana. Lei affida la promessa a un' indiscrezione lasciata circolare senza fatica di smentite («io al Quirinale? mai e poi mai»). E resta al suo posto: il lavoro in ospedale tra i drogati e gli alcolizzati, la sera nella mansarda accanto a Fontana di Trevi, un cunicolo di stanzette, un bagnetto ricavato, un angolo cottura ma con la libertà di vista sui tetti di Roma. Lei chiama il Quirinale «quel lavoro lì» e si lamenta di vederlo troppo poco, lui non le chiede mai un impegno da First Lady. Solo una volta lei lo accompagna in Cina per curiosità, dice, e anche per seguire una terapia dell' agopuntore professor Wu. Diventa amica di Juan Carlos di Spagna e di altri potenti ma senza obbligo di banchetti e di brindisi. Poi Sandro nel 1984 torna a casa, i due festeggiano con un pranzetto solitario in campagna. Passano altri sei anni tranquilli. Infine nel febbraio 1990 lui muore battendo la testa in bagno dopo uno scivolone. L' antiretorica torna nelle immagini che la ritraggono mentre accompagna la bara al crematorio romano. Un addio con un cenno della mano destra. Poi l' urna stretta tra le braccia. Gli ultimi quindici anni registrano una Carla Voltolina impegnata a raccontare il suo Sandro. Ne parla sempre al presente («Sandro dice, Sandro vuole...»). Nel novembre 1992 il missino Giulio Caradonna chiede di sapere che fine abbiano fatto i quadri che gli regalarono da presidente. E lei: «Caradonna, imbecille, bastava informarsi, tutto è custodito al museo Pertini di Savona». Decide di affrontare i capelli bianchi tingendoli di rosso tiziano. Si amareggia per Tangentopoli che travolge il suo Psi: «Io sto dalla parte dei giudici, facciano pulizia, vadano fino in fondo. I ladri vanno puniti. Lo dice anche il settimo comandamento». Regala la pipa di Pertini a Bruno Trentin segretario della Cgil. Ogni tanto affida a una tintoria un vecchio abito del marito custodito in armadio: «L' ho fatto rimettere a posto, qui vicino c' è un signore che se la passa male, oggi glielo regalo». L' estremo bagno di folla, lei che non ne aveva mai avuti, risale al 25 aprile scorso quando Ciampi la saluta in piazza Duomo a Milano «a nome di tutti gli italiani», la piazza l' applaude e lei si commuove. L' ultima firma sotto un appello risale appena al 30 novembre: una richiesta a Ciampi da parte del Comitato pressione per le leggi paritarie. Nel 1997 subisce un' importante operazione chirurgica a Roma. Ovviamente all' ospedale «Sandro Pertini», fa sapere a tutti con soddisfatta, comprensibile civetteria. Paolo Conti LA VITAConti Paolo
ho ricordato che non sempre l'Italia è stata così e che al vertice dello Stato abbiamo avuto mogli e compagne di grande spessore morale e politico che hanno anche contribuito a fare l'Italia con la Resistenza e la Lotta di Liberazione ed anche le lotte per l'emancipazione dei lavoratori ed i diritti delle donne.
Comincio quindi a ricordare le biografie di alcune grandi donne con Carla Voltolina, moglie di Sandro Pertini.
==0========
Corriere della Sera >Archivio >Muore la moglie di Pertini «Sandro, un grande amore»Archivio storico
IL PERSONAGGIO / Sposò l' ex presidente nel ' 46: un uomo affascinante, forte ed educato. Mi insegnò a dissentire, ma con educazioneMuore la moglie di Pertini «Sandro, un grande amore»Carla Voltolina, ex staffetta partigiana, aveva 84 anni Al Quirinale preferì la vita ritirata: io lì? Mai e poi maiROMA - Carla Voltolina, ovvero l' antiretorica fatta moglie di un personaggio come Sandro Pertini. Dal febbraio 1990, quando il suo mondo s' era sfigurato per sempre con la morte di quell' uomo, aveva scelto uno slogan che ripeteva alle cerimonie o agli incontri con i ragazzi delle nuove generazioni: «Che volete che dica ancora? Sandro è stato per me un grande amore, un grande maestro, un grande socialista». Ancora più completa una definizione affidata a Mario Capanna, che la raccoglie e la scrive su Sette nel settembre 1996: «Un uomo affascinante, educato, forte, altruista, generoso, mai una slealtà. Un grande amore. Un grande compagno». Un solo aggettivo per espressioni diverse: grande. Conosce Pertini nel 1944 a Torino e lo sposa l' 8 giugno 1946. Lui le ha insegnato (ancora Capanna) a «dissentire ma con educazione». Sarebbe ingeneroso ridurre la sua personale storia di vita a quel patto matrimoniale. Alta, bruna, una bellezza da foto Luxardo, gran temperamento, eccellente nuotatrice, nasce a Torino nel 1921 da una famiglia borghese. Insomma, impossibile non notarla. Diventa staffetta partigiana nella sua città (dove conosce Sandro e i 25 anni di differenza non ostacolano un amore lungo quasi mezzo secolo) poi nelle Marche, dove viene arrestata dalle SS, a Roma (accanto a Eugenio Colorni) e a Milano. Due lauree (Scienze politiche e Psicologia), lunghe collaborazioni a Il lavoro di Genova e a Noi donne: inchieste sulle carceri, sulle prostitute, sugli anziani. Per le edizioni de L' avanti pubblica con Lina Merlin il volume Lettere dalle case chiuse, in pieno appoggio all' abolizione della prostituzione organizzata. Quindi il lungo impegno come psicologa nei servizi romani di farmacodipendenza, alcolismo e cura psichiatrica. A tutto questo, cioè tantissimo, occorre aggiungere la vita di Carla Pertini, come non si è mai fatta chiamare davvero. A lei, di quello specialissimo lui, per prima cosa piace la voce. Il legame diventa d' acciaio («lui mi ha amato moltissimo, certo. Ma anch' io l' ho amato. Forse di più») cementato da mille interessi comuni. Ovviamente la passione politica, la fede socialista. La pittura e l' amicizia con tanti artisti: Guttuso, Vedova, Turcato, Manzù. Il teatro: li incontravi spesso, a Roma, lui con la pipa spenta tra i denti e lei nelle sue indicibili toilettes, famoso fu un suo smoking da uomo (pantaloni, cravatta nera, fascia) indossato a una prima all' Argentina. La presidenza della Camera non modifica i loro ritmi. Ogni tanto la vita pubblica irrompe nella privata. Capita dopo l' uccisione di Moro, due mesi prima di arrivare al Quirinale: «Se le Br mi rapissero, considerate falsi ed estorti i miei eventuali scritti», scrive alla moglie, l' unica di cui si fida davvero. Ma nemmeno la presidenza della Repubblica altera un equilibrio assai strano per i riti e le ambizioni della politica italiana. Lei affida la promessa a un' indiscrezione lasciata circolare senza fatica di smentite («io al Quirinale? mai e poi mai»). E resta al suo posto: il lavoro in ospedale tra i drogati e gli alcolizzati, la sera nella mansarda accanto a Fontana di Trevi, un cunicolo di stanzette, un bagnetto ricavato, un angolo cottura ma con la libertà di vista sui tetti di Roma. Lei chiama il Quirinale «quel lavoro lì» e si lamenta di vederlo troppo poco, lui non le chiede mai un impegno da First Lady. Solo una volta lei lo accompagna in Cina per curiosità, dice, e anche per seguire una terapia dell' agopuntore professor Wu. Diventa amica di Juan Carlos di Spagna e di altri potenti ma senza obbligo di banchetti e di brindisi. Poi Sandro nel 1984 torna a casa, i due festeggiano con un pranzetto solitario in campagna. Passano altri sei anni tranquilli. Infine nel febbraio 1990 lui muore battendo la testa in bagno dopo uno scivolone. L' antiretorica torna nelle immagini che la ritraggono mentre accompagna la bara al crematorio romano. Un addio con un cenno della mano destra. Poi l' urna stretta tra le braccia. Gli ultimi quindici anni registrano una Carla Voltolina impegnata a raccontare il suo Sandro. Ne parla sempre al presente («Sandro dice, Sandro vuole...»). Nel novembre 1992 il missino Giulio Caradonna chiede di sapere che fine abbiano fatto i quadri che gli regalarono da presidente. E lei: «Caradonna, imbecille, bastava informarsi, tutto è custodito al museo Pertini di Savona». Decide di affrontare i capelli bianchi tingendoli di rosso tiziano. Si amareggia per Tangentopoli che travolge il suo Psi: «Io sto dalla parte dei giudici, facciano pulizia, vadano fino in fondo. I ladri vanno puniti. Lo dice anche il settimo comandamento». Regala la pipa di Pertini a Bruno Trentin segretario della Cgil. Ogni tanto affida a una tintoria un vecchio abito del marito custodito in armadio: «L' ho fatto rimettere a posto, qui vicino c' è un signore che se la passa male, oggi glielo regalo». L' estremo bagno di folla, lei che non ne aveva mai avuti, risale al 25 aprile scorso quando Ciampi la saluta in piazza Duomo a Milano «a nome di tutti gli italiani», la piazza l' applaude e lei si commuove. L' ultima firma sotto un appello risale appena al 30 novembre: una richiesta a Ciampi da parte del Comitato pressione per le leggi paritarie. Nel 1997 subisce un' importante operazione chirurgica a Roma. Ovviamente all' ospedale «Sandro Pertini», fa sapere a tutti con soddisfatta, comprensibile civetteria. Paolo Conti LA VITAConti Paolo
Un brano di Erasmo da Rotterdam tratto da Il Lamento della Pace
Erasmo, La guerra e gli uomini di Chiesa
Gli uomini di Chiesa, che dovrebbero opporsi alle guerre, le sollecitano e prendono parte ad esse con entusiasmo. Un esempio è stato papa Giulio II, che ha mascherato le sue guerre dietro nobili immagini e “splendidi titoli” (come la “Lega santa” contro la Francia). Tutto ciò è in contraddizione con il messaggio cristiano, fondato sul “Padre nostro”, e con l’esempio dato da Cristo.
Erasmo, Il lamento della pace
Pochi anni fa, quando il mondo era travolto a prendere le armi da non so quale peste esiziale, alcuni araldi del Vangelo, frati Minori e Predicatori, dal sacro pulpito davano fiato ai corni di guerra e ancor piú infervoravano chi già propendeva per quella follia. In Inghilterra aizzavano contro i Francesi, in Francia animavano contro gli Inglesi, ovunque spronavano alla guerra. Alla pace non incitava nessuno tranne uno o due, a cui costò quasi la vita l’aver soltanto pronunciato il mio nome. Prelati consacrati scorrazzavano un po’ dovunque dimentichi della loro dignità e dei loro voti, e inasprivano con la loro opera il morbo universale, istigando ora il pontefice romano Giulio, ora i monarchi ad affrettare la guerra, quasi che non fossero già abbastanza folli per conto loro. Eppure questa patente pazzia noi l’avvolgemmo in splendidi titoli. A tal fine sono da noi distorte con somma impudenza – dovrei dire con sacrilegio – le leggi dei padri, gli scritti di uomini santi, le parole della Sacra Scrittura. Le cose sono giunte a tal punto che risulta sciocco e sacrilego pronunciarsi contro la guerra ed elogiare l’unica cosa elogiata dalla bocca di Cristo. Appare poco sollecito del bene del popolo e tiepido sostenitore del sovrano chi consiglia il massimo dei benefici e scoraggia dalla massima delle pestilenze.
Ormai i sacerdoti seguono perfino le armate, i vescovi le comandano, abbandonando le loro chiese per occuparsi degli affari di Bellona. Ormai la guerra produce addirittura sacerdoti, prelati, cardinali ai quali il titolo di legato al campo sembra onorifico e degno dei successori degli Apostoli. Per cui non fa meraviglia se hanno spirito marziale coloro che Marte ha generato. Per rendere poi il male insanabile, coprono un tale sacrilegio col sacro nome della religione. Sugli stendardi sventola la croce. Armigeri spietati e ingaggiati per poche monete a compiere macelli spaventosi innalzano l’insegna della croce, e simboleggia la guerra il solo simbolo che dalla guerra poteva dissuadere. Che hai a che fare con la croce, scellerato armigero? I tuoi sentimenti, i tuoi misfatti convenivano ai draghi, alle tigri, ai lupi. Quel simbolo appartiene a Colui che non combattendo ma morendo colse la vittoria, salvò e non distrusse; da lí soprattutto potevi imparare quali sono i tuoi nemici, se appena sei cristiano, e con quale tattica devi vincere. Tu innalzi l’insegna della salvezza mentre corri alla perdizione del fratello, e fai perire con la croce chi dalla croce fu salvato? Ma che! Dai sacri e adorabili misteri trascinati anch’essi per gli accampamenti, da queste somme raffigurazioni della concordia cristiana si corre alla mischia, si avventa il ferro spietato nelle viscere del fratello e sotto gli occhi di Cristo si dà spettacolo della piú scellerata delle azioni, la piú gradita ai cuori empi: se pure Cristo si degni di essere là. Colmo poi dell’assurdo, in entrambe le armate, in entrambi gli schieramenti brilla il segno della croce, in entrambe si celebra il sacrificio. Quale mostruosità è questa? La croce in conflitto con la croce, Cristo in guerra con Cristo. È un simbolo fatto per atterrire i nemici della cristianità: perché adesso combattono quello che adorano? Uomini degni non di quest’unica croce, ma della croce patibolare.
Ditemi, come il soldato può recitare il “Padre nostro” durante queste messe? Bocca insensibile, osi invocare il Padre mentre miri alla gola del tuo fratello? “Sia santificato il tuo nome”: come si potrebbe sfregiare il nome di Dio piú che con queste vostre risse? “Venga il tuo regno”: cosí preghi tu che su tanto sangue erigi la tua tirannide? “Sia fatta la tua volontà, come in cielo, cosí anche in terra”: Egli vuole la pace, tu prepari la guerra. “Il pane quotidiano” chiedi al Padre comune mentre abbruci le messi del fratello e preferisci che vadano perse anche per te piuttosto che giovare a lui? Infine come puoi pronunciare con la lingua le parole “e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” mentre ti lanci a un fratricidio? Scongiuri il rischio della tentazione mentre con tuo rischio getti nel rischio il fratello. “Dal male” chiedi di essere liberato mentre ti proponi di causare il massimo male al fratello?
Erasmo da Rotterdam, Il lamento della pace, Einaudi, Torino, 1990, pagg. 51-55
Gli uomini di Chiesa, che dovrebbero opporsi alle guerre, le sollecitano e prendono parte ad esse con entusiasmo. Un esempio è stato papa Giulio II, che ha mascherato le sue guerre dietro nobili immagini e “splendidi titoli” (come la “Lega santa” contro la Francia). Tutto ciò è in contraddizione con il messaggio cristiano, fondato sul “Padre nostro”, e con l’esempio dato da Cristo.
Erasmo, Il lamento della pace
Pochi anni fa, quando il mondo era travolto a prendere le armi da non so quale peste esiziale, alcuni araldi del Vangelo, frati Minori e Predicatori, dal sacro pulpito davano fiato ai corni di guerra e ancor piú infervoravano chi già propendeva per quella follia. In Inghilterra aizzavano contro i Francesi, in Francia animavano contro gli Inglesi, ovunque spronavano alla guerra. Alla pace non incitava nessuno tranne uno o due, a cui costò quasi la vita l’aver soltanto pronunciato il mio nome. Prelati consacrati scorrazzavano un po’ dovunque dimentichi della loro dignità e dei loro voti, e inasprivano con la loro opera il morbo universale, istigando ora il pontefice romano Giulio, ora i monarchi ad affrettare la guerra, quasi che non fossero già abbastanza folli per conto loro. Eppure questa patente pazzia noi l’avvolgemmo in splendidi titoli. A tal fine sono da noi distorte con somma impudenza – dovrei dire con sacrilegio – le leggi dei padri, gli scritti di uomini santi, le parole della Sacra Scrittura. Le cose sono giunte a tal punto che risulta sciocco e sacrilego pronunciarsi contro la guerra ed elogiare l’unica cosa elogiata dalla bocca di Cristo. Appare poco sollecito del bene del popolo e tiepido sostenitore del sovrano chi consiglia il massimo dei benefici e scoraggia dalla massima delle pestilenze.
Ormai i sacerdoti seguono perfino le armate, i vescovi le comandano, abbandonando le loro chiese per occuparsi degli affari di Bellona. Ormai la guerra produce addirittura sacerdoti, prelati, cardinali ai quali il titolo di legato al campo sembra onorifico e degno dei successori degli Apostoli. Per cui non fa meraviglia se hanno spirito marziale coloro che Marte ha generato. Per rendere poi il male insanabile, coprono un tale sacrilegio col sacro nome della religione. Sugli stendardi sventola la croce. Armigeri spietati e ingaggiati per poche monete a compiere macelli spaventosi innalzano l’insegna della croce, e simboleggia la guerra il solo simbolo che dalla guerra poteva dissuadere. Che hai a che fare con la croce, scellerato armigero? I tuoi sentimenti, i tuoi misfatti convenivano ai draghi, alle tigri, ai lupi. Quel simbolo appartiene a Colui che non combattendo ma morendo colse la vittoria, salvò e non distrusse; da lí soprattutto potevi imparare quali sono i tuoi nemici, se appena sei cristiano, e con quale tattica devi vincere. Tu innalzi l’insegna della salvezza mentre corri alla perdizione del fratello, e fai perire con la croce chi dalla croce fu salvato? Ma che! Dai sacri e adorabili misteri trascinati anch’essi per gli accampamenti, da queste somme raffigurazioni della concordia cristiana si corre alla mischia, si avventa il ferro spietato nelle viscere del fratello e sotto gli occhi di Cristo si dà spettacolo della piú scellerata delle azioni, la piú gradita ai cuori empi: se pure Cristo si degni di essere là. Colmo poi dell’assurdo, in entrambe le armate, in entrambi gli schieramenti brilla il segno della croce, in entrambe si celebra il sacrificio. Quale mostruosità è questa? La croce in conflitto con la croce, Cristo in guerra con Cristo. È un simbolo fatto per atterrire i nemici della cristianità: perché adesso combattono quello che adorano? Uomini degni non di quest’unica croce, ma della croce patibolare.
Ditemi, come il soldato può recitare il “Padre nostro” durante queste messe? Bocca insensibile, osi invocare il Padre mentre miri alla gola del tuo fratello? “Sia santificato il tuo nome”: come si potrebbe sfregiare il nome di Dio piú che con queste vostre risse? “Venga il tuo regno”: cosí preghi tu che su tanto sangue erigi la tua tirannide? “Sia fatta la tua volontà, come in cielo, cosí anche in terra”: Egli vuole la pace, tu prepari la guerra. “Il pane quotidiano” chiedi al Padre comune mentre abbruci le messi del fratello e preferisci che vadano perse anche per te piuttosto che giovare a lui? Infine come puoi pronunciare con la lingua le parole “e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” mentre ti lanci a un fratricidio? Scongiuri il rischio della tentazione mentre con tuo rischio getti nel rischio il fratello. “Dal male” chiedi di essere liberato mentre ti proponi di causare il massimo male al fratello?
Erasmo da Rotterdam, Il lamento della pace, Einaudi, Torino, 1990, pagg. 51-55
Iscriviti a:
Post (Atom)
































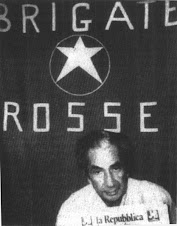























































































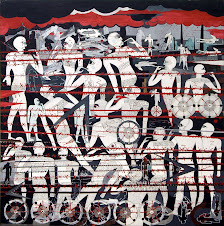






























































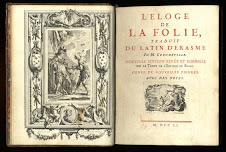



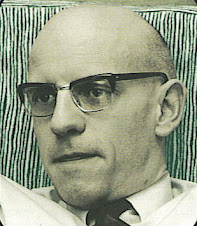














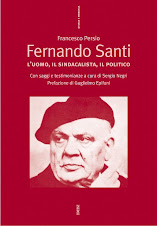





























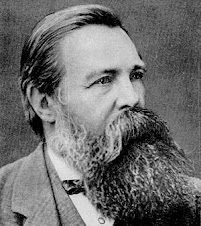













































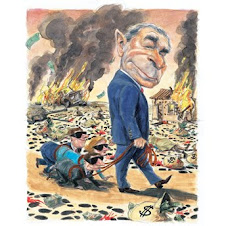

















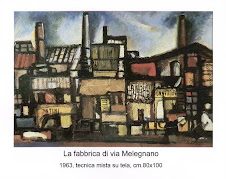














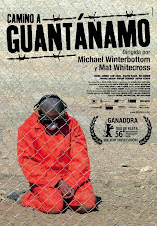





















































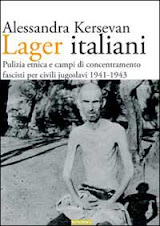



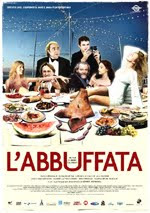















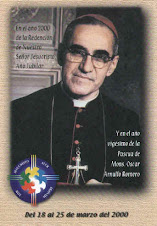










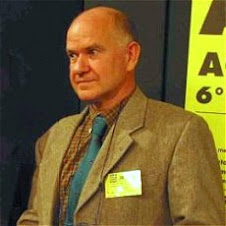




































































.jpg)
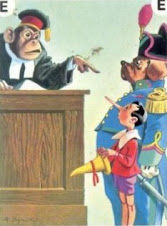







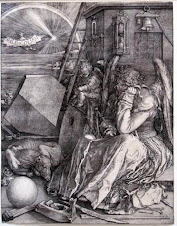


















.jpg)











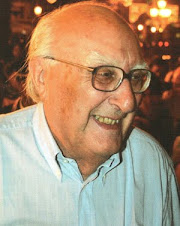









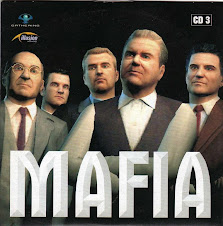















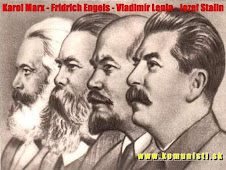



















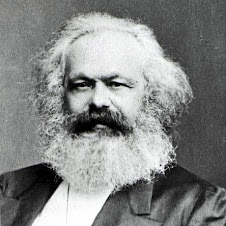























































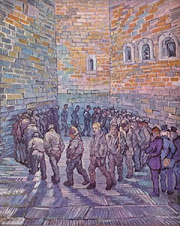
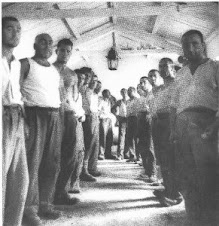




























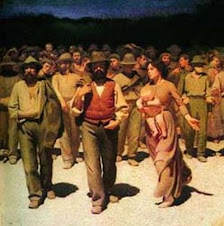













































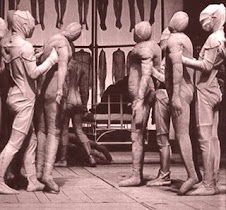


































































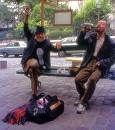



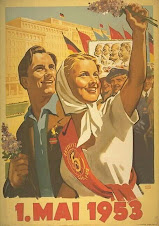
















































































































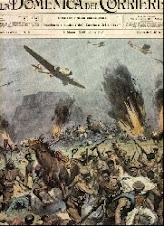






















































.jpg)