Le nuove piaghe della Chiesa - BARBARA SPINELLI
Questa domenica, in un rito celebrato a Novara, sarà proclamato beato Antonio Rosmini, uomo della Chiesa e del Risorgimento, filosofo cristiano e laico convinto, autore di un libro che nel 1849 fu messo all’indice perché indicava le Cinque Piaghe della Santa Chiesa e denunciava con dure parole l’immistione tra potere civile e religioso. Dicono che seppe della condanna mentre scriveva il Commento al Vangelo di Giovanni, e la notizia non lo turbò. Appena un anno prima, Pio IX voleva nominarlo segretario di Stato. «Rimase fermo al suo posto, nel testo non c’è traccia di quel che gli successe», mi dice Bruno Forte, il teologo e arcivescovo di Chieti che una volta ha detto di sé: «Sono un mendicante del cielo, come sognava Jacques Maritain. Sono un uomo che ha un orecchio incollato alla terra per coglierne le germinazioni nascoste e un orecchio in ascolto del cielo. Vivo la fatica di coniugare questi due ascolti». L’episodio di Rosmini che ascolta imperturbato la condanna e sembra avere anche lui due modi di ascoltare e di dire uno veemente che accusa, l’altro che umile si ritrae non semplifica l’esplorazione di quel che oggi è la Chiesa italiana. Ogni organizzazione umana sperimenta i dilemmi, ma nella Chiesa la complexio oppositorum è qualcosa di più: è condizione esistenziale, segreta molla di un durare millenario. Non è semplice, per un laico non vaticanista, raccontare una Chiesa che poche generazioni orsono condannò Rosmini e oggi lo beatifica, che negli stessi anni sospese a divinis padre Curci, fondatore della rivista gesuita Civiltà cattolica, e adesso venera chi prima difese il potere temporale e poi considerò provvidenziale perderlo. Quel che nel magistero è rigido domani può addolcirsi, quel che è ai margini diverrà forse centrale. È poi c’è, negli uomini di Chiesa, la questione eterna della parresia: fin dove avventurarsi, nell’esprimere liberamente ciò in cui si crede? Come coniugare due imperativi santi come verità e obbedienza? Per questo, nell’inchiesta breve cui mi accingo, non citerò tutti i rappresentanti della gerarchia con cui ho parlato. Ho preferito ascoltare la loro parola libera la parresia rispettando l’anonimato. Inoltre restringerò l’esplorazione, perché si può dire poco in qualche articolo. Parlerò dunque di come viene percepita, nella Chiesa, la crisi di un cattolicesimo che è alle prese, tuttora, con la scomparsa della Dc. Un cammino difficilissimo è cominciato da allora, complicato da una società ormai multireligiosa, multiculturale. La Chiesa che ho incontrato alla vigilia della beatificazione di Rosmini è incerta, in piena transizione. Parla molto, ma è anche afasica. Impossibile afferrarla come monolito: a dispetto degli sforzi compiuti da due Pontefici per renderla compatta, non c’è una Chiesa, una gerarchia, una voce che la rispecchi. Neppure sull’etica c’è un’opinione unica, nonostante la morale (i valori non negoziabili) sia vissuta come bussola dei rapporti con lo Stato nell’epoca intranquilla del dopo-Dc. Soprattutto, non c’è un’unica analisi dell’influenza cattolica sulla politica, e la società. L’unica cosa sicura è lo spazio enorme occupato dal tema della laicità: tutti ne sono tormentati, come non accadeva da decenni. Il fervore con cui se ne discute (per contestare un’ingerenza che si concentra oggi su etica della nascita, della famiglia, della morte, o per negare che di ingerenza si tratti) fa pensare ai torbidi dell’800, che in questi giorni saranno rievocati. La laicità, nessuno degli uomini di Chiesa sa dirmi quel che ne pensa, senza aggiungere aggettivi che la stemperano fino a invalidarla: la laicità deve esser sana, si precisa, citando un aggettivo che fu di Pio XII. Comunque non deve essere laicismo, questo male impetuosamente indicato ma di rado spiegato. Eppure la distinzione è semplice: a differenza della laicità, il laicismo non è un metodo ma un’ideologia, che santifica lo Stato e nega che il cristianesimo abbia dimensioni sociali oltre che private. Ma non è il laicismo che spiace alle gerarchie, bensì il metodo rigoroso nel separare Stato e Chiesa. Indispone l’indifferenza e la non confessionalità dello Stato democratico, tacciate ambedue di relativismo. In fondo, i critici della laicità hanno nostalgia di uno Stato etico, che somiglia pochissimo allo Stato minimo cui anelava Rosmini. Non stupisce l’alleanza che vede uniti in questa sete ideologica vescovi conservatori e teo-con di destra o sinistra. Son pochi, coloro che sanno spiegare il versetto di Matteo 22,21: quel «Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» che determina il rapporto cristianesimo-Stato nella storia d’Europa. «La formula è in realtà una scatola vuota», mi dice Gustavo Zagrebelsky, ex presidente della Corte Costituzionale: «perché nessuno può dire cosa si debba dare a Cesare e cosa alla Chiesa». Perché per secoli gli esegeti hanno ritenuto che la distinzione evangelica «implichi la superiorità del versante riservato a Dio (cioè alla Chiesa) su quello riservato a Cesare», scrive in un libro illuminante Giovanni Miccoli (In difesa della Fede - La Chiesa di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, Rizzoli). La vera questione irrisolta, spiega Miccoli, è chi abbia «la competenza delle competenze»: chi decida quel che spetta all’uno o all’altro. Bruno Forte preferisce parlare di «senso dello Stato», più che di laicità. Ma neanche questa parola chiarifica. Se la Chiesa antepone la sua verità sul diritto naturale e il bene morale alle leggi del Parlamento, è chiaro che sarà lei a dire come lo Stato deve legiferare su questioni etiche. Inevitabilmente ci sarà ingerenza anziché separazione costituzionale fra Stato e religione. L’uomo della Chiesa più discusso, nelle conversazioni che ho avuto, è Camillo Ruini: presidente della Conferenza episcopale fino al marzo scorso, ancor oggi presente nella Cei come vicario del Pontefice per la città di Roma. Per alcuni è la persona forte che ha pilotato la Chiesa nel dopo-Dc. Nominato da Giovanni Paolo II, Ruini appare vincente, grazie al peso abnorme che da anni gli attribuiscono i media: ogni suo detto ha l’audience riservata agli statisti. Lui stesso sembra compiacersene. Il 5 novembre, presentando a Milano due suoi libri, ha commentato: «È vero. Sono stato e sono un animale politico». E lo storico Galli della Loggia ha glossato: «La Chiesa ha sempre fatto politica. Non può non fare politica». Nel mio viaggio nella Chiesa ho avuto un'impressione ben più complessa. La Chiesa ha fatto sempre politica, ma sono molti oggi a esser convinti che la via debba essere un’altra, che di nuovo il magistero sia minacciato da una corruzione non finanziaria ma mentale: che il cattolicesimo farebbe bene a de-politicizzarsi radicalmente, come consigliato dallo studioso Jan Assmann che denuncia un’epoca dove i monoteismi non son più oppio ma dinamite dei popoli (Non avrai altro Dio, Mulino). Sono molti a desiderare che i sacerdoti parlino non politicamente, ma profeticamente. La Chiesa non si identifica oggi con Ruini: né quella sacerdotale, né quella dei fedeli. Chi non condivide la politicizzazione il più delle volte tace, ma il dissenso è diffuso (l’80 per cento dei vescovi disapprova il cardinale). «I costi pastorali della politica di Ruini sono stati enormi»: questa la frase ricorrente che sento. Alcuni certo lo difendono. Altri ricordano che sono i due ultimi Papi ad aver voluto l'arroccamento istituzionale. I più sperano nell’uscita dalla Cei del cardinale. Con speranza guardano a Bagnasco, che oggi guida la Cei: l’arcivescovo di Genova non osteggia il predecessore ma sta distanziandosi dalla politica. Si occupa più di attività pastorale, con il consenso di tanti. Tutto sta a vedere cosa sia vittoria e cosa sconfitta, per la Chiesa. E se il potere di Ruini generi autorevolezza. Il cardinale è convinto di sì, lo ha detto con qualche trionfalismo a Aldo Cazzullo, il 4 novembre sul Corriere della Sera. Che la sua strategia sia vincente sarebbe attestato dal referendum del 2005 sulla procreazione artificiale, quando prescrisse l’astensione perché mancasse il quorum, e vinse. Questo spiega il suo odierno appagamento: «Il nostro impegno è stato coronato dal successo, per giunta più largo del previsto. Penso, forse in modo un poco malizioso, che quel che più ha disturbato sia stato proprio questo (...) Constato che quando l’impegno non è coronato da successo, quando la Chiesa "perde" (...) tutto fila liscio. Nel caso contrario (...) riprendono vigore le croniche accuse di interventismo». Colpito, l’intervistatore constata la «riconquista quasi gramsciana dell’egemonia cattolica sulla società». Alla Compagnia di Gesù simili appagamenti sono sgraditi: ottenere il fallimento del referendum non fu vera vittoria, proprio perché fece credere nella perfetta coincidenza tra potere e autorevolezza. L’occasione non fu usata per dire pensieri forti, ma per sommare, furbescamente, l’astensionismo cattolico con il vasto astensionismo non confessionale. Alla rivista Il Regno raccolgo opinioni simili: la riconquista della Chiesa fu autoinganno, la quota di astensioni mobilitata da Ruini non superò il 10-12 per cento. Qui è uno dei costi della Chiesa politicizzata: qui una sua piaga. È la piaga di un magistero che perde autorità, proprio mentre accumula potere. Che si trasforma in lobby, scriveva lo storico Pietro Scoppola. Che si getta nella politica alla stregua d’un partito: mortale come tutti i partiti, episodicamente cruciale come tutti i partiti, dipendente dall’audience come tutti i partiti. Partecipe a pieno titolo della democrazia malata che pretende di combattere. (1-continua)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
































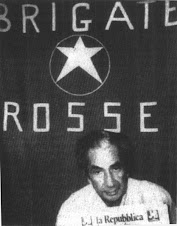























































































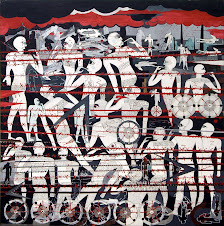






























































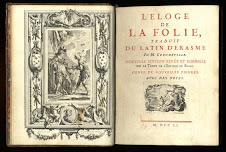



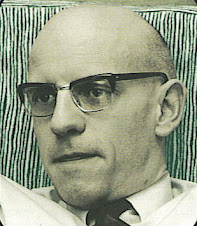














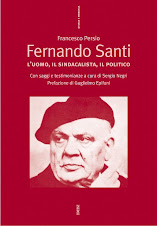





























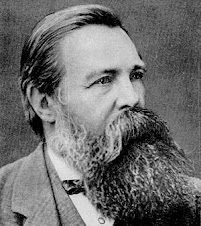













































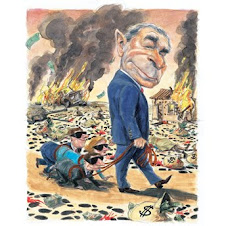

















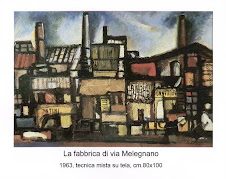














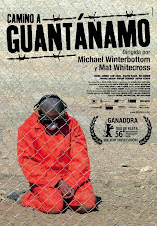





















































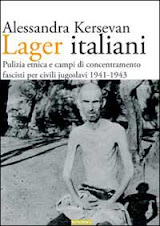



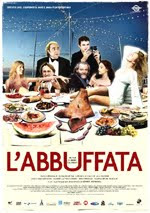















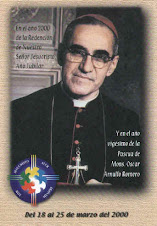










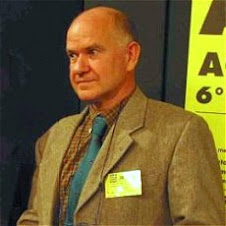




































































.jpg)
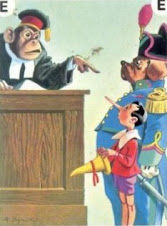







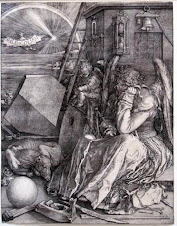


















.jpg)











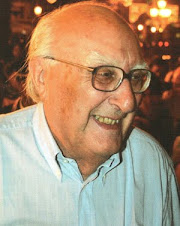









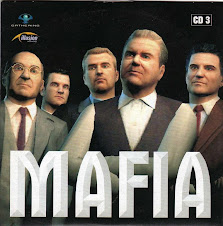















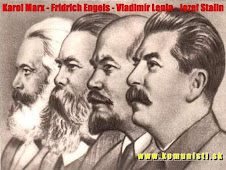



















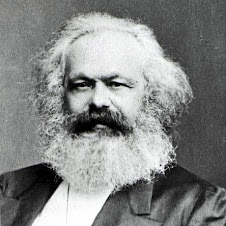























































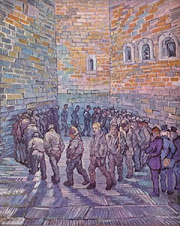
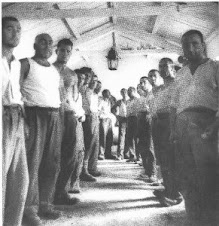




























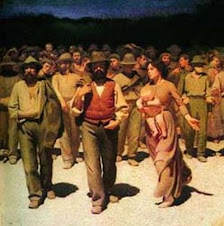













































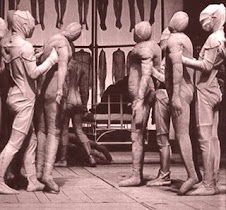


































































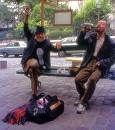



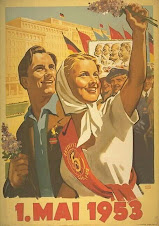
















































































































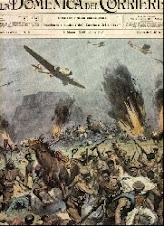






















































.jpg)















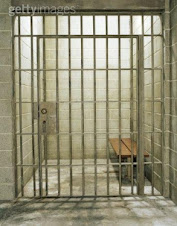







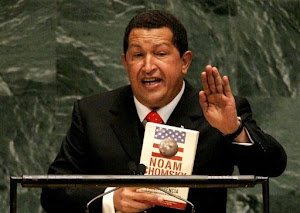







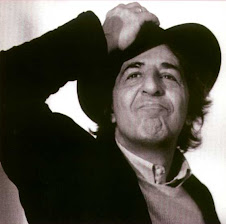










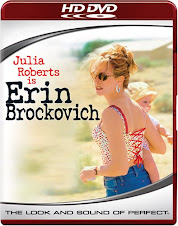






























Nessun commento:
Posta un commento